|
 |
 |
 |
 |
Perchè
un giovane oggi sceglie di farsi prete? Che cosa cerca nel ministero?
Che idee ha sul prete? Sono domande che vengono spontanee davanti ai
seminaristi o ai giovani. Queste domande e altre analoghe sono state
rivolte a Davide Arcangeli, diacono e non ancora prete, della diocesi di
Rimini. Davide Arcangeli è entrato in seminario dopo la laurea in
ingegneria e dopo essere stato per due anni Presidente Nazionale della
FUCI (Federazione Universitari Cattolici Italiani).
GIOIA E TIMORE
D.
Lei diventerà prete tra qualche mese. Con che animo si prepara a questo
passo?
R.
Vivo
oggi la grande gioia di sentire confermata dalla Chiesa e da Dio
un’intuizione che è nata in me circa dieci anni fa, all’età di 19 anni.
Era un periodo di crisi positiva, di una radicale interrogazione sulla
mia vita e sulla mia vocazione nel contesto del mio primo anno di
università. Qui il Signore mi fece conoscere più profondamente il suo
amore e mi donò anche una prima, germinale intuizione di cosa potesse
significare consacrarsi a lui. Negli anni questa intuizione si è molto
sviluppata e ha trovato diverse conferme, così che non posso non gioire
nella certezza di essere incamminato a compiere la sua volontà.
Da
un altro punto di vista, tuttavia, c’è in me anche molto timore, non
solo perché sento la mia inadeguatezza e debolezza, e, come Paolo, ho la
chiara percezione di custodire un tesoro in un vaso di creta (cf 2Cor
4,7), ma anche perché sono convinto che la mia identità sacerdotale sia
in realtà ancora un groviglio di convinzioni, aspirazioni, ideali e
progetti che attendono di essere messi alla prova e plasmati dalla vita.
Mi ritrovo nelle parole del profeta Geremia, che alle parole di
consacrazione di Dio risponde: «Ahimè, Signore Dio! Ecco io non so
parlare, perché sono giovane» (Ger 1,6). Qui non si tratta tanto della
giovane età, ma di quella inevitabile inesperienza di chi ha pregato e
servito Dio negli ambienti protetti del culto (Geremia era un sacerdote
di Israele), e ora deve, non senza contraddizioni, passare dalle forme
ben disegnate all’asprezza spigolosa della realtà. È chiaro che questa
obiezione non viene superata se non da un’incondizionata adesione alla
parola di Dio, l’unica che potrà far aderire alla vita anche il mio
parlare (cf Ger 1,9).
D.
Lei ha deciso di entrare in seminario da giovane, al termine di un
percorso di studio e di servizio alla Chiesa molto vivo e stimolante.
Che cosa l’ha portata a prendere questa decisione?
R.
Se
l’intuizione di cui ho parlato sopra era qualcosa di piuttosto generico
e suscettibile di evolvere in diverse direzioni, credo che sia stato
decisivo il mio impegno da laico di Azione Cattolica nel contesto che
stavo vivendo, quello dell’università, nel donarmi alcuni segni più
specifici della mia vocazione. Ricordo in particolare l’Assemblea
Federale della FUCI nel 2003 a Parma: molti sostenevano che questa
associazione stava per morire, venivamo da un anno molto difficile e io
non mi rassegnavo al ruolo di curatore fallimentare. Quel momento fu per
me rivelatore: il contatto con i ragazzi e con i loro persona li cammini
di fede mi fece penetrare più in profondità nel mistero della Chiesa,
paradossale unione di debolezza umana e potenza di Dio.
Compresi che non ero io il protagonista, ma Dio. Compresi che mi trovavo
dentro una realtà d’amore, in cui non spettava a me la gioia del
possesso, ma una gioia diversa eppure reale, la gioia di chi ascolta la
voce dello Sposo unito alla Sposa (cf Gv 3,29). È una gioia pasquale,
che scaturisce dal travaglio di un radicale e sofferto decentramento da
sé, dalle proprie attese e desideri umani. Intuivo così il mistero della
Chiesa da un’angolatura particolare e dentro il simbolo sponsale, e
questo, pur ancora dentro un’esperienza battesimale, mi ha avvicinato a
ciò che mi sembra essere l’essenza del ministero ordinato.
TRA SCOPERTA E PROFONDITÀ
D.
Quali sono gli elementi che hanno influito sulla sua scelta?
R.
Credo che l’esperienza spirituale di cui ho tentato di parlare si sia
poi ulteriormente approfondita, soprattutto nelle risonanze interiori
delle mie personali esperienze affettive. Qui ho sempre cercato di
integrare emozioni e affetti in una logica di donazione: questo, se da
una parte umanamente mi ha fatto sperimentare tutta la durezza di un
cammino di spoliazione, proprio attraverso di essa è scaturito il dono
di una maggiore comprensione del mistero della mia vocazione.
Ho
così progressivamente scoperto la mia inserzione personale nell’amore,
quella dell’evangelizzatore, colui che è chiamato ad annunciare la
salvezza, e mentre l’annuncia essa diviene presente per opera dello
Spirito: egli non è lo Sposo di Gerusalemme, è solo un annunciatore, ma
porta in sé i tratti dello Sposo, significati dalla bellezza dei suoi
piedi (cf Is 52,7).
Una
parola che mi ha sempre donato molte consolazioni è Romani 11,14-15:
«Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come
crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne
sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo
annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono
belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene!». Oggi
penso che tutto ciò di cui ho parlato in questa e nella precedente
risposta non sia altro che la mia personale e progressiva scoperta di
ciò che è contenuto in quella breve formulazione teologica che definisce
il prete in
persona Christi.
D.
Che cosa la attrae della vita del prete?
R.
Ricordo con particolare emozione quando alla FUCI stavamo preparando un
appuntamento nazionale per i responsabili dei gruppi, che si sarebbe poi
svolto a Firenze, sulle orme di La Pira e don Milani. Stavo leggendo un
passo di
Esperienze pastorali
di
don Milani, libro che rappresenta un primo tentativo, da parte di un
parroco, di riflessione sistematica sulla pastorale. Fui attirato
particolarmente da un passo in cui sembrava che don Milani avesse infuso
tutto quello in cui credeva, tutta l’essenza della sua vocazione
sacerdotale. Nel contesto di una pagina in cui se la prendeva con i
preti che inseguivano le mode del momento per attirare i ragazzi in
parrocchia, poi aggiungeva, con una sferzata improvvisa e rivelatrice
(riproduco qui il senso complessivo della frase e non le parole esatte,
non avendo il testo in mano): «Questi ragazzi, che vogliamo attirare con
mezzucci umani, in realtà sono dei martiri in potenza».
Questa espressione, martiri in potenza, mi è rimasta profondamente
impressa, e ancora oggi è per me come un concentrato dello sguardo con
cui un prete vede la realtà e le cose. Egli vede le potenzialità di
martirio, di dono totale a Dio attorno a sé e freme nello Spirito perché
questo possa compiersi. Cerca così di mettere in atto tutte le sue
risorse di sensibilità e intelligenza umana e tutta la sua personale
santificazione, nell’ascolto di quei segnali dello Spirito che tracciano
la storia di ogni persona, e cerca di collaborare perché tutte le
potenzialità umane e spirituali delle persone siano portate a
compimento.
La
presidenza dell’eucaristia, il ministero della Parola, la grazia
sacramentale della riconciliazione, l’esercizio della carità attiva e la
promozione della comunione ecclesiale, sono tutti strumenti perché
ciascuno arrivi alla misura della pienezza di Cristo (cf Ef 4,13). Ciò
che mi affascina nel prete è la capacità di guardare in profondità nelle
persone, come Gesù: di fronte al giovane che aveva molte ricchezze – ci
dice Marco - «fissatolo, lo amò» (Mc 10,21). E poi gli indicò la via
della sequela, che è la vera ricchezza del Vangelo. Ha saputo vedere
delle potenzialità nascoste in quel giovane narcisista che cercava la
lode del maestro, e al contempo ha saputo affidare alla potenza di Dio
colui che, agli occhi dei discepoli, sembrava condannato a rimanere
chiuso nel vicolo cieco delle proprie sicurezze umane.
TRA DIFFICOLTÀ E IMPEGNI
D.
Quali sono le difficoltà che ha incontrato dentro di lei e attorno a lei
nell’assumere questa decisione?
R.
Le
difficoltà sono state numerose e a tratti mi sono sembrate insuperabili.
Anzitutto l’opposizione dei miei genitori, impauriti da un cammino di
fede che sembrava preludere a qualcosa che era molto oltre le loro
visioni e aspettative su di me. Nel superamento di questa paura, che è
avvenuto solo grazie ad un cammino di fede iniziato dai miei genitori
nel contesto degli anni di seminario, ho riconosciuto non una mia
capacità a convertirli, ma solo la mano del Signore, che opera tutto ciò
che vuole. Soggettivamente questo è il segno più importante della bontà
agli occhi di Dio del cammino da me intrapreso.
Altre
difficoltà sono tutte relative a certi lati naturali del mio
temperamento, come una riservatezza e una tendenza più all’elaborazione
interiore che all’azione, che mi hanno procurato perplessità di fronte
alle incombenze relazionali del ministero pastorale. Ma il Signore mi ha
mostrato come avrei potuto far diventare punti di forza quegli stessi
che a me sembravano alcune volte punti deboli, e in questi anni ha
arricchito e trasformato il mio carattere, integrandolo al livello di
una stabilità affettiva: proprio questa stabilità progressivamente mi
rende capace di non temere le relazioni ma anzi di promuoverle.
Il
cammino del seminario e gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio hanno
avuto un ruolo fondamentale nel rendermi più cosciente di quel che il
Signore andava operando in me.
D.
Ma
in definitiva, c’era proprio bisogno che si facesse prete?
Non aveva davanti una vita soggettivamente buona, già impegnata nel
servizio alla Chiesa?
R.
Certamente, ma in questa frase modificherei solo l’avverbio
“soggettivamente”, in ”oggettivamente”. Mi spiego: ci sono sempre state
nella mia mente due convinzioni. La prima è il cercare “di più”, non
accontentarsi mai delle mete raggiunte, ma sempre ogni giorno rinnovare
dinamicamente la propria adesione alla volontà di Dio, considerando che
ogni volta che ci si ferma, in realtà si regredisce. La seconda è
l’essere convinto che Dio ha un progetto “per me”, che non può esaurirsi
in una bontà misurata esteriormente, secondo canoni oggettivi. Se la
vita del laico impegnato era già buona, e lo era oggettivamente, da un
punto di vista soggettivo, “per me”, era pronto qualcosa di ulteriore da
parte di Dio. Sarebbe lo stesso se dopo l’ordinazione mi accontentassi
di un adempimento di ciò che ritengo essere il canone oggettivo della
vita sacerdotale, risparmiandomi la fatica di cercare ogni giorno il mio
specifico e originale modo di incarnare l’identità sacerdotale.
I PERCHÉ DI UNA CRISI
D.
Quella della vita sacerdotale è una scelta ancora proponibile dunque ad
un giovane...
R.
Senza alcun dubbio, se c’è il desiderio di fare la volontà di Dio e non
la ricerca di una qualche compensazione personale, che si proietta nella
vita del ministero.
D.
Eppure la vocazione al sacerdozio oggi appare in crisi: sono pochissimi
- sempre meno - i giovani che scelgono questa strada per realizzare la
loro vita e per mettersi al servizio degli altri. Perchè?
R.
Alla
base della crisi di vocazioni sacerdotali che i Paesi occidentali
vivono, con alti e bassi, ormai da 50 anni, c’è una crisi della fede.
Credo che non avrei mai potuto intuire questa strada se il Signore non
mi avesse anche condotto attraverso un misterioso salto di fede, che è
quel dono di una fioritura nella parte più alta della persona, laddove i
sentimenti e i valori possono essere giudicati come veri e tutto è come
unificato da un amore superiore. Altrimenti non possiamo essere davvero
sicuri di nulla, dei sentimenti che proviamo e del nome che possiamo
dare ad essi, così come della reale bontà dei valori morali. In questa
insicurezza radicale, come potersi impegnare tutta la vita non solo
nella vocazione sacerdotale, ma in qualsiasi vocazione?
Credo che al fondo di tutte le difficoltà ci sia questo timore, che è
oggi una delle conseguenze della civiltà della tecnica e del mercato,
dove tutto è misurabile e contrattabile e non c’è più nulla di realmente
incondizionato. Ma in fondo questo male è antico quanto l’uomo e già ce
ne parlano i profeti dell’Antico Testamento: l’idolo non ha occhi per
vedere né orecchi per udire, perché è il prodotto dell’arte del fabbro.
Esso non può entrare in una vera relazione, incondizionata, gratuita,
perché è solo il prodotto rassicurante dei nostri sogni.
VERSO LA COMUNIONE DELLE DIVERSITÀ
D.
Qual è l’idea di prete che lei ha in mente? Che prete vorrebbe essere
domani?
R.
Vorrei crescere nell’umanità, fino ad arrivare a «rallegrarmi con quelli
che sono nella gioia e piangere con quelli che sono nel pianto» (Rm
12,15), fino a farmi «debole per i deboli, per guadagnare i deboli, fino
a farmi tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno» (Rm 9,22).
La trasmissione del Vangelo avviene infatti per una dinamica di
incarnazione, di cui il prete, per opera dello Spirito, è testimone in
prima linea: ma ciò non si realizza magicamente, in un sol colpo. C’è
una faticosa maturazione della propria umanità che viene pazientemente
modellata dallo Spirito. Io spero e desidero essere un prete che non si
sottrae a questo impulso dolce e insieme scarnificante.
Tutto coopera a questo fine: la solitudine del celibato, le durezze
dell’obbedienza al proprio vescovo, specie in certi passaggi, il
superamento di tentazioni sempre in agguato, come appoggiare la propria
vita su sicurezze materiali o anche relazionali, o come riporre la
propria realizzazione in un particolare ruolo o servizio. Vorrei essere
un prete la cui vita profuma della libertà del Vangelo, sempre aperto
alla novità che lo Spirito suscita ogni giorno nel suo ministero. Penso
che un prete così (e in realtà ne esistono!) non abbia bisogno di molte
parole per proporre ad un giovane l’ideale della vita sacerdotale. Se
qualcuno è chiamato dal Signore in questa strada, non potrà non essere
in qualche modo contagiato dalla sua testimonianza.
D.
Che cosa apprezza di più nei preti di oggi?
R.
La
varietà di carismi e tratti personali che modellano l’identità dei
preti. Si parla spesso di crisi di identità del ministero sacerdotale.
Certo vi è in molti anche una perdita di punti di riferimento e una
percezione della sostanziale incapacità di tenuta dell’attuale
spiritualità del ministero di fronte alle sfide del tempo presente. Ma
positivamente questa crisi può anche essere dovuta all’estrema varietà
di cammini spirituali: le persone arrivano al ministero in età adulta,
dopo esperienze di vita le più varie, ma soprattutto i cammini di fede
sono fortemente connotati da una libertà di ricerca soggettiva, che
porta ad esprimere maggiormente le sfumature personali e singolari
nell’incarnare l’identità del prete. Credo che questo sia il frutto
positivo della modernità nella spiritualità occidentale. Non possiamo
sottrarci a questa complessità, dobbiamo solo lavorare perché essa non
diventi fermento di divisione o di confusione, ma piuttosto sia
orientata ad una matura, armonica comunione dei diversi. Questo
significa anche sopportare il peso delle crisi che spesso i preti
attraversano, vedendole come passaggi per una più completa
appropriazione della spiritualità sacerdotale nella propria vita, e non
semplicemente come un pericolo da evitare.
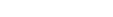 |