|
 |
 |
 |
 |
La concretezza del
cristianesimo
Come
e in quali occasioni è possibile incontrare Dio nel nostro presente ed
esserne affascinati, trasformati1?
Spesso, il rischio che corriamo è
quello di limitarci a parlare di Dio, come se noi potessimo sapere
qualcosa dell’eterno, invece di ascoltarlo là dove si fa presente. Solo
in quest’ultimo caso la nostra persona, ancora prima che le nostre
parole, diventa testimonianza credibile per i fratelli e le sorelle che
incontriamo lungo il cammino.
David Maria Turoldo sosteneva di
essere particolarmente impressionato dal silenzio di Gesù. La
maggior parte della sua vita, a Nazareth, è stata una vita di famiglia,
di lavoro e di silenzio. I discorsi e gli insegnamenti sono venuti dopo
e hanno occupato un tempo quantitativamente molto più ridotto.
È una realtà che riguarda anche noi.
Chi intende porsi alla scuola di Gesù non può ignorare questo aspetto
della sua esistenza. «Il più grande amore è nella più perfetta
imitazione. La più perfetta imitazione è imitare perfettamente Gesù, in
uno dei tre generi di vita di cui ci ha dato l’esempio: predicazione,
deserto, Nazareth»2. Nazareth è il luogo dell’ascolto e dell’ordinarietà.
La parola deve maturare in anni di
silenzio, per caricarsi di
vissuto e di significato profondo. E quando Gesù comincia a dire cose
più grandi del mondo, cerca le più umili immagini. «Il regno dei cieli è
simile a un poco di lievito che una donna impasta in un pugno di farina»
(Mt 13,33): poco lievito, una misura di farina, un’umile donna. E si
veda tutto il capitolo che presenta il cosiddetto discorso in parabole.
Il regno dei cieli è simile a un grano di senape. Il regno dei cieli è
simile a una perla nascosta in un campo; simile a un seme gettato in un
campo; simile a un campo seminato a grano e zizzania; simile a una rete
gettata in mare.
«Sempre immagini di cose concrete,
piccole e reali. Appunto, perché la verità è dentro le cose, non fuori:
il cristianesimo è concreto; e la grazia è la linfa della creazione, non
già una realtà separata dalla vita e dalla storia»3.
Ecco, allora, che non dobbiamo
cercare chissà dove. L’incontro con Dio comincia qui e ora,
nell’immediatezza della nostra realtà e della condizione in cui ci
troviamo. In primo luogo, allora, nella condizione della corporeità che
ne è parte essenziale e importante.
Il corpo oggi
Il modo di percepire e vivere la
corporeità è segnato da due diverse tendenze culturali4.
Cartesio, con la sua distinzione tra
res cogitans e res extensa ha declassato il corpo al rango
di oggetto da indagare, quasi una semplice appendice della sostanza
pensante la quale costituirebbe la nostra vera essenza. È molto
eloquente, al proposito, questo brano delle Meditazioni metafisiche
in cui la persona umana è identificata con una mente che è altro dal
corpo:
«Ma che cosa sono io? Una cosa che
pensa. E che cos’è una cosa che pensa? È una cosa che dubita, che
concepisce, che afferma, che nega, che vuole, che non vuole, che
immagina anche, e che sente […] e siccome ora so che non concepiamo i
corpi se non per mezzo della facoltà d’intendere che è in noi, e non è
per l’immaginazione, né per i sensi; e che non li conosciamo per il
fatto che li vediamo e li tocchiamo, ma solamente per il fatto che li
concepiamo per mezzo del pensiero, io conosco evidentemente che non v’è
nulla che mi sia più facile a conoscere del mio spirito»5.
In molte manifestazioni del trionfo
del corpo, che caratterizza la cultura contemporanea, si riscontra
ancora l’eredità del dualismo. Non bisogna trascurare il fatto che la
visione cartesiana del corpo, consentendo di indagarlo con distacco
tramite la ragione e l’osservazione scientifica, ha favorito il
progresso della medicina. C’è, però, un uso del corpo, un’esaltazione
della sua efficienza o spontaneità, che va tutto nella direzione della
manipolazione e della riduzione del corpo ad oggetto, un corpo
espropriato, ridotto a macchina per produrre risultati, siano essi di
tipo lavorativo, estetico, erotico o atletico.
L’invadenza e lo sfruttamento a fini
commerciali di tecniche e pratiche per abbellire, potenziare o anche
solo modificare la nostra corporeità (moda, fitness, cosmesi, chirurgia
estetica…) ne sono la dimostrazione. Lo stesso vale per il ricorso
esagerato, quasi ossessivo, alla farmacologia e alle prestazioni mediche
di fronte ad ogni sintomo o accenno di malessere, quasi a voler
esorcizzare e negare la fragilità che contraddistingue la nostra
umanità. Qui si esce dall’orizzonte della cura e della lotta alla
sofferenza, atteggiamenti legittimi e doverosi, per inseguire un sogno
di perfezione e di intangibilità del “corpo-macchina”, quasi si
trattasse della manutenzione di un’automobile da cui ottenere sempre il
massimo delle prestazioni. La punta più estrema di tutte queste tendenze
è data dagli interventi consentiti dalle ricerche sulla genetica, che
fin dal concepimento vogliono plasmare e controllare la realtà corporea.
Di segno diverso è la riflessione che
ha portato ad una riscoperta del corpo a partire dalla fenomenologia del
Novecento. Edmund Husserl, in Idee per una fenomenologia pura e per
una filosofia fenomenologica, parla del corpo come punto zero
di ogni orientamento. Tutte le posizioni nello spazio hanno una propria
collocazione rispetto al nostro punto di vista. Il nostro corpo, invece,
per noi è il punto zero, ovunque si trovi, esso è il “qui” in cui
situiamo noi stessi. In tal senso, Gabriel Marcel dice che il nostro
corpo è mediatore assoluto: tutto ciò che sperimentiamo e
proviamo, tutto il nostro rapporto con il mondo passa attraverso il
corpo, è mediato dal corpo. Le nostre stesse idee sono mediate dal
corpo. Il corpo è vissuto dall’interno come me stesso. Non è la mano che
prende oggetti, ma io prendo. Non è l’occhio che vede, ma io vedo. Non è
il corpo che sente, ma io sento.
È molto appropriato un esempio di
Umberto Galimberti: noi possiamo avere un’idea concettualmente perfetta
del nuoto, ma non sapremo mai veramente cos’è fino a che il nostro corpo
non sperimenta l’immersione nell’acqua6. Non basta il concetto di nuoto
per saper nuotare, bisogna stare nell’acqua. Solo abitandolo con il
corpo noi possiamo conoscere il mondo. Noi non possiamo distinguerci dal
nostro corpo, perché esso è apertura originaria al mondo. Siamo
situati nel mondo con il nostro corpo il quale ci consente di
intervenire nel mondo, di trasformarlo. Allo stesso tempo, è attraverso
il corpo che noi attuiamo noi stessi, le nostre scelte e ci poniamo in
relazione con gli altri comunicando, dialogando, amando.
Pensiamo proprio all’amore tra uomo e
donna. Che amore ci può essere senza la fisicità? Senza il volto
dell’altro, senza le carezze, senza i baci, senza la sessualità…
Non solo il corpo è lo strumento
fisico dell’azione umana, ma ne è anche il supporto simbolico e
comunicativo. La comunicazione è caratterizzata dallo spazio in cui ci
troviamo, dalla nostra posizione reciproca e dai segnali corporei che ci
inviamo. Senza il corpo, cioè senza la forma, le dimensioni, lo spazio
occupato dal corpo, non ci sarebbe relazione e neppure possibilità di
esperienza. Così come risiede nel corpo il potenziale energetico che fa
dell’uomo un essere capace di produrre, di creare, di trasformare la
realtà a partire dalla mancanza.
Un altro contributo determinante per
la riscoperta del corpo è venuto dal movimento femminista che ne ha
evidenziato la realtà di corpo sessuato. Il corpo non solo non è un
supporto strumentale per la mente, ma esso è sempre segnato dalla sua
natura sessuata, maschile e femminile, che nella cultura si traduce in
tutti quei tratti che portano alla distinzione di genere (cioè, che cosa
vuol dire essere maschio e che cosa vuol dire essere femmina nella vita
sociale). Non esiste, dunque, una sola, ma almeno due fondamentali
esperienze del corpo vissuto con le proprie specificità: quella maschile
e quella femminile.
Alla luce di queste brevi
osservazioni, diventa per noi prioritario evitare che il nostro corpo
sia monopolizzato dai messaggi e dalle pratiche di carattere
medico-scientifico, estetico, sportivo, commerciale… provenienti dalla
società i quali tendono a indirizzarne la gestione in una direzione
piuttosto che in un’altra. Finiremmo così con l’essere espropriati di un
aspetto fondamentale di noi stessi e della nostra identità per cadere in
qualche forma di controllo, perché sarebbero altri a dirci come gestire
il corpo convincendoci che sia il nostro bene. Quello che occorre è
piuttosto la consapevolezza del nostro corpo; delle sue potenzialità e
dei suoi limiti, del suo benessere e del suo malessere, nonché dei
segnali che ci invia. Se le scelte riguardanti il corpo passano per la
nostra consapevolezza e non sono indotte dagli impulsi che ci bombardano
dall’esterno, ne guadagnano la nostra autonomia e la nostra libertà.
La storia d’amore tra
Dio e il corpo umano
Riassumendo le considerazioni
precedenti, noi siamo un corpo. È nel corpo che si concentrano le nostre
sensazioni. Viviamo come corpo. Entriamo in relazione gli uni con gli
altri con il corpo. I sentimenti si manifestano con il corpo.
La fede ci permette di vedere il
corpo come occasione di condivisione, di comunione. L’incontro
fisico, concreto con l’altro è il fondamento di ogni autentica
relazione, il fondamento dell’amore. Se no, c’è sempre distanza,
estraneità. Non a caso la realtà di Dio può essere espressa tramite una
simbologia corporea e perciò la corporeità – se vissuta come
condivisione – può favorire il nostro incontro con il divino. Anzi, è
Dio stesso che si fa presente a noi nella corporeità.
Il monaco camaldolese Benedetto
Calati, per esempio, diceva che Dio è un bacio, rifacendosi ai primi
nove sermoni di san Bernardo di commento al Cantico dei cantici,
dedicati al bacio. Tutto si spiega col bacio. La vita trinitaria è un
bacio: il Padre bacia il Figlio e lo Spirito santo. L’unione ipostatica
è un bacio. La natura divina come la natura umana. E la vita dell’uomo e
della donna è un bacio7. Questo contatto puramente fisico è il segno
della tenerezza, dell’incontro amorevole e rispettoso con l’altro.
Baciarsi è condividere la più stretta intimità.
Nella Parola di Dio, i segni sono
inequivocabili e aprono un orizzonte completamente nuovo. «Il
cristianesimo non è una dottrina, non è una teoria di ciò che è stato e
sarà dell’anima umana, ma una descrizione di un evento reale della vita
dell’uomo»8. Vorrei ripercorrere ora tre momenti di questo evento in cui
si delinea la storia del rapporto di Dio con il corpo umano, un rapporto
all’insegna della condivisione. È una sorta di trittico che ha al centro
la guarigione del sordomuto. Qui riporto il racconto di Marco.
Di ritorno dal territorio di Tiro,
passando per Sidone, venne al mare di Galilea, in pieno territorio della
Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano.
Allora egli, presolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita
nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua; quindi, alzati gli
occhi al cielo, sospirò e disse: «Effathà!», cioè «Apriti!». E subito
gli si aprirono gli occhi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava
correttamente (Mc
7,31-35).
-
Dio condivide il corpo
dell’uomo
Verbum caro factum est. Il Verbo si
fece carne (Gv 1,14). Dio
non è un alieno chiuso in cieli inaccessibili. Ama tutto l’uomo, al
punto da fare propria la sua corporeità. Gesù è un uomo, con un corpo
umano. Ma, se Gesù fosse soltanto un uomo, noi saremmo ancora
soli, abbandonati a noi stessi. Dio incontra l’uomo scegliendo di essere
un corpo. Questo è il Natale. È un Dio di uomini, perché lega la
divinità all’umanità.
-
Dio condivide con il
corpo
Allora egli, presolo in disparte,
lontano dalla folla, gli mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli
toccò la lingua. (Mc
7,33). Quando Gesù guarisce il sordomuto, non si pone su un piedistallo
facendo una specie di magia. Invece, entra in relazione con lui, lo
tocca là dove è localizzato il suo male. È come se, attraverso il
contatto fisico, aprisse un canale. La condivisione non è né
un’elemosina, né una forma di assistenza. È entrare nella vita
dell’altro con la propria vita e insieme superare il negativo, il male.
L’attenzione a tutta la persona comincia dalla dimensione fisica.
- Dio condivide la
propria vita con il corpo dell’uomo
Gesù disse: «Perché siete turbati, e
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa come vedete che io ho».
(Lc 24,38-39). Da Dio all’uomo,
dall’uomo a Dio. La condivisione è totale: Dio si è fatto come noi per
farci come lui. Tutto l’uomo diventa eterno ed entra in una vita nuova,
corpo compreso: la Risurrezione di Gesù è il segno della nostra. Dio ci
ama come siamo, cioè corporei, perciò anche il nostro corpo condivide la
vita di Dio, la vita eterna. Riguardo a Dio, la presenza del Risorto
rivela che non accetta la morte, non sopporta che i morti restino morti.
Dio non è morte eterna, ma vita eterna. Riguardo alla storia umana, la
presenza del Risorto significa la certezza incrollabile della vittoria
di Dio su tutte le forze nemiche, del bene sul male, della verità sulla
menzogna, dell’amore sull’odio, della mitezza sulla prepotenza, della
gioia sul dolore, della verità sulla menzogna…
Approfondire la dimensione del
contatto, dell’incontro con il corpo in cui c’è fiducia reciproca,
scambio, aiuto, ci pone in questa scia di condivisione. Essa suscita un
nuovo stile di vita, alternativo, controcorrente, più giusto e fraterno.
Un seme di vita eterna
Il Natale e la Pasqua sono il segno
del progetto di amore che Dio ha sulla persona umana, su tutto l’uomo
nella sua completezza, il quale è corporeità e spiritualità senza
dualismo. Nella luce, in Dio, ci sono sia le radici della materia del
nostro corpo, sia il suo destino finale. Lo ha spiegato con poesia e
meravigliosa chiarezza padre Giovanni Vannucci in una meditazione alle
monache benedettine di Pontasserchio, durante l’Avvento del 1973:
«Il nostro compito di uomini consiste
nel trasfigurare la nostra materia, il nostro corpo. Un giorno deporremo
la parte esteriore del nostro corpo, che non è stata per niente una
prigione, ma che ci ha permesso di maturare e di lasciare alla terra
quella essenza di vita, di bene, di amore, di libertà che abbiamo saputo
conquistare qui sulla terra. Deporremo il nostro piccolo fardello in
seno alla madre terra, ma vi deporremo, impressi nella materia del
nostro corpo, anche tutto il bene, la grandezza, la nobiltà, le
vibrazioni di vita che abbiamo conquistato qui sulla terra. La parte
eterna del nostro essere vola a Dio e si immerge nell’estasi
indefettibile di coloro che godono la visione di Dio. Il nostro corpo
non sarà come delle catene che lasciamo qui, sfuggendo dalla prigione,
no. È un seme che verrà raccolto e continuato dagli altri»9.
Nulla di noi va perso in Dio, tutto
il buono risorge e trova compimento. È Maria che ci mostra il compimento
del disegno di Dio: salvata dalle forze di male e di morte del peccato,
chiamata a condividere con il corpo la vita divina. Il nostro corpo è un
seme di vita eterna.
Ho evidenziato la guarigione del
sordomuto come fulcro della storia di condivisione tra Dio e l’uomo,
perché è la storia di come possiamo incontrare Dio nel corpo. Nella mia
carne, nella carne di ogni persona che incontro, c’è la Sua impronta.
L’ascolto di questa Parola mi fa sentire amato da Dio e così mi fa
cominciare ad amarlo. Un amore che è condivisione e inizia dal contatto,
dalla relazione fisica che sono la forma con cui esso si esprime e si
concretizza. Una condivisione disincarnata, fatta solo di buoni
sentimenti, è fittizia. Anche la condivisione inizia dal corpo,
cioè dall’incontro fisico, tangibile, con l’altro. Se no, c’è sempre
distanza, estraneità.
Esaltiamo talmente tanto il corpo e
lo mercifichiamo, quanto poco siamo capaci di condividere con il corpo.
I gesti di Gesù nei confronti del sordomuto attribuiscono tutto un nuovo
significato ai gesti con cui ci facciamo prossimi agli altri e ci
sospingono verso direzioni inesplorate: imparare a toccarsi fidandosi
reciprocamente, trasmettere tenerezza, comunicare con il contatto,
ascoltare il proprio corpo e quello altrui, apprendere trattamenti e
forme di terapia con cui si può contribuire al benessere delle persone.
Il cuore umano è uno scrigno che
nessuno strumento di scasso riesce a forzare con la violenza, si
dischiude e cede i suoi tesori solo accarezzandolo.
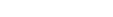 |