|
n. 10
ottobre 2009

Altri articoli
disponibili
|
|
 English
English
Formare se stessi all’arte dell’esistenza
di ANNA BISSI
|
|
 |
 |
 |
 |
Nel
racconto della creazione (Gen 2,7) l’uomo sta nelle mani di Dio, che lo
plasma, come l’argilla in quelle del vasaio. Poi Dio appoggia il volto
sull’opera delle sue mani e vi alita un soffio di vita: quella creatura,
fragile come la creta, partecipa così della respirazione divina e
diventa nefesh, un vivente.
Queste parole della
Scrittura ci sono così familiari che rischiamo di non coglierne la
profondità e la bellezza. Si tratta di poche righe, più dense di un vero
e proprio trattato di antropologia e di teologia. Esse mettono in
risalto la fragilità dell’uomo, quella debolezza strutturale sulle cui
conseguenze la Bibbia c’introdurrà nel capitolo successivo,
raccontandoci l’episodio del peccato originale. Nello stesso tempo ci
rivela quale sia uno dei compiti per eccellenza di ogni creatura:
proprio perché plasmata come un vaso, essa è fatta per racchiudere, per
accogliere qualcosa. Subito dopo, scopriamo quale sia questo
"contenuto", rispetto al quale l’essere umano è modellato come
"contenitore": è il soffio di Dio.
Un suggerimento ulteriore ci viene dall’esegesi:
troviamo in questo testo lo stesso termine utilizzato da Geremia per
indicare la respirazione di una donna che partorisce
(cf Ger 4,31). Dio, quindi, soffia sull’uomo come una
donna soffia, geme, per far nascere il suo bambino. Con quest’immagine
semplice e suggestiva veniamo in contatto con il mistero dell’uomo,
essere plasmato per accogliere il respiro di Dio, la sua Vita.
È questo il dono prezioso rispetto al quale l’essere umano è stato
pensato come un "contenitore", dono che deve ricevere e impregnare tutta
la sua esistenza.
Chiamati a diventare con-creatori
Quest’accoglienza di una realtà infinitamente
preziosa comporta anche un impegno, una responsabilità. In
quanto essere creato, l’uomo è chiamato a diventare concreatore,
esercitando non solo sulla creazione, ma anche su di sé quel sano
dominio che deve orientare tutto l’esistente, in modo ordinato e
armonico, verso un fine: la comunione con gli altri e con Dio. Il suo
ruolo di custode del giardino (Gen 2,15), anche di quello
interiore, e il compito di dare un nome (Gen 2,19) alla realtà
che lo circonda esprimono questa richiesta da parte di Dio di una
collaborazione, di una partecipazione alla crescita di quanto è stato
creato e, di conseguenza, allo sviluppo del dono ricevuto dall’uomo.
Con il peccato questa cooperazione s’infrange
parzialmente, ma grazie alla Pasqua del Cristo noi veniamo di nuovo
pienamente inseriti in questa Vita divina. Il Battesimo, che in essa ci
introduce, ci affida anche la responsabilità di lasciarcene sempre più
permeare, di fare in modo che essa penetri intimamente tutte le fibre
del nostro essere.
Formare se stessi
Il compito di educare se stessi, dunque, non è una
realtà a se stante rispetto all’esperienza di fede e alla vocazione
personale. Esso risponde invece alle esigenze insite nel Battesimo e, di
conseguenza, nella vocazione religiosa. Si tratta, infatti, di avere
cura e di far crescere un dono prezioso, che ci è stato affidato. Questo
compito deve essere svolto con impegno e serietà, perché ciò che deve
maturare e svilupparsi è molto di più di una semplice dimensione della
nostra vita, ma riguarda invece la globalità dell’esistenza.
La formazione di un religioso, infatti, non può
interessare solo un ambito della personalità: la conoscenza, la cultura,
lo sviluppo intellettuale o morale, la competenza. Essa non può fare a
meno di coinvolgere la vita intera, in tutte le sue dimensioni.
Questa vita è una realtà dinamica, simile a un germe bisognoso di
essere custodito e coltivato, per svilupparsi sempre più.
Parlare di dinamismo, quindi, significa far
riferimento a un orientamento, una direzione verso la quale convogliare
il movimento dello sviluppo. Per educare se stessi è dunque
indispensabile definire la finalità di questo percorso
formativo. Esso, infatti, può essere concepito in termini diversi.
Qualcuno può interpretarlo come un accrescimento del proprio Io:
in tal caso l’interesse della persona è orientato verso tutto ciò che
può procurarle una gratificazione a livello psicologico, per esempio il
potere, il successo, l’ammirazione. Se però noi ci riconosciamo come
creature abitate dalla Vita di Dio, allora anche il fine della
nostra formazione personale dovrà avere un nesso, un legame con questa
Vita e il formarsi dovrà trovare uno scopo capace di trascendere la
soddisfazione del singolo. Il modo di pensare se stessi, quindi,
definisce anche il fine del percorso educativo e interpella in merito al
suo orientamento. Diventa così doverosa la domanda su che cosa riteniamo
centrale, fondamentale in questo percorso: il nostro Io, con le sue
potenzialità di sviluppo, o la crescita di quel dono ricevuto nel
Battesimo, che è la Vita di Dio da Lui comunicata nel sacramento?
Interrogarsi
Educare se stessi all’arte dell’esistenza significa
quindi interrogarsi, esplicitamente o in forma indiretta, rispetto a ciò
che personalmente consideriamo come esistenza. Si tratta di una domanda
fondamentale per ogni essere umano e quindi anche per noi religiose, le
cui risposte teoriche possono essere perfette, ma anche difensive, se
non ci lasciamo interpellare dalla concretezza del quotidiano,
domandandoci ciò che per noi, ogni giorno, significa vivere.
La Vita in Dio non può essere certo definita dalle
nostre povere parole umane; nel vocabolario comune troviamo però dei
termini capaci di evocare qualcosa di tale mistero: comunione, dono di
sé, accoglienza, relazione, ma anche dinamicità e movimento, purché non
vissuti come fini a se stessi, ma inseriti in un continuo scambio
d’amore. Formare se stessi all’arte del vivere implica, di conseguenza,
il verificare se nella nostra esistenza può trovare spazio e può
crescere ciò che caratterizza la Vita di Dio. Spesso ci sentiamo
rimproverare si è imborghesita.
Non sono però solo le persone distanti dalla Chiesa
ad affermarlo: più volte, infatti, lo stesso Papa Benedetto XVI lo ha
ripetuto, invitandoci così a riflettere e a convertirci. Uno dei tratti
salienti di tale imborghesimento ha forse dei profondi nessi con il tema
della formazione, perché si può esprimere come perdita della
dinamicità dell’esistenza. Spesso, infatti, più che vivere
noi tendiamo a sopravvivere, a proteggere ciò che siamo o abbiamo. Le
nostre resistenze al cambiamento si configurano sovente come dei no
pronunciati nei confronti di una Vita che non è accolta e ciò in nome
delle nostre paure, della difesa del benessere personale, della
difficoltà a dilatare il cuore, sintonizzandolo sulla lunghezza d’onda
delle necessità della Chiesa e del mondo.
Far crescere la Vita
Il rischio è che questo sia vero a livello personale
e istituzionale. Non sono solo i singoli individui, infatti, che
possono, anche senza volerlo, rifiutarsi di accogliere e far crescere la
Vita. Spesso vengono a mancare gli stimoli da parte dell’Istituto che,
arroccato sulle sue posizioni finalizzate alla sopravvivenza, non
stimola le comunità o i singoli membri a sviluppare dinamiche di
collaborazione, di scambio o a riflettere e interrogarsi su come
accogliere e far crescere quella "Vita abbondante" che ci è promessa nel
Vangelo.
L’autoformazione, soprattutto all’interno di una
comunità religiosa, non si configura come conseguenza di un’iniziativa
individuale, ma dà frutto solo se è pensata in modo organico e
interpersonale. Educare se stessi non può mai essere un dovere imposto
dall’alto e subìto come un peso schiacciante, ma nemmeno un’esperienza
frammentaria, in cui ogni singolo individuo cerca di sviluppare un
aspetto della sua personalità. Il formarsi è un’esperienza coerente e
strutturata, orientata da un fine, capace di prendere in considerazione
non solo gli interessi e gli scopi del singolo, ma anche gli obiettivi
della comunità all’interno della quale si è inseriti. Il sovrapporsi di
finalità, diverse nelle intenzioni dei membri rispetto alle decisioni
della comunità o dei superiori, può creare tensioni pesanti da portare.
Pensiamo, per esempio, a tutte quelle situazioni in
cui manca la necessaria chiarezza rispetto all’importanza attribuita
alla preparazione professionale di un componente della fraternità; tale
ambivalenza finisce a volte per scontrarsi con la necessità inderogabile
per gli altri di mantenere in piedi una struttura. Il "formarsi" diventa
allora una scelta di cui colpevolizzare l’altro o un diritto da
rivendicare e non una dimensione della crescita individuale, da
integrare all’interno di un progetto di vita attento a leggere nei segni
dei tempi, nei talenti personali e comunitari, nel carisma ricevuto,
negli orientamenti tratti dal Vangelo, le indicazioni per le scelte
particolari e collettive.
I voti: alta scuola di formazione
L’atto formativo necessita, come abbiamo messo in
risalto, di modi capaci di guidare un percorso di crescita; esso
ha bisogno però anche di strumenti. La vita religiosa, con la sua
struttura e le sue esigenze, prima fra tutte la ricerca del
Signore, ne mette a disposizione molti. I voti, per esempio,
possono diventare per noi dei mezzi privilegiati, che ci educano
all’arte del vivere. Molti sono gli ambiti della nostra esistenza in cui
essi ci fanno crescere. Fra le diverse possibilità, mi piace mettere in
risalto una dimensione profondamente legata al mistero della vita, quale
lo abbiamo descritto all’inizio. I voti, infatti, possono rappresentare
per noi dei mezzi per accogliere la Vita, quel respiro di Dio che ci
abita. Diventare recettività rispetto ai doni di Dio, mettendo da parte
la possessività del nostro modo di amare, il bisogno di trattenere e
gestire autonomamente l’esistenza: ecco l’alta scuola di formazione che
ci presenta la vita consacrata attraverso questi tre mezzi, capaci di
farci crescere e indirizzarci verso la piena maturità di Cristo (Ef
4,13).
Anna Bissi
Psicoterapeuta
Basilica sant’Andrea - p.za Roma 35
13100 Vercelli
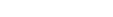 |
|
|
|