|
n. 10
ottobre 2010

Altri articoli
disponibili
|
|
 English
English
"Digitus Dei,
digitus hominis"
di LILIA
SEBASTIANI
|
|
 |
 |
 |
 |
Talvolta
l’artista può vedere più lontano di un teologo o parlarci più da
vicino: il linguaggio simbolico dell’immagine è multi direzionale e
ha possibilità che restano precluse al linguaggio della teologia,
inevitabilmente concettuale e a senso unico. Così è per noi quasi
impossibile riflettere sulla creazione dell’uomo senza che si presenti
agli occhi della mente l’immagine indimenticabile che è nell’affresco
di Michelangelo nella Cappella Sistina: Dio chiama all’esistenza
l’essere umano già formato, ma non ancora interamente vitale, la sua
mano per mezzo del dito indice si muove a incontrare la mano dell’uomo.
Il dito della potenza di Dio incontra, arriva quasi a sfiorare (ma senza
toccarlo) il dito di Adamo, trasmettendogli in tal modo la forza divina
necessaria alla vita, e Adamo si solleva lentamente dalla terra
protendendosi verso il suo creatore, come se si risvegliasse dal sonno…
Il gesto di creazione, che evoca una sinergia
divino-umana in fieri,è un segno complesso che permette una
lettura su piani diversi. Il dito di Dio - l’indice, il dito dell’intenzione
e dell’autorità - e il dito umano corrispondente si avvicinano
indefinitamente, ma non si toccano: le due sfere rimangono distinte,
anche nella comunione. L’essere umano è chiamato alla comunione con
Dio e nel riconoscere la chiamata di Dio si risveglia dal sonno, cioè
acquisisce la consapevolezza di sé, diventa soggetto,acquista autonomia
in un contesto di chiamata-risposta.
Tra parentesi ricordiamo che in questo affresco gli
angeli che attorniano come una nuvola la figura di Dio danno luogo, nel
loro insieme, a una sagoma che ricorda molto un cervello umano in
sezione sagittale: un richiamo simbolico all’esercizio dell’intelligenza?
Non è assolutamente dimostrabile che questo fatto sia ricercato dall’artista;
può essere frutto del caso, ma è di indubbia suggestione e ha
alimentato molte speculazioni simboliche ed esoteriche. È noto del
resto che Michelangelo ebbe rapporti piuttosto stretti con intellettuali
umanisti quali Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, cioè i massimi
esponenti di quell’Accademia Platonica fiorentina
che ricercava una possibile conciliazione tra
pensiero cristiano e neoplatonismo.
La mano
di Dio
Nel linguaggio antropomorfico della Bibbia, come nell’Oriente
antico extrabiblico, è menzionata spesso la mano di Dio
(complessivamente circa trecento volte); e anche il suo braccio, e anche
il suo dito. Alla mentalità cristiana moderna questa modalità nel
parlare di Dio può ispirare anche un certo disagio, può sembrare
troppo umano, ingenuo o al limite dell’irriverenza; ma nelle
intenzioni dell’autore sacro intende sottolineare il carattere
personale di Dio e l’intensità del suo coinvolgimento nella storia e
nelle vicende degli uomini. Il simbolismo della mano sembra l’espressione
più felice di quel movimento in cui la sfera di Dio e quella dell’uomo
s’incontrano.
Alcuni testi biblici parlano della mano di Dio come
simbolo della sua potenza nella creazione e provvidenza, e nella
liberazione d’Israele: "Il cielo è il mio trono, la terra lo
sgabello dei miei piedi [...]. Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed
esse sono mie" (Is 66,1-2). "Le tue mani mi hanno plasmato e
mi hanno fatto integro in ogni parte" (Gb 10,8). "Tu apri la
tua mano, si saziano di beni " (Sal 104,28). Parlando della mano si
allude abitualmente alla destra, che esprime l’autorità e la potenza
di Dio, quindi per estensione la sua gloria stessa. Questa gloria è
ambivalente negli interventi straordinari di Dio, dice protezione e
minaccia: "La tua destra, Signore, terribile per la potenza, la tua
destra, Signore, annienta il nemico…" (Es 15,6).
La mano è anche qualcosa che appoggia e conforta;
veicola la stessa forza di Dio sugli uomini da lui destinati a una
missione particolare, come nel caso dei profeti: "La mano del
Signore fu sopra Elia" (1Re 18,46). "La mano del Signore fu
sopra Eliseo" (2Re 3,15). "Io, il Signore, ti ho chiamato per
la giustizia e ti ho preso per mano" (Is 42,6). La mano di Dio è
anche mano punitrice: "È divampato lo sdegno del Signore contro il
suo popolo, su di esso ha steso la sua mano per colpire" (Is 5,25).
Mano, braccio, dito vengono adoperati per esprimere, con l’immediatezza
del linguaggio simbolico - lontano, come si diceva, dal nostro
linguaggio concettuale, più preciso e corretto, ma anche tanto più
limitato -, il fatto che Dio crea, opera, soccorre, è in vivo rapporto
con l’uomo.
Chiaramente ‘mano’, ‘braccio’, ‘dito’ di
Dio sono figure simbolicamente tangenti, non però identiche. In quasi
tutte le culture la mano è simbolo della persona intera nel suo
operare. Il braccio ha evidentemente lo stesso significato, ma con
speciale riferimento alla forza, al vigore, come nell’immagine
ricorrente di Dio che soccorre il suo popolo "con mano potente e
braccio teso".
Il dito
di Dio
Il dito, nominato più raramente (sono state contate
dodici occorrenze del dito di Dio nei due Testamenti, e in alcuni casi
si tratta di testi di grande intensità e forza evocativa), risulta un
simbolo più limitato e circoscritto, ma anche più ‘mirato’, più
intenzionale. Comunque, presenta vari significati, talvolta anche
compresenti: come la mano, nel suo insieme, significa potere e
autorità, può esprimere biasimo o minaccia, rinvia inoltre all’opera
di creazione, alla vicinanza del soccorrere e del toccare. Il dito a cui
d’istinto rimandano i nostri antropomorfismi
spontanei è l’indice: il dito che, come dice il
nome, ‘indica’, quindi ricorda una direzione, ammonisce. Nel primo
Testamento c’è un passo famoso in cui il dito – al plurale però -
è evocato in riferimento all’opera creatrice di Dio: il cielo, la
luna e le stelle (cioè le realtà superiori, più immediatamente
evocative della trascendenza di Dio) sono chiamate opera delle sue dita.
"Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle
che tu hai fissate… " (Sal 8,4). Più avanti nello stesso salmo
(v.7), le creature sono dette "opera delle mani" di Dio.
I maghi d’Egitto, incapaci di misurarsi con i
prodigi compiuti da Mosè dinanzi al Faraone, dichiarano: "Questo
è il dito di Dio" (Es 8,19). Anche le tavole della Legge sono
attribuite al dito di Dio: "Quando il Signore ebbe finito di
parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della
Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio" (Es
31,18).
Usando la stessa immagine del dito, Gesù collega le
sue opere di guarigione e salvezza con l’intervento liberatore di Dio.
E forse un altro episodio evangelico, che conserva ancora oggi un
elemento enigmatico, si connette con il tema biblico del dito di Dio. È
l’episodio famoso dell’adultera: quando a Gesù viene posta la
domanda insidiosa ("Mosè ha comandato di lapidare donne come
questa; tu che ne dici? "), che tende solo a metterlo in
difficoltà qualunque cosa risponda, egli spiazza e provoca i suoi
interlocutori non offrendo né un sì né un no, nessuna risposta in
parole, ma ostentando disinteresse e mettendosi a scrivere col dito in
terra.
I lettori di questa pagina non possono mai fare a
meno di chiedersi: che cosa avrà scritto? In realtà il gesto di
scrivere qui sembra più importante dell’ipotetico contenuto, a cui l’autore
avrebbe almeno fatto cenno se l’avesse considerato importante. Il
gesto di scrivere con il dito - sulla polvere del suolo e non sulla
roccia - richiama il dono della Legge e nello stesso tempo il compimento
di essa, una nuova legge di Dio scritta nel cuore dell’uomo: le parole
che Gesù dirà alla fine ("Chi è senza peccato… ") sono
appunto un richiamo a guardarsi dentro, a superare gli automatismi del
precetto e della sanzione.
Lo Spirito Santo come
"dito di Dio"
Soprattutto sulla scia di un famoso passo del vangelo
di Luca e del suo parallelo in Matteo, la simbologia antropomorfica del
dito di Dio ha ispirato anche un’interpretazione trinitaria. In Luca
infatti Gesù risponde ai suoi oppositori i quali insinuano che ci sia
un potere diabolico alla base dei suoi interventi di esorcismo e
guarigione: "Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, di
conseguenza è giunto a voi il regno di Dio" (Lc 11,20). Matteo, il
quale attinge alla stessa raccolta di detti di Gesù, forse preoccupato
per possibili fraintendimenti di tipo magico-antropomorfico da parte dei
suoi destinatari, visibilmente corregge: "Se io scaccio i demoni per
virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di
Dio" (Mt 12,28).
I più antichi commentatori della Scrittura e i Padri
della Chiesa, spiegando i testi biblici e le immagini che vi compaiono a
uditori che, quantunque convertiti, erano stati influenzati dall’antropomorfismo
pagano, sentono il bisogno di sottolineare senza equivoci la natura
spirituale di Dio e la sua trascendenza. Così nella mano creatrice di
Dio si comincia presto a scorgere un’allusione alla seconda persona
della Trinità. "Il primo uomo fu fatto dalla mano di Dio, cioè
dal Verbo di Dio", così Ireneo di Lione. Ma poiché non mancano i
passi biblici che parlano delle mani di Dio al plurale, sarà sempre
Ireneo a spingere oltre questa interpretazione simbolica affermando in
diversi suoi scritti che il Figlio e lo Spirito Santo sono "le due
mani del Padre".
Il dito di Dio viene identificato poi con lo Spirito
Santo: le dita sono perfezione e compimento della mano. E Ambrogio:
"Certo Dio non creò il cielo e la terra con dita corporee, ma con
la grazia dello Spirito settiforme, con quel dito di cui trovi scritto
nel Vangelo [...]. Se allora lo Spirito è il dito di Dio, visto che il
Figlio ne è il braccio, lo Spirito, cooperando col Padre e col Figlio
nell’unità della loro azione, ha collaborato alla creazione del cielo
e della terra…". Anche sant’Agostino (cf Discorso CCLXXII)
identifica il dito di Dio e lo Spirito Santo. Nell’inno allo Spirito
Santo Veni Creator (che risale al secolo IX), lo Spirito è
invocato anche: "Dexterae Dei tu digitus", dito della mano
destra di Dio.
Il
dito dell’uomo
Non va dimenticato che lo Spirito Santo assicura la
comunicazione di vita tra Dio e gli esseri umani, esprime nella storia
la logica di creazione, prolunga e rende attuale qui e ora la redenzione
attuata una volta per tutte: quindi è anche una componente essenziale
dell’uomo, l’elemento unificante tra "digitus Dei" e
"digitus hominis". Infatti la riflessione biblica sul ‘dito
di Dio’, inesauribile e fascinosa, potrebbe far dimenticare il polo
umano del discorso. Sarebbe una vera tentazione quella di ridurre l’essere
umano a semplice oggetto dell’intervento di Dio; contraddirebbe la
logica stessa dell’alleanza e della redenzione. Ricordiamo ancora come
nell’affresco di Michelangelo il dito divino e il dito umano s’incontrano
e, per così dire, entrano in dialogo, ma il contatto resta incompiuto,
eternamente in divenire: l’alterità di Dio e l’alterità dell’uomo
sono preservate, anzi acquisiscono un valore teologico.
L’essere umano è fatto a immagine di Dio, e
tuttavia Dio non si sostituisce al suo ‘sorgere’, al suo scegliere
(e nel racconto della Genesi non sceglierà proprio benissimo!), alla
sua coscienza; bensì li ridesta e li avvalora. Dio, che noi chiamiamo
Padre, non va confuso con un genitore terreno iperprotettivo e un po’
invadente. Dio ama muovendosi all’incontro e ama ritirandosi. Dio
prende molto sul serio gli esseri umani che chiama alla vita. All’inizio
della creazione, dell’alleanza, della vita stessa dell’essere umano,
secondo la fede giudeocristiana, si trova il dono di Dio; ma nemmeno il
dono, come osserva Carmine Di Sante in un suo libro recente, è la
figura più alta della bontà divina: "È vero che per essa l’uomo
è destinatario dell’amore gratuito di Dio, ma destinatario che, di
fronte alla donazione divina, non è recettività e passività […], ma
alterità che, di fronte all’amore di Dio dato gratuitamente, è
chiamata a decidersi liberamente […]. Per il racconto fondatore d’Israele
l’amore di Dio per l’uomo è amore responsabilizzante che, da una
parte, lo eleva dalla necessità alla libertà, essendo l’unico che
può dire sia no che sì, dall’altra lo destina dalla libertà alla
responsabilità".1
Per chi preferisse conservare il primato assoluto
della categoria del dono, si potrebbe anche dire che il dono di Dio, e
quindi la dignità dell’uomo, culmina nella libertà responsabile.
1 C. DI SANTE, L’uomo
alla presenza di Dio. L’umanesimo biblico, Queriniana, Brescia
2010, 81-82.
Lilia Sebastiani
Articolista e conferenziera
in materia teologica
Via Isonzo, 9 - 05100 Terni
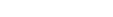 |
|
|
|