|
Il tema del corpo – e qui in
particolare della donna nella sua corporeità – ha largo spazio
nell’insegnamento di Giovanni Paolo II, il quale si è trovato in un
momento culturale che chiedeva di ripensare la figura femminile alla
luce dei mutamenti che hanno portato a una nuova valutazione della donna
in ogni ambito di vita. E lo ha fatto con una competenza e una
sensibilità da lasciare stupiti. Il segreto – come egli stesso ha avuto
modo di confidare – va ricercato nella sua viva relazione interiore con
Maria, attraverso la quale è giunto a una più profonda comprensione
della donna, della sua dignità e della sua vocazione1
.La riflessione di questo Papa
tutto mariano sulla donna va dalla dimensione corporea a quella psichica
e spirituale, chiarendo la funzione femminile sia nella Chiesa che nella
società umana. E tutto viene fatto scaturire dall’origine della donna:
un corpo che Dio plasma traendolo dall’uomo-maschio e a questi lo ridona
perché non si senta più solo nell’universo. Così il discorso si
intreccia con quello della creazione: un argomento particolarmente caro
a Giovanni Paolo II il quale proprio agli inizi del suo pontificato, nel
corso delle udienze generali del mercoledì, ha proposto una serie di
catechesi sull’amore umano nel piano divino2.
Un amore che parte dalla corporeità dell’uomo e della donna destinati a
essere «una sola carne» (Gen 2, 24) e si esprime sempre in riferimento a
questa unità originaria dei due. La presenza dell’elemento femminile,
accanto e insieme a quello maschile, ha il significato di un
arricchimento per la persona umana in tutta la prospettiva della sua
storia, compresa la storia della salvezza.
L’approfondimento dei primi
capitoli del libro della Genesi offre le basi per una vera e propria
teologia del corpo. Di conseguenza, «il fatto che la teologia comprenda
anche il corpo non deve meravigliare né sorprendere nessuno che sia
cosciente del mistero e della realtà dell’Incarnazione. Per il fatto che
il Verbo di Dio si è fatto carne, il corpo è entrato, direi, attraverso
la porta principale nella teologia, cioè nella scienza che ha per
oggetto la divinità»3.
Qualunque dimensione si guardi
del femminile, non si può prescindere da quel corpo ricevuto dal
Creatore. Anche nella Mulieris dignitatem (15 agosto 1988) Giovanni
Paolo II riparte dal libro della Genesi per svolgere il discorso sullo
specifico della donna, sia come madre di vita che come colei in cui
meglio si esprime l’ordine dell’amore.
L’unità
originaria uomo-donna
L’identità femminile viene colta
attraverso le prime parole dell’uomo alla donna appena creata: «Questa
volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa» (Gen 2,23).
Adamo, fino a quando non ha avuto al fianco Eva, si è sentito solo pur
in quell’esplodere di vita vegetale e animale in cui il Creatore lo
aveva posto. E il racconto della Genesi si svolge proprio sottolineando
l’essenzialità per l’uomo di una creatura con cui poter comunicare:
sembra che Dio prima gli faccia fare l’esperienza della solitudine,
perché poi si accorga meglio del grande dono che riceve quando gli viene
posta accanto la donna.
Così «l’uomo (maschio) manifesta
per la prima volta gioia e perfino esaltazione, di cui prima non aveva
motivo, a causa della mancanza di un essere simile a lui. La gioia per
l’altro essere umano, per il secondo ‘io’, domina nelle parole dell’uomo
(maschio) pronunziate alla vista della donna (femmina). Tutto ciò aiuta
a stabilire il pieno significato della originaria unità»4.
Unità e dualità ad un tempo.
Questa caratteristica ontologica apre alla “comunione delle persone” e a
quel concetto di “aiuto” che esprime una reciprocità nell’esistenza e
che nessun altro essere vivente era in grado di offrire. «Nella
creazione della donna è inscritto, fin dall’inizio, il principio
dell’aiuto: aiuto – si badi bene – non unilaterale, ma reciproco. La
donna è il complemento dell’uomo, come l’uomo è il complemento della
donna: donna e uomo sono tra loro complementari»5.
E questo non solo dal punto di
vista fisico e psichico, ma anche dell’essere: la femminilità ritrova se
stessa di fronte alla mascolinità, mentre la mascolinità si conferma
attraverso la femminilità. Il corpo rivela l’uomo. Così il corpo umano
viene ad essere una realtà antropologica e ad un tempo teologica. «La
teologia del corpo, che sin dall’inizio è legata alla creazione
dell’uomo a immagine di Dio, diventa, in certo modo, anche teologia del
sesso. O piuttosto teologia della mascolinità e della femminilità, che
nel libro della Genesi ha il suo punto di partenza»6.
Proprio in quanto creati come
“unità dei due”, l’uomo e la donna sono fatti per vivere una comunione
d’amore tale da rispecchiare quella stessa comunione d’amore che è nella
vita divina tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. «Questa unità
dei due, che è segno della comunione interpersonale, indica che nella
creazione dell’uomo è stata inscritta anche una certa somiglianza della
comunione divina (communio). Questa somiglianza è stata inscritta come
qualità dell’essere personale di tutt’e due, dell’uomo e della donna, ed
insieme come una chiamata e un compito» (MD 7).
Sull’immagine e somiglianza di
Dio è fondato tutto l’ethos umano, il cui vertice è il comandamento
dell’amore. Quindi l’uomo e la donna sono chiamati sin dall’inizio non
solo a vivere l’uno accanto all’altra, ma ad esistere reciprocamente
“l’uno per l’altro”. E in questo si coglie già il carattere sponsale
della relazione tra le persone.
Ma il mistero del peccato viene
a turbare l’armonia originaria del rapporto tra l’uomo e la donna. Dice
il testo biblico: «Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti
dominerà» (Gen 3,16). E Giovanni Paolo II sottolinea come la perdita
della fondamentale eguaglianza dei due è stata soprattutto a sfavore
della donna. L’affermazione biblica ha in sé un riferimento diretto alla
reciproca relazione dell’uomo e della donna nel matrimonio, e
indirettamente raggiunge i diversi campi della convivenza sociale in cui
la donna rimane svantaggiata per il solo fatto di essere donna.
Oggi, con il riconoscimento dei
“diritti della donna”, si va verso il superamento di quella cattiva
eredità, ma occorre che la donna sia fedele nel custodire quanto
costituisce la sua essenziale bellezza. Infatti «le risorse personali
della femminilità non sono certamente minori delle risorse della
mascolinità, ma sono solamente diverse. La donna… deve intendere la sua
realizzazione come persona, la sua dignità e vocazione sulla base di
queste risorse, secondo la ricchezza della femminilità, che ella
ricevette nel giorno della creazione e che eredita come espressione a
lei peculiare dell’immagine e somiglianza di Dio» (MD 10).
Donna, madre
di vita
Maternità e verginità sono le
due dimensioni attraverso cui si realizza la personalità femminile.
Nella figura di Maria coesistono e si armonizzano insieme, per questo
ella rimane il modello a cui specialmente le donne sono invitate a
guardare nel portare a compimento la propria vocazione, per l’una o per
l’altra via.
La persona umana «non può
ritrovarsi pienamente se non mediante un dono sincero di sé» (GS 24).
Giovanni Paolo II afferma che questa verità apre la strada a una piena
comprensione della maternità. Infatti «il reciproco dono della persona
nel matrimonio si apre verso il dono di una nuova vita… La maternità
implica sin dall’inizio una speciale apertura verso la nuova persona: e
proprio questa è la ‘parte’ della donna. In tale apertura, nel concepire
e nel dare alla luce il figlio, la donna si ritrova mediante un dono
sincero di sé» (MD 18).
Attraverso la maternità la donna
partecipa della potenza creatrice di Dio. Non solo il suo corpo, ma
anche la sua psicologia sono strutturati in modo da comunicare vita.
L’essere genitori si realizza molto più nella donna, la quale è
coinvolta direttamente e “paga” impegnando anche le risorse del proprio
corpo, specie nel periodo prenatale. Ella avverte il mistero di cui è
strumento. «La maternità contiene in sé una speciale comunione col
mistero della vita, che matura nel seno della donna: la madre ammira
questo mistero, con singolare intuizione comprende quello che sta
avvenendo in lei» (ivi).
La generazione del nuovo essere
umano avviene nel seno della donna con apparente passività. Poi «quando
partorisce è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato
alla luce il bambino, non si ricorda più dell’afflizione, per la gioia
che è venuto al mondo un uomo» (Gv 16,21).
Giovanni Paolo II vede in queste
parole di Cristo un legame tra la maternità e il mistero pasquale, nel
quale è contenuto anche il dolore di Maria sotto la croce. E dalla
sofferenza del parto lo sguardo si allarga a ogni sofferenza fisica o
morale attraverso cui la donna passa trasformando la croce in vita: «In
questa sofferenza ha una parte la sensibilità propria della donna; anche
se essa spesso sa resistere alla sofferenza più dell’uomo. E’ difficile
enumerare queste sofferenze, è difficile chiamarle tutte per nome: si
possono ricordare la premura materna per i figli, specialmente quando
sono ammalati o prendono una cattiva strada, la morte delle persone più
care, la solitudine delle madri dimenticate dai figli adulti o quella
delle vedove, le sofferenze delle donne che da sole lottano per
sopravvivere e delle donne che hanno subito un torto o vengono
sfruttate. Ci sono, infine, le sofferenze delle coscienze a causa del
peccato, che ha colpito la dignità umana o materna della donna, le
ferite delle coscienze che non si rimarginano facilmente. Anche con
queste sofferenze bisogna porsi sotto la Croce di Cristo» (MD 19).
Nel Vangelo la maternità è
collegata con la verginità, come si vede dalle parole di Gesù ai
discepoli che lo interrogavano sulla indissolubilità del matrimonio e la
convenienza o meno di sposarsi (Mt 19,3-12). Con la venuta di Cristo la
prospettiva cambia. Maria è la prima creatura umana ad intuire che «le
cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove» ( 2Cor 5,17). La
sua maternità divina «è la risposta del tutto imprevedibile all’attesa
umana della donna in Israele: essa giunge a Maria come dono di Dio
stesso» (MD 20).
Così, alla luce del Vangelo, è
nata la vocazione della donna anche alla verginità: «una via sulla
quale, in un modo diverso dal matrimonio, essa realizza la sua
personalità di donna» (ivi), sempre nella prospettiva di quel “dono
sincero di sé”, che in questo caso passa attraverso un amore sponsale
per Cristo.
La rinuncia alla maternità
fisica, che può comportare anche sacrificio per il cuore femminile, apre
alla maternità “secondo lo spirito”. La vocazione alla verginità viene
vissuta in genere nelle varie forme comunitarie di vita consacrata o
anche singolarmente. Comunque «è sempre vocazione di una persona, di una
concreta ed irripetibile persona. Dunque, profondamente personale è
anche la maternità spirituale che si fa sentire in questa vocazione» (MD
21).
Su questa base c’è un
avvicinamento tra la maternità della donna sposata e quella della donna
vergine. Entrambe le vocazioni trovano compimento nel “dono sincero
della persona”. E come il profilo del matrimonio si ritrova
spiritualmente nella verginità, così la maternità fisica è chiamata a
essere, a un tempo, maternità spirituale per poter generare tutta la
persona che è unità di corpo e di spirito.
E’ significativo che per
illustrare la fondamentale missione della Chiesa ed esprimere la verità
sul proprio servizio apostolico san Paolo non abbia trovato di meglio
che il riferimento alla maternità: «Figlioli miei, che io di nuovo
partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi» (Gal 4,19).
Il
“femminile” e l’ordine dell’amore
Il carattere sponsale dell’amore
tra l’uomo e la donna viene assunto nella Lettera agli Efesini (5,
21-33) per esprimere il mistero di Cristo e della Chiesa: una analogia
in cui Cristo è lo Sposo e la Chiesa la Sposa. «Cristo ha amato la
Chiesa e ha dato se stesso per lei» (Ef 5,25). Della Chiesa, detta anche
suo “corpo” (Ef 5,23) egli ha amato ogni singola persona. E ora essa
come soggetto collettivo – fatto di tutti gli esseri umani, sia donne
che uomini – è la “Sposa” di Cristo, chiamata a rispondere al suo amore.
In questo modo il “femminile” diventa simbolo di tutto l’umano (cf MD
25).
Alla luce di quanto detto
finora, Giovanni Paolo II individua ciò che decide della dignità della
donna, sia agli occhi di Dio che agli occhi dell’uomo: «Sul fondamento
del disegno eterno di Dio, la donna è colei in cui l’ordine dell’amore
nel mondo creato delle persone trova un terreno per la sua prima radice»
(MD 29).
Più facilmente che l’uomo ella è
portata ad aprire tutto il suo essere all’amore che lo Spirito Santo
vuole comunicarci. Nell’accoglierlo, esce dal proprio piccolo io
limitante e diventa capace di farsi carico degli altri, coinvolgendosi
totalmente nella situazione di una persona a lei cara per legami di
sangue, di amicizia o di pura carità.
Ritorna alla mente quel che
Caterina da Siena esprimeva con il termine “portare”: sentire anche nel
proprio fisico la realtà dell’altro che assorbe energie mentre viene
aiutato. Allora, l’essere posta nella dimensione dell’amore, comporta
per la donna trovare anche concretamente spazio per amare, evitando di
riempire la vita di troppe cose che rischiano di soffocare nella sua
persona il richiamo e la possibilità di un dono di sé più profondo.
Nella Mulieris dignitatem si
afferma che la dignità della donna viene misurata dall’ordine
dell’amore. «Quando diciamo che la donna è colei che riceve amore per
amare a sua volta, non intendiamo solo o innanzi tutto lo specifico
rapporto sponsale del matrimonio. Intendiamo qualcosa di più universale,
fondato sul fatto stesso di essere donna nell’insieme delle relazioni
interpersonali, che nei modi più diversi strutturano la convivenza e la
collaborazione tra le persone» (MD 29).
Dobbiamo riconoscere che «la
forza morale della donna… si unisce con la consapevolezza che Dio le
affida in un modo speciale l’uomo» (MD 30). E in un momento culturale
come il nostro, in cui si rischia di perdere la sensibilità per quanto è
essenzialmente umano, è più che mai attesa «la manifestazione di quel
‘genio’ della donna che assicuri la sensibilità per l’uomo in ogni
circostanza: per il fatto che è uomo!» (ivi).
La riflessione ci ha portato a
scorrere soprattutto quelle pagine a cui è sottesa la corporeità della
donna. Ma la figura femminile rimanda anche alla bellezza. Proprio
Giovanni Paolo II vi ha fatto riferimento nel corso del 1995, anno
dedicato alle donne. Rivolgendosi ai sacerdoti, li invitava ad
approfondire l’immagine della donna come sorella, un titolo che
«rappresenta una specifica manifestazione della bellezza spirituale
della donna e a un tempo è rivelazione di una sua intangibilità»7.
Concludeva poi la Lettera alle
donne con quelle qualità femminili che mettono in luce «la bellezza –
non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale – che Dio ha elargito sin
dall’inizio alla creatura umana e specialmente alla donna»8.
Una bellezza di cui Dio è la
fonte e che rientra nel discorso di una teologia del corpo umano:
«Nell’ambito della luce che proviene da Dio, anche il corpo umano
conserva il suo splendore e la sua dignità. Se lo si stacca da tale
dimensione, diventa in un certo modo un oggetto, che molto facilmente
viene svilito, perché soltanto dinanzi agli occhi di Dio il corpo umano
può rimanere nudo e scoperto e conservare intatto il suo splendore e la
sua bellezza»9.
Primizie di questa bellezza sono
il corpo trasfigurato di Cristo e quello di Maria santissima assunta in
cielo10.
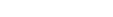 |