|
 |
 |
 |
 |
ULISSE E IL FASCINO DELLE
SIRENE
Per rispondere alla domanda vorrei
iniziare con una parabola. Tutti conosciamo i racconti omerici di
Ulisse, il quale, per non cedere al canto delle sirene, si fa legare
strettamente all’albero della nave, mentre fa tappare le orecchie dei
marinai con la cera.
I Padri della Chiesa erano giunti a
fare un commento coraggioso a questo mito di Ulisse. Clemente
Alessandrino, per esempio, con una lettura allegorica destinata ad avere
molto seguito, considera le sirene, con i loro dolci e fatali
incantesimi, come il segno della sapienza di questo mondo. I marinai poi
sono coloro che, senza alcuna comprensione per la buona cultura,
essendosi tu-rate le orecchie, rifiutano qualsiasi confronto, perché
sanno che non troverebbero più la via di casa, una volta che avessero
prestato ascolto alla sapienza di questo mondo. Ulisse invece è il
cristiano sapiente che sa di dover passare in mezzo alle insidie della
cultura del tempo, non però con le orecchie tappate, ma ascoltando e
valutando ogni realtà con il giusto discernimento, per trovare nelle
cose della cultura quelle che favoriscono la fede. Ma, per fare questo,
egli deve legarsi con fortissimi lacci al suo albero, che è l’albero
della croce. Legato così al suo legno, sarà immune da qualsiasi inganno.
La sapienza di Dio guiderà la sua nave ed il Santo Spirito la farà
giungere al porto del cielo.
Anche oggi la vita consacrata, legata
tenacemente alla croce e senza vergognarsi del suo scandalo, può
affrontare coraggiosamente tutte le difficoltà e le insidie del nostro
tempo e superare lo splendido ma fatale pericolo di questo mondo, sicuro
di sé ma fragilissimo, e discernere così tra le muse e le sirene, per
essere in grado di portare nel cuore delle nostre culture l’annuncio che
esiste un porto di pace che dà significato a tutta l’umana navigazione.
Occorre che ci aiutiamo tutti a
prendere coscienza che il problema nodale - quello che stentiamo ad
accettare fino in fondo - è che ci troviamo davvero in presenza di
grandi trasformazioni epocali, il che significa trovarci dinanzi a
situazioni che mai si sono presentate fino ad oggi. Anche la vita
consacrata, e la formazione in essa, deve accettare di confrontarsi con
una strada diversa, poiché oggi sussiste in contesti realmente diversi e
deve rispondere a bisogni che forse sono profondamente comuni ad ogni
generazione, ma che oggi non sono confrontabili e quindi sono diversi
per linguaggi, radici emotive in cui affondano e orizzonti verso cui si
proiettano. I dati ci dicono che ogni proposta ed ogni formazione, che
alimenta illusioni sulla vita consacrata, non è solo una cattiva
educazione, ma produce quel drammatico infantilismo, che tutti abbiamo
conosciuto oppure che, magari più avanti negli anni, si trasforma in
rifiuto ed abbandono.
Libertà e felicità nel
futuro della vita religiosa
Abbiamo certo tanti elementi
problematici ma, per fortuna, abbiamo altrettante realtà positive, che
sono grandi risorse per il futuro. Il dramma è che alcuni princípi
positivi e validi delle culture corrono il rischio di deteriorarsi per
il fatto di essere affermati, specie in questi ultimi decenni, in
maniera unilaterale. E così ciò che è un valore positivo, che ha
contribuito a costruire un modo di vivere altamente civile, rischia di
diventare, proprio per la sua assolutizzazione, un elemento di
disgregazione della stessa civiltà.
Si pensi solo al principio della
libertà, conseguente all’importanza che oggi si dà alla soggettività:
assolutizzato e sganciato dal riferimento ad altri princípi (come ad es.
quello della solidarietà) rischia di condurre all’atomizzazione del
nostro sistema di vita. Una libertà rivendicata come valore assoluto
rischia infatti di distruggere quella società che aveva contribuito a
costruire. Così può accadere anche nella vita consacrata: alcuni valori
evange
lici introdotti in questi anni in
forma talvolta unilaterale, senza un adeguato riferimento ad altri
valori ugualmente evangelici, possono contribuire ad inne-scare quel
terremoto, che sta destabilizzando la vita degli istituti religiosi.
E così dalla giusta e santa ma
unilaterale sottolineatura del valore della persona e del rispetto della
coscienza si è passati insensibilmente a molte forme di individualismo.
Dalla nuova visione dell’autorità come servizio alla comunità, anche
come contrapposizione alle varie forme di autoritarismo della società
civile, si è passati all’indebolimento dell’autorità stessa e ad una
scarsa stima per l’obbedienza. Dalla necessità missionaria di leggere i
segni dei tempi, si è passati, quasi inavvertitamente, alla diminuita
coscienza della necessità di rispondere con l’ansia del Regno di Dio,
limitandosi soprattutto a problemi di efficienza. Dall’apertura alle
esigenze della società, per meglio conoscerla e quindi per meglio
servirla, si è stati condotti talvolta a subire il fascino di forme poco
evangeliche presenti nella società, traducen-dole in stili di vita
borghese di stampo consumista. Dalla necessità e urgenza di comprendere
i macrofenomeni delle nostre società si è stati insensibilmente distolti
dalla più modesta ma non meno essenziale attenzione all’interiorità e ai
problemi personali del cammino spirituale, in una parola, all’uomo
interiore, al classico habitare secum.
Come conseguenza, l’acquisita
sensibilità per il cambiamento della società ha messo in secondo piano
la sensibilità verso il cambiare se stessi. E ancora: l’importanza data
alla creatività ha messo inevitabilmente in ombra la regolarità, il
riferimento alla regola, vista come ripetitività o giudicata
insufficiente per affrontare le nuove situazioni.
La felice e feconda riscoperta della
Bibbia, come fonte primaria della vita spirituale nella vita consacrata,
ha avuto come contraccolpo il pratico abbandono, da parte di molti
religiosi, della letteratura spirituale tipica della vita religiosa e
del proprio carisma, letteratura che nel passato ha mediato la parola di
Dio per questo nostro peculiare genere di vita.
E si potrebbe continuare, mostrando
come la vita consacrata, soprattutto in Europa, non sfugge al processo
di complessità, tipico della nostra società, ma comincia pure a sentire
il bisogno di tendere più consapevolmente ed energicamente ad una
sintesi che sia più rispondente alla realtà delle cose. Tanto più che la
società europea sta diventando in modo paradossale sempre più complessa
ed atomizzata attorno a tante aggregazioni settoriali e a diversi
interessi, spesso in difficile comunicazione tra di loro e poco
accordabili.
Quali suggerimenti si possono offrire
in una situazione di questo genere?
Ormai si avverte indilazionabile la
necessità, che emerge ovunque, di fare una sintesi dentro la vita
consacrata, una sintesi che riequilibri i diversi valori, perché, da una
parte, il novum di questi anni non disperda la saggezza della
tradizione e dall’altra, la scusa della tradizione non sia usata come
pretesto per uccidere il nuovo e per rimanere bloccati nell’antico. Si
tratta, in definitiva, di procedere con il senso sapienziale di tutte le
realtà, che interagiscono nel campo vasto e variegato della vita
consacrata. È un’operazione evangelica questa, dello scriba saggio, che
sa trarre dal suo tesoro le cose nuove e le cose antiche. È
un’operazione che richiede molta maturità umana e spirituale, che
procede da una visione vasta e complessiva dei molti elementi in gioco e
che va condotta assieme al popolo di Dio di tutta la Chiesa.
In questa prospettiva è giunto il
momento per la vita consacrata di passare dal fare all’essere,
a liberarsi cioè dalle molte opere, per concentrarsi maggiormente
sulla vita nello Spirito e lasciare spazio al Signore, perché possa
agire lui.
Contrasto tra modelli e
dinamiche
Approfondendo ed allargando il
discorso, possiamo costatare che fino al Vaticano II, e anche dopo, il
modello più forte della vita consacrata era il cosiddetto modello
classico, che sottolineava soprattutto gli aspetti disciplinari,
l’osservanza regolare, l’uniformità, l’ascesi… Un modello che ha
prodotto numerosi frutti di santità e di zelo apostolico ma che, al
contempo, ha corso molto il pericolo di formalismo. Poi, quasi in
alternativa opposta, ha preso il sopravvento il modello liberale,
che ha relativizzato di brutto gli elementi fondamentali del precedente
modello, soprattutto la disciplina e l’ascesi, per concentrarsi sulla
persona del consacrato/a, sulla sua realizzazione, sui suoi desideri e
sui numerosi impegni di efficienza apostolica. Il rischio, più che
teorico, è stato l’abbandono o lo svuotamento degli aspetti
contemplativi e, di conseguenza, la perdita o lo smarrimento
dell’identità religiosa e del senso della consacrazione, ridotto per lo
più ai suoi aspetti più funzionali.
Sono questi due modelli, che, pur con
gli innegabili apporti utili, ci hanno lasciato alle porte di una crisi
profonda, nella quale tuttora siamo immersi e ci dibattiamo. Per
fortuna, però, stiamo assistendo anche ad un cambio di model-lo,
soprattutto grazie e sotto la spinta dei giovani consacrati. Un modello,
in verità, ancora molto incipiente ma che, tuttavia, si potrebbe già
chiamare model-lo radicale o di sequela radicale del Signore
Gesù; un modello che si collega con la ormai conosciuta categoria della
rifondazione. Una radicalità di sequela, che chiede di ripartire da
Cristo e dalla centralità di lui nell’esistenza dei consacrati ed
insieme rilancia la specificità escatologica della stessa vita
consacrata.
Infatti, tutta la radicalità della
vita consacrata irradia l’attesa della venuta del Regno in mezzo ad un
mondo dimentico del fatto che la morte non ha l’ultima parola e che il
Padre sta attendendo tutti, affinché, risuscitati nel Signore, tutti
possano vivere per sempre con lui ed in lui. Il più grande servizio che
il Signore ci chiede ed il miglior servizio che possiamo rendere agli
uomini del nostro tempo è quello di essere testimoni dell’escatologia,
della grande Pasqua del Signore. Vivere senza figli, senza cercare di
fare carriera e senza denaro in proprio, condividere una comunione di
fraternità senza altro legame che quello carismatico, questo non è per
condurre un’esistenza cupa e per condannare il vivere comune, ma, al
contrario, per illuminare il senso e compiere la vita umana con una
forte tensione verso quel Regno, che solo può colmare l’amore umano e
che è la sola grande ricchezza intramontabile.
Inoltre bisogna dire che dopo gli
entusiasmi del rinnovamento conciliare, a causa delle difficoltà sempre
più forti subite dalla vita consacrata (invecchiamento, scarsità
vocazionale, emarginazione da parte della società [un po’ anche dalla
Chiesa] abbandoni e fragilità vocazionale, secolarizzazione di vita,
gestione sempre più difficile delle opere….) le tre dinamiche, sognate e
programmate dai documenti della Chiesa e degli Istituti come una
perfetta sintonia di coinvolgimento e di rinnovamento della vita
consacrata, in realtà, dopo 40 anni, costatiamo che girano a velocità
contrastata e contrastantesi a vicenda.
L’istituzione si è sempre più
centralizzata e sovraccaricata di impegni per far fronte alle difficoltà
sempre più grandi e spesso si è trasformata in istituzionalismo a
scapito delle persone. D’altra parte, dopo il crollo dei grandi sistemi
(al valico degli anni ‘80 /’90) tutte le istituzioni sono andate in
crisi. Le strutture troppo sovente diventano un problema per la
realizzazione della missione.
La persona, sia per contrastare le
ideologie totalitarie, sia per liberarsi dall’omogeneizzazione e
dall’anonimato della società dei consumi, sia per salvarsi dalle
pressioni dell’istituzionalismo (presente anche nella Chiesa e nella
vita consacrata) rivendica con forza un forte soggettivismo, che arriva
fino alla gestione privata della vocazione e del carisma. In particolare
si è surriscaldato o, se vogliamo, raffreddato il rapporto tra
istituzione e persona. Prendiamo per esempio il problema del rapporto
fra le esigenze del ruolo e la vita/crescita personale nella maturità
(umana, di fede, carismatica, apostolica…), il rapporto tra la
personalità e la professionalità, che il ruolo comporta. In passato
c’era una specie di natural fitness (armonia naturale) dello
status del prete in parrocchia o del frate, religioso, religiosa in
genere.
Oggi siamo alla crisi del rapporto.
Abbiamo una specie di ponte spezzato tra le esigenze della persona, le
sue domande di vita, di esistenza e le esigenze, le risposte
dell’istituzione. Pensiamo al superlavoro, ai problemi, alle richieste
più grosse di quelle che si è in grado di affrontare (se ti adatti, sei
bravo; se contesti o non ce la fai, sei inadeguato…); pensiamo alle
aspettative eccessive e persistenti, che via via massacrano fisicamente
e psicologicamente; pensiamo al fatto che troppo sovente si è
impossibilitati e non abilitati a conciliare l’ideale (= entusiasmo
vocazionale, motivazioni di dedizione…) con la situazione reale.
La conseguenza è che subentra la
sfiducia nell’istituzione (la denuncia che non sa rinnovarsi; che
pretende cose impossibili; che considera le persone solo una forza
lavoro…) e ci si rifugia nel privato con varie forme di sindrome di
burnout (= sentirsi fusi): depressione, ambiguità di identità per
angoscia e senso di fallimento; cose che normalmente vanno a parare in
varie fughe: alcool, sesso, ricerca di successo ed interessi personali
extra. Da
contemplativi nell’azione a bruciati
dall’azione con tutta l’energia spesa solo nel fare. Tutto questo per di
più è aggravato dalla situazione delle comunità, in cui la relazione fra
le generazioni vive un momento discretamente difficile. Riassumendo,
potremmo racchiudere tutto nella parola mentalità.
Il carisma, dopo il tornado
conciliare degli anni ‘60; il ritorno entusiasta alle sorgenti del
Vangelo e del fondatore degli anni ‘70; la raccolta dei frutti con le
nuove Costituzioni negli anni ‘80; si è trovato negli anni ‘90 a far
fronte al rinnovamento incompiuto e sospeso (tuttora perdurante) e così
ri-mane come un capolavoro sospeso a mezz’aria, e perciò non è diventato
vita rinnovata. La difficoltà a tradurre in concreto le grandi linee
conciliari, mantenendo lo status quo, sta tranciando le radici
vive del carisma ridotto per lo più a standart per non dire
fossile.
IL DISAGIO COME
OPPORTUNITÀ
Stiamo, dunque, vivendo nel disagio
di questo postmoderno, in cui, non purtroppo, ma per grazia di Dio,
siamo chiamati ad esistere. E che cosa sia disagio nelle nostre
comunità, oltre il già detto, si può rilevare dai seguenti sintomi:
a.
normalmente ci sono
difficoltà a trovare persone che siano disponibili per ruoli di
autorità;
b.
c’è un diffuso
individualismo comunitario non solo come fenomeno ma addirittura come
atteggiamento esigito;
c.
molti consacrati/e fuggono
nel loro ruolo, assolutizzando i loro compiti apostolici e professionali
o si buttano a cercare un accumulo di specializzazioni;
d.
c’è una diffusa ricerca di
spiritualità extra il proprio carisma;
e.
predomina come clima
generale una visione negativa sul mondo contemporaneo; (diversità tra
visione negativa come documentazione dei fatti e come sensazione
generale)
f.
sono accresciute le
lacerazioni interne alla comunità fra generazioni, fra i diversi ruoli e
fra le culture.
Di fronte a questa sintomologia, che
respiriamo a pieni polmoni, è scat-tata una serie di percorsi devianti:
1.
la negazione o la
rimozione dei problemi. Al massimo il lamento come sfogo o il buttarsi
nel lavoro/compensazioni per non guardare in faccia la realtà;
2.
tentare di risolvere i
problemi rimuovendone i sintomi (es. non ci sono vocazioni. Andiamo a
prenderle nel 3° mondo; non funziona più un’opera apostolica: ne
facciamo un albergo…);
3.
cercare dei colpevoli: i superiori,
gli anziani, i giovani, la mezza età, la diocesi e la parrocchia, lo
Stato, le famiglie, le culture diverse…
Tutto questo è una specie di
cortocircuito, che ha alla base la sensazione che gli altri
rappresentano un pericolo; e il voler uscire in fretta e furia dal
disagio, che stiamo vivendo.
Mentre la strategia giusta è tutta da
un’altra parte. I momenti di crisi contengono grandi opportunità, come
ci dimostra la storia. Il salmo 48 recita: <<L’uomo nella prosperità non
comprende, è come gli animali che periscono...>>. Ci vuole il coraggio
del cambiamento, valutando bene il presente. Anche i fenomeni che vi ho
snocciolato possono essere visti in modo sbagliato: o solo come un punto
di arrivo di un glorioso passato, ricco di soddisfazioni carismatiche e
pastorali, che, volere o no, sta andando in bancarotta; oppure come un
futuro, che pretende di cominciare da zero, come se non avessimo addosso
i cromosomi di un carisma che ha già tutta una storia. Invece c’è un
presente che deve andare all’essenziale e al genuino del passato, da cui
partire per il futuro, anche se rimane pieno di incognite e di
incertezze.
Questo allora è possibile solo se
l’Istituto si mette tutto in stato di formazione (basta con la
formazione riservata ai giovani) e con la ristrutturazione generale
delle comunità e delle cosiddette opere. Attenzione però: formazione e
ristrutturazione devono procedere insieme. Una formazione senza
contemporanea ristrutturazione delude e viene abbandonata in fretta,
perché la si vede inutile ed accademica, non ha un risvolto pratico dove
attivarsi. Una ristrutturazione senza contemporanea formazione si riduce
a far crescere il disagio ed il malcontento: si chiudono opere, si
resiste, si lotta fra partiti opposti all’interno dello stesso
Istituto...
Le provocazioni e il cambiamento
vanno ad ancorare sostanzialmente due ambiti, che, per primi, devono
muoversi.
L’identità personale e il
gruppo carismatico
Dall’Ottocento ad oggi la vita
consacrata si è definita per lo più per il tipo di opere che portava
avanti (nel campo educativo, ospedaliero, della carità nella prima
accoglienza….). Oggi quel sistema di opere sta crollando per chiusura,
riduzione, cambio di destinazione di uso, reimpostazione di presenza…
Allora la posta in gioco è se dobbiamo davvero identificarci con questi
apostolati o c’è qualcosa di più profondo a cui ancorarsi. In fin dei
conti una delle più grandi ragioni di contrasto ed incomprensione nella
vita comunitaria è qui. Dobbiamo preoccuparci soprattutto di rispondere
alle sfide di oggi con un impegno sempre più forte ed esigente sul piano
dell’efficienza, per quanto è possibile stare dietro alla corsa
travolgente della nostra epoca, oppure cercare di posizionarci sul piano
della sapienza?
Se noi guardiamo alla storia della
Chiesa e della stessa vita consacrata, ci accorgiamo che nei momenti più
difficili si è riusciti ad andare oltre e a rinascere rinnovati, perché,
invece di correre all’impazzata a tappare buchi e falle del momento
storico e culturale, ci si è dati da fare per cercare dei punti fermi,
ciò che è stabile, per superare le logiche del proprio tempo, andando
sempre più in profondità. È quello che intendiamo fare anche con questi
incontri. Insomma, tutto si riassume nel dilemma: essere religiosi
per… fare questo, quest’altro, o esclusivamente a causa di Gesù
Cristo? Oggi deve emergere fortemente che nella vita consacrata si entra
e si rimane per essere la memoria vivente del modo di vivere e di
esistere di Gesù di fronte al Padre e ai fratelli (VC 22 ), non tanto
e/o solo per fare delle cose, fossero pure importanti opere apostoliche.
Ci si deve cioè preoccupare essenzialmente delle persone consacrate e
della loro qualità di vita, prima che del mandare avanti le cosiddette
opere. E questo, come dice il documento Ripartire da Cristo al n.
20, richiede che si dia il primato alla vita spirituale e si rinsaldino
le radici della spiritualità carismatica, in modo da poter esprimere la
vera sapienza, essere cioè adulti nella fede, attraverso questa via
evangelica, con discernimento storico sull’oggi.
Comunità di rapporti
autentici
Dobbiamo dire subito che è importante
smontare il sistema, con cui abbiamo per lo più motivato e costruito la
vita di comunità. A parte che sul piano della spiritualità noi adulti ed
anziani siamo stati formati ad una spiritualità molto individuale, che
soprattutto dalla devotio moderna ad oggi è stata la linea
vincente, con una gelosa tendenza a tenere per noi le esperienze ed i
cammini spirituali di vita. Oggi la Chiesa ci chiede la capacità di una
comunione spirituale fraterna, che - bisogna ammetterlo - è per lo più
inedita. Fino ad oggi troppo sovente la comunità è stata sentita o come
luogo dell’apostolato (dove s’identifica l’opera con la comunità) oppure
solo come strumento di apostolato.
Tutto questo naturalmente è servito a
creare il punto più debole di ogni comunità consacrata oggi, da cui
deriva poi la maggior parte delle crisi e cioè il tipo di rapporti
interpersonali che vige, troppo sovente molto formali per non dire
inesistenti, con un parallelismo marcato fra le generazioni. Ci viene
chiesto d’impostare in comunità rapporti umani veri, in cui possa
scorrere e circolare bene il comandamento dell'amore reciproco. E questo
perché la comunità consacrata non sia o resti una comunità chiusa, ma
diventi una comunità aperta dentro la storia e la nostra casa sia la
casa di tutti, aperta ai quattro venti. Una diaconia di servizio
nata e fondata sulla koinonia, senza cui non ci può essere una
vera diaconia. Ma per questo occorre che la comunità ritorni ad
essere, come diceva già Benedetto ai suoi tempi, <<scuola del divino
servizio>>.
Ci
chiediamo come è possibile tradurre tutto questo in stile comunitario.
Indico due percorsi:
1.
la vita concreta
comunitaria, tempi, incontri… deve essere impostata in modo tale che chi
la sceglie sa che non è per una ragione di maggior efficienza apostolica
o per assicurare dei servizi logistici per la persona (come sarebbe un
pensionato o un albergo), ma per un’autentica testimonianza vocazionale;
2.
occorre rifare i patti tra
i fratelli/sorelle della comunità, dandosi una regola condivisa da
tutti, per assimilare ciò che si è maturato in questi 40 anni. Su quale
base? L’amore per Cristo ed il suo Vangelo; l’aver colto l’essenza del
carisma; il saper discernere i segni dei tempi. Insomma una comunità di
persone che sentono di aver ricevuto un mandato chiaro – ci credono - lo
vogliono portare avanti insieme.
Di qui un derivato, frutto dei due
punti precedenti: la missione più importante della vita consacrata è
quella di condurre alla maturità della fede gli altri membri del popolo
di Dio. Occorre rimettere il Cristo al centro, perché la vita consacrata
è troppo dispersa in tante cose, dimenticando o trascurando
l’essenziale.
LE NUOVE REALTÀ DELLA
VITA CONSACRATA
Interessante, anche se drammatica e
discutibile, è la riflessione che José Maria Vigil, clarettiano, ha
scritto su Adista (14 maggio 2005). Egli sostiene che la vita
consacrata europea è al collasso di una crisi irreversibile e non basta
una rifondazione per risolvere od ovviare alla situazione. Oltre al
fatto delle vocazioni scarsissime, la vita consacrata è praticamente
scomparsa dal suo ruolo di protagonista vigorosa e rilevante nella
società e nella Chiesa. Egli denuncia il suo stato di cattività
istituzionale che la rende priva di libertà profetica. Per cui, quella
che stiamo vivendo, non sarebbe più l’ora della profezia ma della
cultura e della semplice professionalità; non l’ora dell’esodo ma
dell’esilio; non l’ora della rivoluzione ma delle piccole riforme.
Questo proprio perché si è ridotti ad un collettivo marginale
strutturato da una gigantesca indifferenza all’esterno e da una grande
apatia all’interno. E conclude che non resterebbe altro che salvare il
salvabile e abbandonare il resto.
Si tratta, a mio parere, di una
veduta aerea, che non coglie il sottobosco e i particolari della vita,
che pur tuttavia si muove in dimensione micro. Certo, la
situazione è preoccupante, ma… Se camminiamo con i piedi per terra,
lasciando la veduta aerea, ci accorgiamo che la vita consacrata esiste e
si sta muovendo anche un’altra realtà.
Infatti,
in questi 40 anni, dal Concilio ad oggi, sono nate nuove piante di vita
consacrata. Sono soprattutto di forma monastica, però rinnovata e
desiderosa di coniugare insieme i valori tradizionali e le prospettive
del Vaticano II con gli stimoli culturali del post-sessantotto e del
cambio culturale in pieno svolgimento. Ricordiamo solo le più famose:
Bose; Piccola Famiglia dell’Annunziata di Dossetti in Emilia Romagna;
Comunità dei Figli di Dio di Barsotti in Toscana. Le caratteristiche
principali di queste <<piante>>:
a
forte dinamica spirituale che
gira attorno alla centralità della Parola di Dio;
a
forte componente fraterna
(comunità miste - condivisione con laici, soprattutto famiglie), senza
sottolineature clericali ma piuttosto laicali, centrata sulla
valorizzazione della consacrazione battesimale comune e con una grande
sensibilità ecclesiale locale e sul territorio;
a
spiccata missione al servizio
della maturazione nella fede verso tutte le componenti del popolo di Dio
(accoglienza, lectio, condivisione di vita …).
In Italia queste forme nuove si
aggirano su una tipologia simile per un totale di almeno una trentina.
Non parliamo degli altri continenti, soprattutto dell’America Latina, in
cui questo pullulare nuovo è ormai traboccante (es. in Brasile più di
180 forme nuove di vita consacrata inserite in movimenti carismatici…).
Ma non ci sono solo piante nuove.
Abbiamo anche un certo numero di germogli spuntati sul tronco vecchio
delle antiche fondazioni e carismi. Credo che la maggioranza degli
Istituti potrebbe testimoniare qualche piccolo germoglio di questo
genere, anche nella maggior parte dei casi tollerati, per non dire
contestati. Certo, non integrati, anzi piuttosto marginali rispetto
all’insieme dell’Istituto classico di riferimento. Una sorta di piccoli
fuochi sparsi. Tuttavia, al di là della tolleranza/accettazione, la cosa
interessante è che questi germogli nuovi hanno le stesse o la maggior
parte delle caratteristiche delle comunità nuove di cui dicevamo, ossia:
- centralità preponderante della parola di Dio; - fraternità
particolarmente sottolineata. Se, magari, non sono comunità miste,
tuttavia sono comunità realmente condivise con laici e famiglie, per
partecipare insieme ad esperienze carismatiche molto strette; - presenza
significativa sul territorio e nella realtà ecclesiale locale, non tanto
vista come produzione dei classici servizi della carità, quanto
piuttosto di accoglienza ed attenzione alle nuove povertà; - recupero
delle sorgenti e della freschezza carismatica a servizio della
maturazione della fede del popolo di Dio (accoglienza, lectio divina,
condivisone di vita e di cammino di fede…).
Sarebbe interessante passarle in
rassegna. Sia alle nuove piante che ai nuovi germogli c’è da guardare
con molta attenzione ed apertura, anche se non bisogna peccare di
ingenuità. Ciò che è molto interessante è che gli elementi e le
caratteristiche tornano quasi dappertutto. Ci sono fra loro anche molti
problemi. Qualcuna di queste farà semplicemente un’exploit e poi morirà.
Altre, credo, segneranno il futuro.
Tre sfide
Oggi
nella vita consacrata abbiamo soprattutto una crisi d’identità e,
di conseguenza, di visibilità e, di conseguenza ancora, di
credibilità.
Il rilancio della santità come fine e
preoccupazione fondamentale della vita consacrata diventa urgente e
fondamentale. Nel passato la vita consacrata si fregiava della santità
come di un suo privilegio, rispetto al resto del popolo di Dio.
Ricordiamo la famosa distinzione plurisecolare della via dei
comandamenti aperta a tutti e la via dei consigli aperta solo ad alcuni
privilegiati del club elitario della vita consacrata. Oggi,
grazie anche all’impostazione teologica ed ecclesiologica del Vaticano
II, questa visuale è stata fatta bellamente saltare.
La santità non è più monopolio di un
gruppo particolare di credenti, ma è chiamata e dovere di tutti. Il
rischio però per la vita consacrata è stato ed è quello di demordere
dall’impegno primario e fondamentale della santità e di concentrarsi
invece su altre dinamiche immediatamente più produttive, come
l’attivismo secolarizzato, riducendosi a produrre dei servizi magari
benemeriti ma essenzialmente funzionali. Oppure, ci si esprime nello
spiritualismo disincarnato, visto che oggi, come moda e come rifugio c’è
tutto un rilancio di esperienze di tipo mistico molto emozionali, come
cura, guarigione dei travagli interiori dell’uomo contemporaneo, in
concorrenza con le fughe a Oriente o il dilagare delle sette e della New
Age, senza compromettere sul serio le persone nei cammini di fede e
nella conversione della vita.
Ancora, si cerca una propria identità
nel perseguire un ruolo professionale stimato e considerato a livello di
società e si presenta così il proprio biglietto da visita: prima
professore, parroco, sindacalista, infermiere, psicologo, giornalista,
promotore sociale; poi consacrato, suora, prete. Tutto questo intacca
fortemente l’identità della vita consacrata sia a livello delle singole
persone che a quello di gruppo carismatico, di istituto. Non si capisce
più chi si è veramente, dal momento che si vive sbilanciati sia nel
proprio progetto personale di vita sia nelle proposte stesse di vita
comunitaria e di congregazione. Dio diventa un pretesto non la causa
delle proprie scelte e la vita consacrata non è più esistenza
concentrata su Dio, ma un usare i suoi percorsi per altre finalità
simili e parallele a quelle della società.
Nel Medioevo e nell’età moderna c’era
il fenomeno raccapricciante della vita consacrata secolarizzata per
costrizione indotta (= persone obbligate alla vita consacrata per
salvaguardare la solidità e la compattezza del patrimonio familiare a
tutto vantaggio del primogenito). Oggi abbiamo fenomeni preoccupanti di
vita consacrata secolarizzata a causa di servizi utili alla società e
per ricavarne l’immagine di sentirsi accettati, stimati e valorizzati da
essa. Naturalmente da questa crisi d’identità deriva la crisi di
visibilità (mettiamo in vetrina una schizofrenia di vita: affermiamo
cioè una vita pienamente consacrata, insieme con ritmi, mentalità e
scelte quotidiane praticamente sulla linea dell’andazzo e degli stili di
vita della società). Scatta allora l’altra grave crisi sia per noi
stessi sia per chi ci vede e ci vive a fianco: non siamo più credibili a
noi stessi e tanto meno per gli altri (credenti e non), che ci
considerano moneta falsa e gente inutile o semplicemente apprezzano il
servizio che facciamo, ne usufruiscono molto ma poi, per trovare e avere
un senso alla loro vita, se ne vanno altrove. In tutto questo l’unica
alternativa è tornare al nodo fondamentale, cioè a prendere sul serio la
vita consacrata, andando all’essenziale, perché solo qui si giocano
l’identità, la visibilità e la credibilità e si diventa quel sale e quel
lievito che Dio e la Chiesa si aspettano da essa.
In linea con questo c’è tutto il
discorso della riscoperta del carisma. La domanda è: tornare alle
origini e/o aprire nuove frontiere? Cosa significa tornare alle origini?
Un ritornare semplice, oppure una riforma, che comporti di aggiornare ed
inculturare lo spirito e le intuizioni delle origini, dando così una
forma rinnovata al carisma?
Ogni esperienza fondativa è una
parola di Dio infuocata, che scende e nasce sulla terra attraverso 4
elementi (4 pro):
a
provocazione
contestuale, che sfida il Fondatore Santo e lo fa reagire e convertire
al progetto del Signore su di lui;
a
progetto
evangelico. La reazione provocata dallo Spirito spinge a vivere qui e
ora il Vangelo con una particolare sfaccettatura: siamo alla nascita del
carisma vero e proprio;
a
processo
attuativo: sono i diversi passi concreti ed ufficiali, che fanno
prendere forma al progetto, che comportano più di qualche volta delle
vere fatiche da Ercole;
a
prodotto
definitivo: è l’immagine concreta del carisma nello srotolarsi del
tempo, attraverso l’istituzione, le varie persone, gli adattamenti...
Rinnovare i carismi. È dunque
possibile e come? Ogni carisma, dono dello Spirito, contiene un insieme
di elementi fondamentali, che sono immutabili nello scorrere dei tempi e
nella varietà delle culture. Questi elementi fondamentali immutabili
sono posti nel contenitore mutevole legato al tempo ed alle culture
stesse. La prima dimensione importante è allora la capacità di
discernimento, per riuscire a cogliere gli elementi essenziali e perenni
del carisma rispetto a quelli transeunti. Dunque il contenuto
fondamentale e il contenuto mutevole della cultura del tempo. La
seconda dimensione è vedere i diversi contenitori, che si sono
succeduti lungo le epoche, controllando sempre che gli elementi
essenziali siano stati salvaguardati. La terza è lasciarsi
provocare dall’oggi sociale, culturale ed ecclesiale, per formare il
nuovo contenitore dei valori perenni. In base a questi elementi
ricostruire il nuovo contenitore di oggi, soprattutto nella direzione
della spiritualità, della relazione fraterna e della missione.
CONSAPEVOLEZZE, SPERANZE,
INTERROGATIVI
Siamo al punto dei giovani. Partiamo
da una prima costatazione: in questi 50 anni in ambito ecclesiale sono
sorte nuove proposte per vivere il Vangelo nella vita reale
contemporanea, nonostante le tante comunità spente che ci sono in giro.
Nella vita consacrata, ricca di principi di storia millenaria a livello
di santi, c’è stata, a livello teorico, un impegno straordinario nel
ritrovare le radici carismatiche e nel riaggiornare le Costituzioni ma,
insieme, una notevole povertà di prospettive circa il futuro, per il
sogno chime-rico di un ritorno veloce della prosperità di un tempo -
cosa che non ritornerà più -; per il freno di tanta inerzia ricondotta a
sistema e per il peso di strutture diventate ingombranti ed intralcianti
il vivere veramente in modo evangelico la spiritualità, la fraternità e
la missione. Si pensi solo un momento a ciò che è capitato dalla
rivoluzione francese fino ad oggi: la vita consacrata ridotta a
lumicino; rinata nell’Ottocento con una prosperità ineguagliata
nella storia e buttata principalmente nelle opere di carità;
soffocata oggi proprio da queste stesse opere di carità attraverso
lo Stato (la normativa costringente); la Chiesa che ha spostato il
monopolio delle opere di carità dai consacrati a tutto il popolo di Dio;
ed i giovani stessi (la loro interpellanza = essere consacrati per
gestire opere oppure per essere profeti?).
Di fronte a tutto questo i giovani
consacrati sentono la vita come una presenza di minoranza nella società
e nella Chiesa o solo più un residuo? Si può parlare di minoranza quando
c’è un rapporto proporzionato: es.: 3/10; ma se il rapporto è 3/100 si
deve parlare piuttosto di residuità. Oggi molti giovani consacrati e
consacrate si sentono piuttosto residuità di un qualcosa che ai loro
occhi non sembra avere più molto futuro. Sentono l’attualità dei valori
della vita consacrata, in particolare dei consigli evangelici, ma
costatano l’incapacità ad esprimerli secondo categorie e modalità
convincenti per l’oggi.
Certo, dalla crisi si può uscire solo
guardando in avanti. Nello stesso tempo è fondamentale essere fedeli ai
grandi valori fondanti e caratteristici della vita consacrata ma con
modalità nuove. Ad es.: - una comunità evangelica con rapporti realmente
di tipo familiare, che annuncia un nuovo tipo di società fraterna ed
ugualitaria, che accentua la comunione prima e al di sopra della
comunità giuridica; - una comunità che dà la preferenza ai cammini di
fede piuttosto che alla “routine” dell’osservanza. Oggi non ci sono più
tante contestazioni forti e rigidità frontali come nel ’68, ma forse
perché non ci sono più ragioni chiare e definite che si confrontano;
troppe volte rimane solo una nebulosa di sentimenti e risentimenti
mentre non si tiene sufficientemente conto dell’esigenza di una vita
felice e realizzata dal punto di vista umano, per essere pienamente
uomo/donna anche nella vita consacrata.
Anche lo stesso servizio apostolico,
più che preoccuparsi esclusivamente di conservare la religiosità, deve
investire invece sul piano dell’annuncio dell’evangelizzazione. Molte
delle nostre attività andavano bene quando la gente mancava di beni
primari di cui vivere (mancanza delle condizioni base di sussistenza,
salute, educazione); oggi la gente, e in particolare i giovani sono
carenti del senso e del perché vivere. Oggi siamo richiesti soprattutto
di essere fermento negli spazi del dinamismo ecclesiale, in esperienze
che comprendono attività apostoliche di stretto intreccio tra
ecclesiologia e vita consacrata. Ciò richiede attività apostoliche
portate avanti insieme in maniera complementare tra istituti diversi in
stretta sinergia con la pastorale diocesana. Che cos’è mancato e cosa
manca oggi per tradurre in mandato la sfida attuale? È mancato finora
soprattutto il fidarsi di provare qualche esperienza nuova, che sia il
tentativo di ritradurre la grazia del carisma nel rinnovamento delle
esigenze nuove. Tante volte si vede chiaro che bisognerebbe fare così,
ma continuiamo a rimandare la realizzazione di queste esperienze, in
attesa di tempi più maturi, che di fatto ci fanno perdere l’oggi di
tante occasioni favorevoli.
- E la tanto celebrata tradizione? -
È vero: la tradizione è quella che ha portato il carisma a portata della
nostra vita. Tuttavia quante aggiunte sono state appiccicate.
TESTIMONI DI SPERANZA: A
QUALI CONDIZIONI?
La Chiesa ci sta chiedendo di
permettere alla perfecta caritas di Cristo di sbrigliarsi nella
fantasia della carità; non rimane altro allora che dare spazio al
fremito dello Spirito, che già respira e soffia in noi e che vuole
tradursi in vita concreta. Questo fremito deve diventare gaudio ed
esultanza di liberazione e di vita nuova. Ma come? ci chiediamo. A quali
condizioni? Ci sembra importante allora individuare la strada da
percorrere, soprattutto in tre direzioni.
Dal rinnovamento
esteriore al rinnovamento interiore
Negli ultimi quarant’anni abbiamo
fatto molte letture sociologiche, psicologiche, pedagogiche, con vari
agganci teologici e filosofici del cammino compiuto dalla vita
consacrata. In verità, bisogna ammetterlo, si è fatta poca lettura
sapienziale, che è il cercare la parola che Dio ha da dirci per questo
momento ed attraverso questi frangenti. Abbiamo lavorato molto
sull’aggiornamento; abbandonato e abbandonando tante posizioni, ci siamo
lanciati nella ristrutturazione delle opere, nel riqualificare il
personale, versando un enorme dispendio di energie, ma avvertiamo che la
risposta vera si pone ad un altro livello: bisogna andare più in
profondità.
Oggi manca una sufficiente esperienza
di Dio, che sostenga i diversi progetti i quali sono riempiti dalle
nostre organizzazioni e dalle nostre mire di efficienza, con cui qualche
volta tentiamo addirittura di programmare Dio: da quello personale a
quello comunitario, da quello formativo a quello pastorale e di
istituto.
Dal <<monopolio>>
vocazionale alla comunione fra gli stati di vita
In questi anni in cui i paesi
dell’Unione Europea vogliono rilanciare il processo della Costituzione e
gli Italiani vogliono concentrarsi sul valore della Costituzione
repubblicana, per ripensarsi, senza polemiche inutili e perniciose a
partire degli elementi fondanti, al fine di dare un nuovo ordine
all’interagire di tradizioni e di idee e creare un’armonia delle
differenze; in questi stessi anni l’esigenza della profezia di
comunione, lungo i tracciati della ecclesiologia del Vaticano II, si fa
particolarmente sentire.
Una comunione che, da una parte,
esprima con chiarezza l’identità di ogni membro, di ogni stato di vita,
di ogni chiesa; dall’altra metta bene in evidenza che occorre lasciarsi
creare dallo Spirito in questa armonia delle differenze. Ognuno si
sentirà uno strumento nelle mani del suo Signore e si libererà dalla
presunzione di potere e dovere realizzare da solo il necessario
miglioramento del mondo. Quando le cose stanno così, prenderà il
sopravvento allora e diventerà protagonista quella perfecta caritas
del Signore, che sarà il motore di tutto: <<L’amore di Cristo ci
spinge>> (2Cor 5,14). Una perfecta caritas, che, proprio col suo
protagonismo, non appiattirà ed uniformerà i carismi di ogni stato di
vita, ma ne esalterà le diversità nell’arcobaleno della comunione.
Renderà i laici interpreti del Signore risorto in tutte le realtà
secolari, con una particolare accentuazione della ricchezza e fecondità
dell’amore matrimoniale e della famiglia. Darà ai ministri ordinati la
stessa ansia apostolica e il fuoco della carità pastorale del cuore di
Cristo, che insegue senza posa la pecorella smarrita, cioè l’umanità
sofferente e perduta, per dire a tutti che Dio, col cuore squarciato in
croce, è amore e vuole la salvezza del mondo intero. Infine, chiamerà i
consacrati ad esprimere nella loro esistenza la sponsalità della Chiesa,
tutta attratta ed intenta al Signore Gesù, in modo da essere segni e
memoria vivente del suo stile di vivere e di esistere (GS 22).
Dall’informazione/istruzione alla formazione continua
Il volto autentico della persona
nella struttura della sua concreta esistenza trova il fattore ultimo
portante nell’iniziativa dello spirito: conoscenza, libertà e azione. È
espressione creatrice, perché lo spirito trascendente entra nell’essere
della natura e le dà forma, la quale non può essere altra che la forma
vivente del Cristo, perché siamo creati a sua immagine e somiglianza. La
forma autentica si inserisce in questa dinamica fondamentale. Queste
brevi riflessioni di R. Guardini ci introducono alle considerazioni di
questo ultimo punto.
Poiché le energie dell’amore sorgivo
umano (eros) non si possono mai separare dall’amore discendente
dall’alto (agape), è urgente educare e formare a far incontrare,
dialogare e maturare vicendevolmente i due amori, in modo tale che la
persona diventi sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva (cf Gv
7,37s.). Una formazione, quindi, che deve tradursi in apporti armonici
di conoscenza, appello alla libertà, itinerario progressivo di
maturazione e di crescita nell’azione, perché questa saldatura tra la
ricchezza limitata e fragile della persona e delle sue energie affettive
e la grazia di questa perfecta caritas, mossa dallo Spirito
Santo, può produrre davvero la forma vivente di ogni persona,
all’interno della sua vocazione, di ogni consacrato in particolare, nel
suo specifico carisma. Ma occorre un passaggio urgente: in questi anni
nella formazione hanno preso il sopravvento alcuni progetti per lo più
statici e alcune metodologie, che, troppo spesso, al di là delle
dichiarazioni teoriche sulla personalizzazione, hanno piuttosto favorito
una plasma-tura esteriore piuttosto che provocare la dinamizzazione
della persona dall’interno verso questa forma vivente di vita.
Molta formazione, infatti, ha dato
eccessivo spazio alle conoscenze intellettuali programmate e teoriche
più che alle dinamiche interiori di crescita. Abbiamo, di conseguenza,
tanta formazione da manuale e poca alla scuola dei grandi maestri di
vita. Occorre perciò una vera rivoluzione formativa, che non solo si
accontenti di far percorrere i sentieri indicati dalle Ratio, ma
abiliti veramente a discernere in sé quella perfecta caritas di
cui dicevamo, che abiliti cioé ad accoglierla in libertà e disponibilità
e a lavorare alla sua saldatura con la propria ricchezza personale e con
la propria storia, perché si traduca in prassi quanto è indicato dal
documento Perfectae caritatis: <<Il rinnovamento degli Istituti
dipende in massima parte dalla formazione dei membri […]. Per tutta la
vita poi i membri si adoperino a perfezionare diligentemente questa
cultura spirituale, dottrinale e tecnica>> (n. 18).
Quando un religioso/a viene
chiamato/a dai fratelli/sorelle a presiedere, coordinare, aiutare la
vita del gruppo carismatico, si trova a dover rappresentare e mediare la
ricerca della fedeltà allo Spirito Santo, autore di quel carisma. La sua
è un’autorità obbediente. Il/la superiore/a è servitore del bene comune,
del bene della persona. Dopo tutto quello che abbiamo visto, quasi a
sintesi dell’insieme, dovremmo dire che il/la superiore/a esplica: - il
servizio della luce: ricordando a tutti le finalità ed i valori del
progetto evangelico comune, attraverso una “scuola costante ed
attualizzata della Regola”, per recuperare il patrimonio comune di
spiritualità carismatica; - il servizio dell’incontro: gestendo le
strutture, in modo tale che favoriscano l’unità del gruppo con
l’animazione e le decisioni opportune, mettendo la comunità in stato di
conversione continua; - il servizio della missione: aiutando tutta la
comunità a dare valore missionario e di testimonianza al Vangelo,
suddividendo opportunamente i servizi; mantenendo i rapporti,
armonizzando le diversità, interrogandosi su che cosa vuole veramente
Dio oggi.
CONCLUSIONE
Se la nostra identità è tutta
nascosta e contenuta nel servizio di Cristo, che lava i piedi, la nostra
riflessione si è limitata al nucleo più significativo di questo
servizio, cioè la sua perfecta caritas. Un nucleo ancora da
riscoprire e da rilanciare con rinnovato impegno, nonostante i 40 anni
che ci separano dal Concilio.
L’avvenimento dell’intero Concilio è
stato un vero momento di grazia, un’esperienza di Pentecoste, una visita
dello Spirito alla sua Chiesa. La nostra ricerca ed i nostri impegni
devono puntare con tutte le forze a farci camminare verso quei traguardi
aperti e verso quei grandi orizzonti, che appaiono ancora incompiuti
nella fatica del nostro rinnovamento.
Riferimento bibliografico
H. U. VON BALTHASAR, <<Il grande
respiro della “Lumen Gentium”>>, in AA.VV.,
La Chiesa del Concilio,
Istra, Milano 1985. BENEDETTO XVI, <<Discorso alla Curia Romana>>, in
L’Osservatore Romano, 23 dicembre 2005. BENEDETTO XVI, Deus
caritas est, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006.
BENEDETTO XVI, <<Discorso ai Superiori e alle Superiore Generali>>, in
L’Osservatore Romano, 22-23 maggio 2006.
R. GUARDINI, <<Fondazione della
teoria pedagogica>>, in C. FEDELI (a cura di), Persona e Libertà -
Saggi di fondazione della teoria pedagogica, La Scuola, Brescia
1987.
K. RAHNER, Discepoli di Cristo,
Paoline, Roma 1968. S. XERES,
La Chiesa, corpo inquieto - Duemila
anni di storia sotto il segno della riforma,
Àncora, Milano 2006.
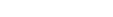 |