|
 |
 |
 |
 |
Siamo
tutti soggetti alla depressione, «la più umana e più reale delle cose»,
come dice J. Vanier1, un esperto di quella
realtà enigmatica che è il cuore umano. E forse potremmo spingerci anche
un pochino oltre, per affermare che probabilmente un po’ tutti abbiamo
fatto esperienza nella nostra vita della depressione, o forse lo siamo
tuttora o permane nel profondo di noi stessi una sorta di «io depresso»,
pronto a far capolino non appena le cose non vanno per il verso giusto.
In fondo, dice Bernanos, la speranza nasce nel medesimo punto ove
potrebbe nascere la disperazione, viene dalle stesse profondità
intrapsichiche, che vuol dire che anche il tipo speranzoso, col suo
atteggiamento positivo e ottimista, in qualche modo ha intravisto,
almeno per un attimo, lo spettro del suo contrario, della disperazione.
Come potrebbe conoscere e assaporare il gusto della gioia chi non ha
versato mai alcuna lacrima?
Tutto ciò per dire che non stiamo
parlando di alcuni casi clinici, o per lo meno non solo di essi, ma di
qualcosa che ci appartiene e ci abita dentro, e che in qualcuno a volte
emerge con particolare evidenza e sofferenza.
Vorremmo, in questa breve
riflessione, vedere il significato che può assumere la depressione in
convento (femminile soprattutto), e poi, in modo più propositivo,
identificare alcuni atteggiamenti da evitare e altri da metter in atto,
per aiutare la persona del depresso a vivere il meglio possibile la sua
depressione.
Suor Depressa
Partiamo da una sorta di definizione
descrittiva del fenomeno. «La persona depressa - in modo diversificato a
seconda degli stadi - è generalmente caratterizzata da una profonda
sofferenza interiore, da atteggiamenti di apatia, di scarsa fiducia in
se stessa e nella vita, da sensi di inadeguatezza e di colpa, di
fallimento e di oscuramento del futuro, da una chiusura in se stessa e
da un senso di abbandono da parte degli altri e, talvolta, dalla
sensazione di essere abbandonata anche da Dio»,2
al punto di sentire la vita insopportabile, priva di senso.3
Ancor più in sintesi potremmo
ricondurre a tre, allora, gli elementi costitutivi della depressione, le
sue radici: - la sensazione di non esser amabile; - né di esser di fatto
stata amata; - la convinzione che la propria esistenza sia priva di
senso.
Le tre cose sono tra loro
strettamente collegate, poiché le prime due sensazioni sono causa della
terza. È importante sottolinearlo, poiché questo ci fa capire la natura
fondamentalmente relazionale ed emotiva della depressione; in
altre parole è la relazione l’ambito in cui nasce la depressione,4
e la sfera emotivo-affettiva l’area prevalente in cui si
manifesta. La depressione, infatti, è problema dell’umore, non del
pensiero (come altre sindromi, ad esempio la schizofrenia). Se dunque
suor Depressa tende a isolarsi e sembra rifiutare il rapporto, in realtà
ne ha un bisogno enorme, e forse sta solo verificando se davvero non vi
sia nessuno che si prenda cura di lei…
Sta di fatto che le donne tendono a
esser colpite il doppio dalla depressione rispetto ai maschi, forse per
il particolare significato, con conseguente alto investimento emotivo,
che la relazione ha per la psicologia femminile. E questo dunque sta a
dire che il fenomeno può esser presente anche in convento; addirittura
c’è chi dice che oggi sia in aumento la …depressione religiosa
femminile.
Come aiutare queste persone?
Chi ha il dono della fede dovrebbe
aver un’arma in più per uscire da questa situazione.
Le consorelle di suor
Depressa
Abbiamo detto che il problema della
depressione è problema relazionale, ma allora anche la sua terapia dovrà
essere legata alla relazione. Ovviamente senza escludere, per i casi più
gravi, ovvero per la depressione clinica, il ricorso ai farmaci e alla
psicoterapia (che è pur sempre fenomeno relazionale).
Ecco perché ora la nostra attenzione
va da suor Depressa a chi le vive accanto. È fondamentale un certo tipo
di presenza per aiutare chi è depresso, e ancor prima è fondamentale che
chi sceglie di porsi a lui accanto comprenda il ruolo che potrebbe
giocare in questa vicenda o avverta tutta la propria responsabilità
fraterna. Ben ricordando, come abbiamo sottolineato più sopra, che
nessuno è immune da questo problema. E allora, se questo è vero, il
rapporto stabilito con il depresso svela il rapporto che ognuno di noi
ha con il proprio «io depresso» e con le ricorrenti sensazioni di non
sentirci amabili, anche nei confronti di Dio. Quando si è di fronte ad
una persona depressa, si diventa poveri noi stessi perché in realtà si è
messi di fronte alla propria povertà.5
Vedremo prima cosa non fare, e poi
l’aspetto più positivo.
Atteggiamenti da
evitare
C’è una serie di pregiudizi nei
confronti di queste persone o della sindrome in sé che non aiutano in
nessun senso, né la comunità ad affrontare il problema, né tanto meno la
sorella a risolverlo.
«Lo fa solo per mettersi al centro
dell’attenzione, ma io non ci casco».
Sempre pericoloso mettersi a fare gli psicologi, con interpretazioni poi
scontate e banali; ancor più grave pretendere di giudicare, impalcandosi
a giudici severi e rigorosi. È vero che il problema del depresso è un
certo egocentrismo, ma è diverso leggerlo come un bisogno compulsivo, di
fronte al quale suor Depressa è relativamente impotente e di cui spesso
è nemmeno consapevole, o come un tranello che mi tende e nel quale io,
l’intelligente senza problemi, evito di cadere. Nel primo caso scatta
una certa comprensione misericordiosa, nel secondo c’è solo il giudizio
presuntuoso che peggiora la situazione.
«Sei tu che ti sei messa in testa
certe idee. Cacciale come tentazioni».
Un bel po’ di errori in un colpo solo. Il primo è inviare un messaggio
che aumenta il senso di colpa e la percezione negativa che il depresso
ha già di sé; il secondo è far leva unicamente sulla volontà, come fosse
semplice rovesciare una sensazione che la persona si porta dietro da
chissà quanto tempo; sbagliato è pure far capire che è tutta una
montatura del soggetto, poiché è vero che il depresso distorce la
realtà, ma quando qualcuno non si sente amato nessuno può negare la
realtà di quel sentimento. Gli stati d’animo non sono veri o falsi, sono
e basta. Infine anche il riferimento alle «tentazioni» non è
intelligente, poiché accentua nel depresso la sensazione di esser
lontano anche da Dio.
«Anch’io mi sono sentita giù, ma ho
reagito. E allora dai, tirati su».
Dire questo (o pensarlo, non fa grande differenza) è come dire: «io sono
più bravo di te», ovvero è come spingere suor Depressa ancor più dentro
il baratro del suo sentirsi un nulla. Col solito insipiente richiamo
volontaristico che ne aumenta il senso di frustrazione. A volte son
proprio questi messaggi (comunque «inviati») che determinano nel
depresso rabbia non tanto contro chi gli parla così, quel bravone sempre
vincente, ma contro se stesso, soprattutto, con esiti anche pericolosi.
«Poverina, mi fa così pena! Ha
bisogno della mia amicizia calda e intima».
Ammirevoli lo slancio e la buona intenzione, ma attenzione a un paio di
cose. Anzitutto alla reale motivazione che spinge ad andare incontro
alla sorella: è la sua dignità o perché mi fa pena? Quando si vuol
davvero aiutare non si può barare, e l’aiuto è vero solo se è sincero,
ovvero determinato dalla stima dell’altro; la compassione non fa
crescere, proprio perché non trasmette stima, che è la cosa di cui ha
più bisogno un depresso.
Inoltre occorre capire che la
depressione agisce da barriera alla comunicazione intima, per cui suor
Depressa non è capace di rispondere a questa super-amicizia, la sente
eccessiva, come le chiedesse qualcosa che non è in grado di dare. E
allora, o la rifiuta isolandosi, o - al contrario - la subisce e ne
diviene dipendente.
«Con noi si trova male. Proviamo a
farle cambiare comunità».
E così, scaricando la sorella, ci si toglie il peso della propria
responsabilità! Se non esiste una relazione causale fra depressione e
ambiente, è più saggio far restare la persona depressa nello stesso
contesto ambientale, anche quando fosse essa stessa a chiedere il
trasferimento, che provocherebbe ulteriore stress e instabilità.
Quando i sentimenti sono fragili e la capacità critica indebolita, non è
buona cosa programmare cambi di vita e di luogo.
«È nevrotica, non possiamo farci
niente». Certi
comportamenti (isolamento, mutismo, rifiuto d’alimentarsi…), durante le
crisi depressive, possono far pensare a un disturbo nevrotico. Ma non è
detto, sono soprattutto messaggi che vanno decifrati per dar loro una
risposta adeguata. E non sempre è facile.
Infine, etichettare uno come
nevrotico, ancora una volta può esser un modo furbo per non sentirsi
responsabili di fronte a lui.
«Se noi stiamo allegre, lei
dimenticherà tutto e sarà allegra». Magari bastasse alzare un po’ il
tono comunitario per risolvere le depressioni! A volte è vero che la
depressione di una (la più debole psicologicamente) è il risultato della
tristezza di tutte, o la conseguenza della scarsa gioia evangelica della
fraternità. Ma non si risolve il problema dando ordini d’esser tutti
allegri; non c’è niente di più inautentico della gioia artificiale! Ma
poi, anche se a fin di bene, l’invito all’allegria potrebbe accentuare
in suor Depressa la sensazione di non esser capita, quasi d’esser presa
in giro.
Atteggiamenti da
mettere in atto
Vediamo ora d’indicare alcuni
atteggiamenti positivi, che possano aiutare a viver bene la depressione,
nei limiti del possibile, senza la pretesa di risolverla né
d’improvvisarsi psicoterapeuti, ma con l’intento di accompagnare suor
Depressa a scoprire che …non è questo il suo vero nome.
Avvertire il più presto possibile i
sintomi. Anche qui
funziona il principio della medicina preventiva, prima si coglie una
certa fatica di vivere, meglio è. Quali i sintomi? Irrequietezza,
tendenza all’isolamento, insoddisfazione e frustrazione generale,
tristezza diffusa (senza motivo), mutismo, anemia generale,
sospettosità, insonnia, inappetenza… Ma ancora più importante è che la
persona stessa giunga pian piano ad ammettere il suo stato interiore, in
un momento in cui può ancora far qualcosa per non piombare nella piena
depressione. Per questo è decisivo il rapporto umano con la persona
depressa, per offrirle la possibilità di fare una triplice esperienza:
della stima di sé nella sua propria amabilità, dell’accettazione
di sé anche nella sua non amabilità, e della
responsabilità di cui deve farsi carico, per dare senso alla vita. È
la triade terapeutica della depressione, come vedremo, che risponde ai
tre elementi costitutivi della depressione prima menzionati: il sentirsi
non amato e non amabile, e la sensazione di non senso della vita.
Resistere alla fuga e decidere di
stare accanto. Grande
tentazione quella di ignorare la cosa (e la persona) con mille alibi
(«mi mette angoscia», «tocca alla superiora», «si fa peggio a darle
attenzione»…). In effetti «starci» o «non starci» al complesso gioco
relazionale che la depressione attiva è sempre scelta molto impegnativa.
Ma, per l’appunto, dev’essere sentita come una scelta, libera e
responsabile, una specie di volontariato all’interno della comunità
religiosa, come decisione di restare accanto a suor Depressa, senza
pretendere di capire e risolvere subito tutto, ma con la disponibilità
intelligente a reinventare la relazione con una persona che si presumeva
di conoscere bene.
Accettare il confronto con la propria
depressione. Ecco il punto
nevralgico e il vero motivo della tentazione di fuggire, come già
accennato: il contatto con la depressione altrui risveglia
inevitabilmente quello con il nostro «io depresso», o con quella parte
del nostro io che non si sente amabile. Tale contatto, allora, è una
preziosa opportunità per fare i conti con se stessi, e può regalare
l’inaspettata scoperta di trovare qualche tratto di sé che non si
conosceva pienamente, ma che è emerso forte e chiaro nel tentativo di
aiutare.6 Potrebbe, ad esempio, aiutarmi a
scoprire su cosa si fonda la mia amabilità (o la mia stima di me
stesso), o - più importante ancora - potrebbe svelarmi se ho fatto
l’esperienza d’esser amato nella mia amabilità, ma anche nella mia
non amabilità, che è esperienza fondamentale per un credente.
Fare dono della stima (o far scoprire
l’amabilità). La stima (da
attivare) è la prima della triade terapeutica. Se la depressione nasce
nella relazione e a motivo di qualche relazione, anche la terapia dovrà
essere relazionale, di vero rapporto umano, nel quale suor Depressa
possa recuperare o correggere anzitutto la percezione della propria
amabilità, da lei messa in dubbio.
La condizione fondamentale, allora,
sarà che chi accosta la persona depressa non faccia finta di voler bene,
non lo faccia per compassione, o per sentirsi lui più buono, ma
unicamente per la dignità dell’altra, perché lo merita ed è giusto
che sia così, perché in suor Depressa c’è un’amabilità oggettiva
tale che non può essere scalfita da niente e da nessuno, da nessun
peccato e da nessuna condanna. La stima, infatti, è il segno più alto
dell’amore, la sua conseguenza inevitabile, ma anche la sua verifica
implacabile: se non c’è stima nel rapporto, non c’è neppure amore, al
massimo ci sarà la compassione, che non viene dall’amore né comunica
stima. Tanto più questo sarà vero con un depresso che si sente già
negativo, e ha un bisogno vitale di stima.
È ovvio che non si potrà convincere a
suon di argomenti suor Depressa che lei è amabile, ma si potrà solo
darle la possibilità di fare un’esperienza reale e concreta nella
relazione che ora le viene offerta di vivere, perché scopra anche
attraverso essa la propria amabilità radicale. Quell’amabilità radicale
che è come una cicatrice dell’origine divina, e che è il vero fondamento
della stima di sé. Suor Depressa capterà subito la sincerità di chi
l’avvicina, mentre si chiuderà come un riccio dinanzi a quegli approcci
che non nascono da stima e non possono darle stima.
Amare la persona «nella sua
depressione» (o nella sua amabilità).
Raccomanda con la forza dell’esperienza J. Vanier: «Bisogna amare le
persone nella loro depressione. È il modo migliore per aiutarle ad
uscirne».7 Amarle «nella loro depressione»
non è un invito generico a voler bene, quanto l’offerta dell’esperienza
che abbiamo detto fondamentale per qualsiasi essere umano:
l’esperienza di essere amato anche nella sua non amabilità. Che vuol
dire oltre i propri meriti e diritti. Abbiamo visto che il depresso si
sente non amabile. Ma in realtà questo è un fatto normale, ognuno di noi
è non amabile per certi aspetti, è inutile pretendere di oscurare quella
zona negativa che c’è in tutti, tanto più inutile e falso sarà dire al
depresso che non esiste in lui alcuna non amabilità. Ma sarà possibile
volergli bene lo stesso, e su questo si deve investire nella relazione:
fargli fare l’esperienza d’esser benvoluto anche nella sua non
amabilità, oltre i suoi meriti, oltre ogni sua possibile pretesa,
anche laddove è debole e incoerente. È possibile perché così ci ama Dio,
e proprio questa è la tipica esperienza cristiana, che permette poi a
ognuno di accettare se stesso.
L’equivoco di suor Depressa, infatti,
forse favorito da certa falsa o povera spiritualità, un po’
meritocratica e narcisista, è quello di vedersi balorda, poco dotata,
perdente (specie se si confronta con le altre). E allora non si accetta,
è come in perenne lotta con se stessa, delusa di sé, non amabile,
appunto, e dunque tutta da …rottamare. Sarebbe senza senso e frustrante,
a questo punto, ripeterle che invece no, deve accettarsi; non avrebbe
senso, primo perché non si danno ordini di tal tipo, secondo perché
l’accettazione di sé è possibile solo se entra in scena un altro,
l’Altro, il tu di Dio. Già a livello psicologico la persona è in grado
di accettarsi solo quando è accettata da un altro; ma siccome è solo Dio
che può garantire un’accettazione totale e incondizionata, allora questo
altro può esser solo lui. Solo chi si vede con gli occhi di Dio può
accettarsi, dunque, perché solo il Creatore guarda con occhio
radicalmente benevolo la creatura, accogliendola nel suo limite e non
permettendo che la sua debolezza possa offuscare la sua radicale
bellezza.
Ora questa verità di fede diventa
esperienza per suor Depressa, diventa verità vissuta nello sguardo e
nella vicinanza, nel gesto e nella parola della sorella che ha scelto di
porsi accanto a lei. Come se i suoi occhi e mani, cuore e bocca fossero
gli occhi, le mani, il cuore, la bocca dell’Eterno amante.
Promuovere il senso di responsabilità
per dare senso alla vita.
A questo punto è possibile rispondere anche al terzo sintomo o elemento
costitutivo della depressione, ovvero la sensazione di non senso della
vita. E da dove può venire questa …inversione di senso?
Ancora una volta dalla qualità
dell’esperienza relazionale, e particolarmente dalla verità
dell’affetto umano che è al centro di essa, e che un po’ alla volta la
persona inizia a scoprire dentro la propria vita, nella sua storia,
nelle persone che le sono state accanto, a partire dai suoi genitori, e
nonostante i tanti e inevitabili limiti di cui è costellata ogni vicenda
esistenziale umana. È come se l’affetto che ora viene trasmesso a suor
Depressa nella relazione con chi le sta accanto sbloccasse in lei una
certa capacità percettiva, e le consentisse, finalmente, di vedere
l’amore che ha già ricevuto nella sua storia, e di scoprire che quest’amore
è stato tanto, commuovendosi di fronte a esso. D’altronde solo l’amore
può scoprire l’amore. Liberando la memoria dai virus.
Da qui il nuovo senso della vita e di
ciò che prima le appariva privo di significato, o di ciò che sentiva
come un peso o addirittura come ingiustizia: se è vero che nulla come
l’amore rende responsabili, la scoperta dell’amore ricevuto in
abbondanza fa ora sentire alla persona tutta la propria responsabilità
nei confronti della vita stessa, o dello stesso amore ricevuto, e degli
altri cui potrà donare questo amore, magari soprattutto quegli altri che
soffrono come lei la tentazione di non sentirsi amabili.
Nel momento in cui suor Depressa
comincia a cogliere questa connessione di significati tra amore ricevuto
e responsabilità nei confronti di tale amore, non è più depressa. Magari
questo le complicherà la vita, ma in senso costruttivo e aperto al
futuro. Infatti il depresso, a volte, è uno che piange su di sé e la
propria storia, visto che si sente di fatto non amato, perché
«inconsciamente sa» (non c’è contraddizione, è possibile) che ammettere
di aver ricevuto amore significa poi essere responsabili di questo
amore, e dunque darsi da fare per rispondere a questo amore. Ma ciò è
sentito come troppo difficile e spaventa il depresso, che preferisce
proprio per questo non riconoscere l’amore ricevuto e piangersi addosso.
Farlo uscire dall’equivoco significa
ridargli vita, metterlo in condizione di dare senso alla sua vita,
riaprire la sua vita al futuro.
Allora, se stare accanto a un
depresso vuol dire fare i conti con la propria depressione, quando si fa
questo cammino non è solo suor Depressa che impara a sorridere alla
vita, ma anche chi l’ha accompagnata e poi tutta la comunità. Tutti
assieme a celebrare il Dio che rende lieta la mia giovinezza!
AMEDEO
CENCINI
Università
Pontificia Salesiana
Via S.
Bakhita, 1 - 37030 Poiano (Verona)
1.
Cf. J. Vanier,
La depressione. Il cammino do guarigione. Elledici,
Leumann (Torino) 2000.
2.
S. Pintor,
«Principali punti della fede sui quali è necessario particolarmente
insistere», in Aa.Vv., La depressione. Clinica, analisi
antropologica, prospettive pastorali, EDB, Bologna 2005, 280.
3.
Cf. T Anatrella,
«Educare al senso della persona, della responsabilità e dell’autostima
alla luce del cristianesimo», in Aa.Vv., La depressione, 289.
4.
E’ significativo in
tal senso il fatto, rilevato da ricerche scientifiche, che il divorzio o
la fine d’una relazione, nel 45% dei casi scateni episodi depressivi
(rilevazione statistica dell’Istituto di Psicologia Clinica
Rocca-Stendoro di Milano, citato in R. Rocca- G. Stendoro, «Quando si
spegne la voglia di vivere», in Tre dimensioni. Psicologia,
spiritualità, formazione 2 (2005) 286.
5.
Ciò ha una
sua verità e utilità per chi opera professionalmente nel settore nel
momento psicodiagnostico: il depresso ti fa sentire depresso, ovvero, se
ti senti depresso potrebbe esser segno che il paziente è un depresso.
6.
Cf. S. Landra,
«Stare accanto nella sofferenza mentale», in Tre Dimensioni.
Psicologia, spiritualità, formazione 3 (2006) 319.
7.
Intervista apparsa
su Zenit, 13/2/2007.
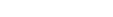 |
 English]
English] English]
English]