|
 |
 |
 |
 |
Forse
potrà sembrare strano, ma di fatto di gente dalle speranze infrante e
desiderosa di tirarsi in disparte delusa, o anche di mettere fine alla
missione e perfino alla vita, è piena la Sacra Scrittura1.
Adamo vive il suo fallimento con la paura e il nascondimento, Eva con
una reazione che mostra la mancanza di sicurezza, perché rimanda
l’accusa ad altri (Gn 3,10-12). Abramo mostra di lasciarsi trascinare
dal suo carattere introverso verso una tristezza misteriosa per la
mancanza di eredi (Gn 15,1-4) e poi per il rischio mortale di dover
sacrificare anche il figlio nato in vecchiaia (Gn 22,1-19). Mosè ha
cercato per lunghi decenni di soffocare ogni ricordo e ogni rimorso per
il suo popolo nella sofferenza, e solleva ben cinque pesanti obiezioni
alla chiamata di Dio presso il roveto ardente (Es 3,1-4,17).
Ma il popolo stesso nel deserto
dell’esodo passa spesso dall’euforia alla ribellione e alla depressione
rabbiosa (Es 15,22-17,7). Mentre il profeta Samuele dopo aver mostrato
sapienza e coraggio nel far transitare dal governo dei giudici a quello
della monarchia, con la scelta di Saul, resta poi impigliato nella
mitizzazione del suo eletto, tanto da farsi rimproverare dal Signore per
un pianto che non finisce mai (1Sam 16,1). E possiamo continuare con
quasi tutti i profeti maggiori e minori, con condottieri popolari, e con
sapienti delusi come Qohelet.
Anche nel Nuovo Testamento non
mancano depressi e sfiniti, impauriti che distruggono se stessi nella
vergogna (come Giuda) e avviliti che riescono a superare il senso di
colpa grazie all’amore (ad es. Pietro, Maria di Magdala, Zaccheo,
l’adultera, la samaritana...). Gesù stesso non è esente da passaggi
oscuri e avvilenti: si pensi a quando piange davanti alle mura di
Gerusalemme, nella veglia angosciata al Getsemani, incontrando le pie
donne sulla via del Calvario, nella sensazione di essere abbandonato dal
Padre sulla croce... E Paolo di Tarso quante volte non si sente avvilito
sia per paura della propria fragilità, sia per la ostinazione fanatica
dei suoi correligionari nel rifiutare il Cristo, sia per il ricordo di
tante traversie che come a ondate gli tornano alla mente riaprendo paure
e angosce.
Prendiamo in considerazione un gran
campione di coraggio e audacia, che però conosce anche gli abissi della
paura e le vertigini della voglia di morire. Parliamo del profeta Elia,
audace testimone di Dio e perfino infantile nelle sue paure.
Elia profeta: un uomo
che sfida tutto e tutti
La vicenda avventurosa del profeta di
Tisbe è raccontata in pochi capitoli del libro dei Re (1Re 17-19 e 21;
2Re 1-2), e sembra più una epopea per grandi quadri che una vera
biografia. Infatti non si conosce neppure la famiglia e la vocazione di
Elia: egli appare improvvisamente con irruenza, minacciando la chiusura
totale del cielo, fino a quando lo deciderà lui. Solo dal contesto
generale si capisce a che cosa mira la sua protesta così minacciosa:
risvegliare la coscienza del popolo, che sta pericolosamente adeguandosi
alla prepotenza della regina Gezabele e adottando le sue pratiche
religiose verso Baal, assurde per i veri israeliti.
Non entro se non di striscio in tutti
i passaggi della scenografia dell’attività di Elia: cosa che pure ci
darebbe spunti utili per capire il suo carattere, a momenti irruente e
deciso, a momenti impaurito e titubante. Di fronte alle resistenze della
vedova di Zarepta per il futuro del suo cibo, Elia non mostra alcun
dubbio, non mancheranno né olio né farina. Ma quando all’improvviso
muore il bimbo della donna che lo ospita, il profeta va in crisi
profonda, e manifesta una incertezza sconcertante, insieme anche una
solidarietà inattesa (1Re 17,7-24). E sarà proprio questa solidarietà
che svelerà agli occhi della vedova una immagine “altra” di Dio, più
compassionevole, impotente, quasi impaurito. E noi possiamo intravedere
il volto del più grande dei profeti, Cristo Gesù, con le sue grida e le
sue angosce (Ebr 5,7-9).
Nel momento del grande scontro sul
Carmelo fra le centinaia di profeti di Baal e il profeta di Jhwh rimasto
solo, ritroviamo ancora una fatica interiore del tisbite, che sente di
essersi esposto ad un rischio senza rete, se la sfida non riesce. La sua
preghiera angosciata: «Rispondimi, Signore, rispondimi!» (1Re 18,37) fa
trapelare, insieme all’audacia, una venatura di paura e di angoscia
mortale; che si trasformerà in furore massacrante dopo la vittoria, con
lo sgozzamento dei 450 profeti. Ma subito dopo ancora una scena
contraddittoria: la supplica prolungata di un uomo prostrato e
rannicchiato, solidale con la sofferenza ormai pluriennale del popolo, e
conclusa con la corsa euforica fino al palazzo regale di Izreèl (1Re
18,41-46).
Ma preferirei focalizzare la nostra
attenzione sul passaggio successivo, sul momento della crisi più grave e
mortale che Elia abbia passato.
«Prendi la mia vita…»
La reazione furiosa della regina
Gezabele di fronte all’oltraggio perpetrato dal profeta Elia con lo
sgozzamento di tutti i suoi profeti di corte, manda in tilt il vincitore
della disfida del Carmelo, che non sa far altro che darsela a gambe,
poiché la paura e l’impotenza lo dominano (1Re 19,1-3). Attraversa da
Nord a Sud la Galilea e la Giudea, scende a Bersabea. Al limitare del
deserto lascia il ragazzo che lo serviva e si inoltra verso sud per una
intera giornata di cammino. E al crepuscolo precipita nella depressione
più nera e mortale, buttandosi sotto un arido ginepro: «Ora basta,
Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri»
(1Re 19,4). È la rivelazione chiarissima di uno stato di depressione,
che potremmo dire da manuale. Verifichiamo il fenomeno nei vari aspetti.
Anzitutto il peso della paura
per una situazione che non sa come affrontare, dai contorni incerti e
dagli esiti niente affatto positivi, vista la ferocia di Gezabele già
conosciuta, quando massacrava a cuor leggero altri profeti. È una paura
oggettiva, ma anche ingrandita dal suo carattere, dalla sua
immaginazione, popolata dalla grandezza dei padri che non sente
incoraggianti ma giudici. Vi è mescolata anche l’ambizione,
perché si misurava sulla grandezza del passato, cercava di dare il suo
apporto originale, e la pur grandiosa vittoria gli è ritornata come un
boomerang avvelenato e non in benedizione.
Altro elemento tipico della
depressione è la fuga: si tratta di un dislocamento fisico, anche
faticoso; ma soprattutto di una fuga allo stesso tempo nell’immaginario,
rincorso dal ricordo dei padri che hanno vinto il confronto con lui
(almeno così egli giudica). Non importa dove sta andando, che senso
assurdo abbia quella strada verso il deserto: importa mettere delle
distanze grandi tra la fonte della paura e la propria persona, quasi che
così la sofferenza venisse annullata, resa invisibile. Ma gli esplode
dentro lo stesso.
Terzo elemento che sottolineerei è il
deserto e la solitudine: nella depressione ci si sente
lontani da tutti, anche se gli altri ci stanno accanto, gomito a gomito,
sono per noi assenti. Questo perché non vogliamo e non riusciamo ad
entrare in contatto con loro: e anche se ci tendono la mano, non la
vogliamo, come Elia che lascia il ragazzo al limitare del deserto. Come
ogni depresso anche lui si sente solo, nessuno, escluso; e il deserto
dove si è ficcato corrobora questa sensazione in maniera palpabile,
schiacciante. La sterilità del deserto gli penetra dentro, tanti sforzi
per niente, un completo fallimento!
Altro elemento è l’autoaccusa:
«Non sono migliore dei miei padri». Pensa di aver sbagliato tutto, ha
lottato invano trovandosi con una minaccia mortale sul capo e
l’indifferenza del popolo, che pure lo aveva acclamato al momento della
vittoria. Pensieri mortali d’impotenza e di colpa, d’incapacità e
d’inutilità lo assalgono. Tutto viene drammatizzato, radicalizzato:
basta! Sullo sfondo c’è quella figura pericolosa della donna Gezabele: è
come se gli togliesse l’aria e la vita, un fantasma negativo che lo
schiaccia, perché ha ripreso in mano la situazione, e il popolo ha
paura.
Infine il desiderio di morte:
vuole morire, chiudere tutto, un desiderio che è come una pozione
mortale. Una sensazione di stanchezza che lo fa gettare sotto il ginepro
e abbandonarsi al sonno, sperando che da lì non ritorni più, non ci sia
risveglio. Un morire dolcemente, perché gli manca qualsiasi segnale di
dolcezza, di premura verso di lui, di sostegno. Un desiderio del cielo,
ma avvelenato, per non vedere più nulla, per non lottare ancora invano,
per non uscirne di nuovo sconfitto. Possiamo vedere – in controluce,
aiutati dalla psicologia del profondo – che l’assenza delle tracce di
famiglia nella vita di Elia potrebbe significare una mancanza di
esperienza positiva con la madre. E da qui deriva allora quella lettura
di sé sempre minacciato, insicuro, e la reazione sproporzionata.
Eppure nel profondo della sua
angoscia distruttiva, Elia è come se lanciasse un grido di aiuto, una
richiesta di soccorso, per una fiducia che sembra non corrisposta dagli
esiti degli avvenimenti. E proprio in questa situazione, come da una
sorgente interna, si svela una misteriosa forza interiore.
Il fuggiasco diventa
pellegrino
Conosciamo quello che ci narra la
Bibbia: ad Elia si avvicina un messaggero celeste e lo risveglia,
offrendogli del cibo e indicandogli un percorso ancora più profondo
dentro il deserto, una meta misteriosa verso una totale rinascita nella
missione e nella speranza (1Re 19,5-8). Ed il profeta si incamminerà,
come in una specie di itinerario iniziatico fino al «monte», il luogo
della nascita di quella alleanza per la quale stava lottando con tanto
successo e con apparenti sconfitte che lo distruggevano. Lassù Elia
ridirà ancora i suoi bollori, le sue paure, la sua rabbia per un popolo
che distrugge tutto, che lo lascia solo a difendere la memoria e la
fedeltà, senza sostenerlo contro le minacce feroci. La teofania dell’Horeb
ha tutti gli aspetti della conclusione di un percorso di iniziazione, ma
anche di un attraversamento positivo, con esiti ugualmente positivi,
della crisi depressiva. Esaminiamone alcuni aspetti (1Re 19,9-18).
Anzitutto l’angelo non lo ha
colpevolizzato - tipo: «tutta una commedia», «non esagerare», «che ti
sei messo in testa?» - ma gli si è fatto vicino, con rispetto e
tenerezza, lo ha invitato a fare quei gesti che erano i più concreti e
necessari in quel momento. «Alzati e mangia!»: non è una proposta
miracolosa, una provocazione, ma un gesto semplice ed efficace, adatto
al momento. Tanto più che è accompagnato dal tocco della mano: la
tenerezza che gli era mancata; e dall’interpellazione diretta: «tu». Gli
mancava da tempo questa sensazione di essere persona e non personaggio,
fragile e impaurito e non eroe senza fragilità.
La presenza lì vicino di un soccorso
visibile, tangibile, adatto alla situazione è un altro elemento
interessante: un orcio d’acqua nel deserto arido è refrigerio e
risorsa vitale. Ma anche quella focaccia cotta su pietre roventi
indica che qualcuno ha impastato e cotto con attenzione e dedizione quel
pane. Non esistono solo minacce, ma anche risorse e gesti di
solidarietà. Minacciosa come una caldaia rovente poteva sembrare
Gezabele, ma c’era qualche altra persona che, invece delle pietre
roventi, faceva uso per dare sollievo e sostegno, di tenerezza e
generosità.
Il duplice passaggio dell’angelo
segnala la necessità di tappe adeguate, di momenti diversi per riuscire
a riprendere le forze e segnalare nuovi cammini. Non si possono forzare
le situazioni, non si deve colpevolizzare. È necessario accompagnare con
insistenza e determinazione, indicando allusivamente un impegno, ma
anche offrire le risorse utili. Vitamine che incoraggiano, assieme a
nuove avventure che bisogna tornare a vivere con distesa disponibilità.
La vita non era scomparsa durante la crisi depressiva, ma, come la brace
sotto la cenere, bisognava farla rivivere.
Quel lungo viaggio di quaranta
giorni e quaranta notti, sappiamo bene che è una cifra simbolica,
come simbolico è anche il ritorno alle sorgenti dell’alleanza, al luogo
dove l’identità d’Israele si era plasmata e codificata. Proprio per
questo rimane ancora cocente dentro Elia la delusione dell’incapacità
del popolo a distinguere le forme della fedeltà da quelle del
tradimento. L’interpellazione sull’Horeb della voce divina che lo
provoca: «Che fai qui Elia?», io la vedo anche come traccia di una sua
crisi ancora interiore d’identità. È forse una domanda rivolta con
ossessione a se stesso: che ci sta a fare là, perché è arrivato tanto
lontano, perché tutta questa avventura?
Nella duplice risposta, sempre uguale
- ma per gli esegeti forse è un errore dei copisti - io trovo traccia
dello sfogo del profeta, ancora non del tutto pacificato con se stesso e
il suo carisma. È come se dicesse: mi sono imbarcato in questa fuga e in
questo viaggio, cercando un senso e una soluzione, ma in fondo, per chi
conosce bene le cose, io sono vittima di una violenza che distrugge
tutto. Non me la sento di accettare questo, non posso credere che ci si
debba adattare, senza ardere di zelo e reagire.
Nella triplice teofania spettacolare
del fuoco, terremoto e vento (1Re 19,11-14), forse c’è anche una
catarsi psicologica trasformante: Elia è abitato da questi elementi
furiosi, e lui per primo deve liberarsene. Solo così troverà invece una
fiducia serena e stabile, una comunione con tutti coloro che
silenziosamente hanno perseverato senza dar nell’occhio, ma che l’occhio
di Dio non ha mancato di seguire con premura. Elia supererà la sua
catastrofe interiore se anche i suoi bollori si acquieteranno, se
tornerà ad amare quel popolo che invece gli sembrava solo inferocito e
idolatra. Se accetta che la fedeltà passi anche per altre forme, meno
clamorose e spettacolari delle sue, ma vere e sincere, allora la sua
stessa sconfitta sarà una scoperta di un Dio «altro» e di un altro
Israele, che finora non aveva saputo vedere.
«Ritorna sui tuoi
passi…»
L’avventura pericolosa e mortale in
cui si era imbarcato Elia viene superata, non senza qualche perplessità
circa la sua vera trasformazione, visti altri episodi posteriori (cf 1Re
21,17-29). Ma certamente Dio lo ha come attirato nel vortice più
profondo, generato dalla sua stessa crisi di paura e di terrore, per
denudarlo di ogni sicurezza, per svuotarlo di ogni furore iconoclasta,
per lasciarlo sfogare fino in fondo contro tutti e contro tutto, e non
solo contro se stesso. Ma poi lo ha anche costretto ad uscire da questa
caverna che lo proteggeva e lo rendeva cieco. Doveva conoscere un Dio
«altro», e diventare lui stesso altro – pur nella struttura del
suo carattere, che in fondo mai muterà del tutto - verso il suo popolo,
verso Dio, verso il futuro che gli sembrava del tutto occluso (1Re
19,19-21).
Chiamato ad osare la vita -
per dirla con i bei libri di Simone Pacot2 -
deve scoprire che alla sua angoscia e al suo fallimento Eliseo
contrappone la gioia di servirlo (1Re 19,21). Alla sua solitudine
affettiva e operativa in tanti porranno un’alternativa e un rimedio
unendosi nell’associazione carismatica dei figli dei profeti (cf
2Re 2,1-18). Il Dio che Elia pensava di servire con tutto lo zelo
umanamente possibile e che voleva difendere dalle profanazioni,
rischiava di essere profanato dalla sua irruenza e cecità nel sentirsi
solo e unico, mentre a migliaia abitavano Israele con cuore fedele.
Le sorgenti limpide per una rinascita
interiore sua e del popolo, erano simbolicamente e traumaticamente
disseccate (come le acque del Kerit), ma Dio sapeva alimentarle
segretamente per altre vie e con altri modelli. Elia le ha ritrovate
sull’Horeb, verso cui fuggiva avvilito e arrabbiato. Il popolo invece ne
aveva sempre avuto accesso, nonostante i clamori del tisbite e le sue
accuse.
Bruno
Secondin
Pontificia Università
Gregoriana – Roma
Borgo S. Angelo, 15 –
00193 Roma
1.
Una bella rassegna
ne fa L. De Candido, «crisi», in Nuovo Dizionario di spiritualità,
a cura di S. De Fiores e T. Goffi, Paoline, Roma 1979, 336-354.
2.
Mi riferisco ai
volumi di S. Pacot, L’evangelizzazione del profondo, Queriniana,
Brescia 20043, Osa la vita nuova!, Queriniana, Brescia
2005.
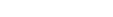 |
 English]
English] English]
English]