|
supplemento
n. 05 maggio 2007

Altri articoli disponibili
|
|
 English
English
La tentazione del potere
Lectio divina: Marco 10,32-45
di
Marcello Brunini
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Gesù, nel vangelo di Marco, da buon conoscitore ed
educatore del cuore, aiuta i suoi discepoli a prendere contatto con il
desiderio di potere che si annida nelle loro profondità. Il Maestro sa
bene che coloro che hanno autorità devono tener presente quella subdola
tentazione del potere, che è nascosta nell’esercizio stesso
dell’autorità. L’opposto dell’amore, difatti, non è immediatamente
l’odio, ma il potere. Ciascuno di noi ama le persone con le quali
condivide l’esistenza quotidiana ma, al contempo, vuole che facciano ciò
che noi desideriamo. C’è in ognuno un desiderio di prevaricazione
sull’altro. Questo atteggiamento si ritrova nella famiglia, negli
Istituti, nella Chiesa, nella società.
Gesù aiuta a prendere contatto con questa tentazione
di prevaricazione. È importante seguire il suo cammino di purificazione
dal potere, perché aiuta ad intravedere lo stile che dovrebbe permeare
il servizio dell’autorità espresso in un orizzonte spirituale. Un testo
di Marco (10,32-45) ne dà una esatta esplicitazione.
"[32] Mentre erano in viaggio per salire a
Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sconvolti;
coloro che venivano dietro erano spaventati. Prendendo di nuovo in
disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto:
[33] "Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà
consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte,
lo consegneranno ai pagani, [34] lo scherniranno, gli sputeranno
addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni
risusciterà".
[35] E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i
figli di Zebedèo, dicendogli: "Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia
quello che ti chiederemo". [36] Egli disse loro: "Cosa volete che io
faccia per voi?". Gli risposero: [37] "Concedici di sedere nella tua
gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra". [38] Gesù disse
loro: "Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io
bevo, o essere battezzati con il battesimo con cui io sono battezzato?".
Gli risposero: "Lo possiamo". [39] E Gesù disse: "Il calice che io bevo
anche voi lo berrete, e il battesimo col quale io sono battezzato anche
voi lo riceverete. [40] Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra
non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato".
[41] All’udire questo, gli altri dieci cominciarono a indignarsi con
Giacomo e Giovanni. [42] Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: "Voi
sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i
loro grandi esercitano su di esse il potere. [43] Fra voi però non è
così; ma chi vuol essere grande tra voi sarà vostro servitore, [44] e
chi vuol essere il primo tra voi sarà lo schiavo di tutti. [45] Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti"".
Contesto e divisione
I discepoli credono sinceramente che Gesù è il Messia
promesso. Pietro lo ha manifestato per tutti (cf. Mc 8,27-29). Tuttavia,
hanno serie difficoltà ad accettare il messianismo "debole" in cui Gesù
si esprime; egli è un Messia umile e piccolo e, per di più, orientato
verso la morte. I desideri, le attese e le speranze del popolo d’Israele
attorno al Messia, sembrano infrangersi dinanzi al modo con cui Gesù si
presenta. La reazione di Pietro agli annunci della passione rivela
questo malcontento e conduce all’incomprensione della missione del
Maestro.
Il testo afferma chiaramente: "Pietro lo prese in
disparte e si mise a rimproverarlo" (Mc 8,32). Gesù contraddice Pietro:
"Va’ dietro a me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini" (Mc 8,33). Pietro è "satana", in quanto ripropone a Gesù la
tentazione del demonio, che l’aveva spinto verso un messianismo forte e
vincente. Gesù rimette Pietro al suo posto: dietro il Maestro. Il posto
del discepolo non è davanti, ma dietro, al seguito del Maestro. Pietro
ha sempre il desiderio di dire a Gesù quello che deve fare, come
comportarsi: Pietro ama il Maestro, ma vuole che faccia come dice lui.
Ecco il desiderio nascosto del potere sull’altro.
Ma questo non è tutto. I discepoli non solo pensano
secondo satana, ma rivelano un’incomprensione quasi totale della
missione di Gesù. Sia dopo il secondo (cf. Mc 9,31) che dopo il terzo
annuncio della passione (cf. Mc 10,32-34), sorge tra di essi una disputa
sul "potere"; un diverbio su chi tra di essi è il più grande. La
tentazione del potere è molto più radicata di quanto sembra e avvolge
tutti i discepoli. Gesù li aiuta a comprendere che tra il potere mondano
e la gloria della croce c’è profonda opposizione.
Il nostro episodio, inoltre, è la conclusione di
tutto l’insegnamento iniziato in 9,35 con il detto: "Se uno vuol essere
il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore (diaconos) di
tutti". Al v. 44 del nostro testo viene sottolineato: "Chi vuol essere
il primo tra voi sarà schiavo (doulos) di tutti". Questi due
versetti racchiudono un insegnamento peculiare: la necessità, per il
discepolo, di abbandonare il desiderio del potere e porsi all’ultimo
posto per servire tutti, come il Maestro. Il v. 45, poi, fornisce la
motivazione di questo atteggiamento, legandolo strettamente al servizio
del Figlio dell’uomo.
Il nostro testo può essere suddiviso in due momenti:
a) Gesù annunzia per la terza volta la sua passione, morte e
risurrezione (vv. 32-34); b) la disputa sul potere, che possiamo
suddividere in tre unità: il dialogo tra Gesù e i figli di Zebedeo (vv.
35-40), la reazione degli altri discepoli (v. 41), la risposta di Gesù (vv.
42-45).
Annuncio della passione, morte
e risurrezione (vv. 32-34)
Il vangelo di Marco si presenta come un viaggio.
Gesù, i discepoli e il lettore sono diretti verso Gerusalemme. Nella
città santa si concluderà violentemente la vita di Gesù. Un cammino
tracciato da Dio nelle Scritture e accolto con ferma decisione da Gesù:
"camminava davanti a loro" (v. 32). È lui il Maestro che cammina
davanti al discepolo; è lui che sale per primo e traccia la strada.
Il discepolo è tale perché sta dietro. A Pietro che
lo aveva rimproverato, il Maestro aveva risposto: "Va’ dietro a me,
satana!" (Mc 8,33). Quasi a dire: "Tu, Pietro, vuoi andare avanti; sei
tu che vuoi tracciare la strada. Questo atteggiamento non è da
discepolo; il discepolo sta dietro e guarda il Maestro! Siccome tu sei
il discepolo, il tuo posto è dietro di me". Il discepolo, difatti, è
colui che mette i piedi sulle orme lasciate dal Maestro, è colui che si
sovrappone al suo cammino. Se intende mettersi davanti, il discepolo
nega se stesso.
I discepoli seguono Gesù "sgomenti… impauriti"
(v. 32). Non capiscono fino in fondo, ma intuiscono che cosa accadrà a
Gerusalemme. Nel cammino dietro a Gesù c’è posto anche per la paura. Il
Maestro stesso ne farà esperienza (cf. Mc 14,33). La sequela di Gesù
avvolge tutta la vita, proprio per questo in certi momenti è difficile.
Percependo lo sgomento dei discepoli, Gesù fa una
cosa tenerissima: li prende in disparte e li "mette a parte" di ciò che
sta per accadergli a Gerusalemme. Condivide con loro la sua vita, la sua
morte, l’attesa della risurrezione. Sei verbi descrivono l’azione
dell’uomo su Gesù: condannare, consegnare, schernire, sputacchiare,
flagellare, uccidere. "È come la somma di tutto il male, che raggiunge
la sua consumazione nell’uccisione dello stesso Dio".1
L’ultima azione però sarà quella di Dio: "e, dopo tre giorni,
risorgerà" (v. 34).
Gesù si presenta ai suoi come il giusto sofferente,
il Figlio dell’uomo ucciso e risorto, umiliato e innalzato.
Dialogo tra Gesù e i figli di
Zebedeo (vv. 35-40)
Nel contesto che abbiamo delineato, si collocano le
parole di Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo. Essi si alleano nel
desiderio di primeggiare sugli altri: "Maestro, vogliamo che tu
faccia per noi quello che ti chiederemo" (v. 35).
"Noi vogliamo che tu faccia per noi". In
queste parole si esprime la volontà di potenza dei due. Possiamo
riformulare così la loro richiesta: "Tu Signore devi fare la nostra
volontà, devi venire totalmente incontro ai nostri desideri". Per un
discepolo che vive della sola volontà del Maestro, questa è una
richiesta veramente distorta. È il rovesciamento del fondamento
dell’essere discepoli. Il discepolo non può chiedere ciò, altrimenti si
fa Maestro. La tentazione del potere possiede una sua unicità proprio
perché ti fa mettere nei panni del Maestro.
"Ciò che chiediamo a te". I discepoli chiedono
che Gesù si faccia esecutore dei loro piani. Il discepolo è colui che
segue il Maestro, qui, al contrario, è colui che si mette davanti. La
domanda dei figli di Zebedeo smaschera la loro volontà di potenza, il
loro tentativo di autoaffermazione allo stato puro.
Il Maestro risponde: "Che cosa volete che io
faccia per voi?" (v. 36). Gesù non annienta il desiderio del
discepolo; lo accoglie, anche quando è decisamente distorto, e cerca di
educarlo confrontandolo con la sua vita.
"Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla
tua destra e uno alla tua sinistra" (v. 37). Si gioca a carte
scoperte. La richiesta che i due esprimono non si limita al prestigio e
al potere da esercitarsi su questa terra. Tutto ciò è già stato escluso
in precedenza (cf. Mc 9,34-37). L’attuale desiderio dei due fratelli
pretende ormai di elevarsi fino al cielo, di impossessarsi anche del
Regno e della gloria del Cristo. I due fratelli sembrano non aver
percepito niente della confessione di Gesù sulla sua passione e la sua
prossima morte. Giacomo e Giovanni vogliono "sedere nella gloria" del
Figlio di Dio. "La "Gloria" è sinonimo di Dio, in ebraico significa
"peso". È il suo eccessivo amore, che dall’alto l’ha attirato verso di
noi. Ogni nostra esaltazione è una vana-gloria, un peso vuoto, un
non-Dio. La "sua gloria" invece è l’abbassamento del Figlio dell’uomo
crocifisso, giudizio sul mondo e fine di ogni vanagloria. Alla sua
destra e alla sua sinistra, al posto dei due fratelli, si troveranno
intronizzati due malfattori, fratelli di tutti noi (15,27)".2
I due fratelli non vogliono soltanto la supremazia
sugli altri, vogliono partecipare alla gloria stessa del Messia. Pur non
conoscendone la natura, essi la ritengono potente, grande, unica perché
è la gloria del Messia. Non percepiscono che stanno vanificando in
radice il piano del Padre e la sua opera in Gesù.
Allora Gesù propone loro la vera grandezza del
discepolo: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice
che io bevo, o essere battezzati nel battesimo che io ricevo?" (v.
38).
Per partecipare alla gloria del Figlio dell’uomo è
necessario attraversare una prova terribile, la stessa di Gesù: bere il
calice ed essere battezzato.
Il calice di Gesù è quello che lui stesso sarà
tentato di rifiutare nel Getsemani: "Abbà! Padre! Tutto è possibile a
te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò
che vuoi tu" (Mc 14,36). È il calice della croce, il calice amaro di
tutto il fiele del mondo (cf. Is 51,17; Sal 75,9). Bere il suo calice, è
partecipare al suo destino, diventare suoi discepoli nel servizio, fino
alla morte. Solo in questo modo si partecipa della sua stessa
benedizione, del suo "calice di salvezza" (cf. Sal 115,13). Bere il suo
calice è proclamare: "Il Signore è mia parte di eredità e mio calice" (Sal
15,5).
Il battesimo è, per Gesù, il suo andare in fondo,
nell’abisso, in solidarietà con tutti gli uomini, con tutti i peccatori.
La sua morte è come un bagno in un mare di sofferenza per la salvezza di
tutti. Lo stesso termine, nella letteratura profana, significa
"inghiottire", "annegare" e talvolta persino "perdere", "far perire".
Per il discepolo, ricevere questo battesimo significa essere "sepolti
insieme con lui nella morte… essere completamente uniti a lui con una
morte simile alla sua" (cf. Rm 6).
Avere parte alla gloria di Gesù significa, dunque,
per il discepolo partecipare fino in fondo al suo destino di morte. La
gloria del Maestro è quella della croce; questa gloria è la stessa per
il suo discepolo. Chi vuole appartenere a lui deve essere pronto a
seguire il suo intero cammino. Partecipando alla sua passione, i suoi
discepoli si legano a lui e, con lui, al Padre. Il mistero della
passione di Gesù è che esso non lo separa, ma lo lega al Padre. Lo
stesso vale per il discepolo.
La risposta dei due è senza tentennamenti: "Lo
possiamo" (v. 38). Non hanno capito. Fra la domanda di Gesù e la
loro risposta non c’è un attimo di riflessione, così la parola del
Maestro non diviene per essi interrogazione e possibilità di
cambiamento. Essi sono chiusi nella loro volontà di potenza, di
conseguenza, incapaci di prendere contatto con il destino di Gesù. Ad
ogni modo, per volontà di carne nessuno può essere discepolo e
partecipare alla morte del Maestro. Ciò è solo dono dello Spirito.
Gesù, ugualmente, garantisce loro che saranno suoi
discepoli: "Il calice che io bevo, anche voi lo berrete" (v. 39).
Lui li ha scelti e la sua fedeltà rimane sulle loro vite. Essi saranno
incorporati al suo destino, passando attraverso la sua stessa esperienza
di sofferenza e morte.
Questo avverrà. "Ma sedere alla mia destra o alla
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato
preparato" (v. 40). Il Figlio dell’uomo non è venuto a conferire
privilegi o posti di potere, neppure in rapporto alla sua gloria. Egli è
venuto per comunicare la sua umiltà di Figlio. Concedere di sedere alla
destra o alla sinistra è proprio del Padre. Gesù è l’umiltà piena, il
Figlio senza potere. Solo il Padre concede, a quanti si fanno piccoli
come il Figlio, di sedere vicino a lui.
Reazione degli altri
(v. 41)
e risposta di Gesù (vv. 42-45)
"Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a
indignarsi con Giacomo e Giovanni" (v. 41). Anche gli altri amano il
potere e si sentono scavalcati e minacciati dall’iniziativa dei due
fratelli. È l’invidia per il potere. Da una parte la via della croce,
dall’altra la lotta per il potere. La reazione dei dieci evidenzia il
peccato del mondo, comune a tutti, per il quale Cristo muore.
Gesù, allora, "li chiamò a sé" (v. 42).
Teneramente il Maestro chiama tutti i suoi discepoli per aiutarli ad
entrare nel mistero della sua gloria crocifissa. Li accoglie così come
sono, non li caccia via e li aiuta a comprendere il fraintendimento in
cui sono caduti circa la sua gloria crocifissa.
"Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi esercitano su
di esse il potere" (v. 42). Voi sapete che quanti "sembrano
comandare" i popoli, li tiranneggiano e i loro capi spadroneggiano su di
loro. Il mondo è governato da un preciso principio: servirsi degli altri
per primeggiare. In realtà, costoro sono uomini "capovolti". A loro
sembra di comandare e di primeggiare, ma è solo una parvenza.
"Tra voi non è così" (v. 43). La gloria del
mondo che si esercita con il dominio, deve essere evitata con cura dai
discepoli. Infatti, "tra voi" c’è il Figlio dell’uomo, c’è l’Umile, c’è
l’Ultimo. "Tra voi" è possibile un servizio vicendevole, perché "tra
voi" c’è il Figlio. Con lui possiamo prendere contatto con la nostra
volontà di potenza e capovolgerla in servizio.
"Chi vuol diventare grande tra voi" (v. 43).
Anche nel Regno di Gesù c’è una grandezza che va desiderata e chiesta.
Lui stesso la desidera per noi. Ma questa grandezza è il servizio: "Sarà
vostro servitore", sarà vostro diacono (v. 43). Servo è colui il cui
lavoro è dell’altro. Servire, allora, è promuovere il bene dell’altro; è
il contrario di servirsi dell’altro o asservire l’altro.
"Chi vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di
tutti" (v. 44). Il discepolo di Gesù, non è soltanto un diacono, ma
è "lo schiavo". Mentre il servo mette a disposizione dell’altro il
proprio lavoro, lo schiavo è tutto del padrone, sua esclusiva proprietà.
Nella comunità di Gesù, i discepoli sono schiavi l’uno dell’altro,
proprietà l’uno dell’altro. Nella sua comunità vige il paradosso della
gloria del crocifisso: grande è chi serve, primo è colui che si fa
schiavo.
Accogliendo tutte le fratture e la volontà di potenza
presente nel cuore dei discepoli, Gesù li accompagna verso questa
paradossale novità. Partendo dal loro desiderio di primeggiare, li aiuta
ad entrare nell’altra ottica, li aiuta a trasformarsi in lui.
"Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti"
(v. 45). Prima il comando, quindi il motivo del capovolgimento di
prospettiva. Il Maestro e Signore "non è venuto per essere servito,
ma per servire". Questa è la più bella definizione che Gesù dà di
sé. Sintetizza il senso della sua venuta tra noi, il fine di tutta la
sua vita. Egli è nostro servo, nostro schiavo; colui che mette a nostro
servizio la sua opera, la sua parola, la sua stessa vita. Così facendo
ci rivela Dio stesso: Dio è colui che serve l’umanità, è colui che si è
messo nelle mani degli uomini.
"In riscatto per molti"; in riscatto delle
moltitudini, ossia di tutti. Il testo richiama Isaia (53,10-12): "Ma al
Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in
espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo
suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e
si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà
molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio
le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se
stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori".
Gesù offre in sacrificio la sua vita a servizio e in
riscatto delle moltitudini. Il suo destino di "giusto sofferente" lo
lega a tutto il male del mondo. Egli prende su di sé il peccato e lo
vince per tutti. Ogni uomo è anche uno schiavo del peccato, vive in
disaccordo con Dio e non può con le proprie forze riconciliarsi con lui.
Gesù è venuto a riscattare i peccatori, a riconciliarli con il Padre.
Così la sua vita, in quanto posta "a servizio",
diventa un’esistenza donata a tutti; una vita che trova nella morte il
suo sigillo ultimo e definitivo, come dono della vita in Dio. È quanto
il centurione romano affermerà ai piedi della croce, quando "vistolo
spirare in quel modo", vedrà rifulgere sul volto del Crocifisso la
gloria del Dio vivente e farà risuonare, per la prima volta sulla terra,
il grande segreto del Vangelo: "Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!"
(Mc 15,39).
Alla gloria della croce conduce la nostra solidarietà
con Cristo e con i fratelli. La vita cristiana prima di essere un
servizio è una mistica. Il servizio cristiano non ha il suo fondamento
in sentimenti di partecipazione alla vita degli uomini o in un semplice
aiuto offerto agli ultimi. Le radici profonde del servizio cristiano
sono in Cristo Gesù: l’Ultimo. La nostra solidarietà con lui ci
porta ad essere ultimi, ossia servi, schiavi dei fratelli. Quanto più
sono unito a Cristo Ultimo, tanto più sono servo e schiavo degli
ultimi; tanto più il mio servizio dell’autorità fa trasparire lui:
l’Ultimo degli ultimi.
Certamente il servizio di Gesù e il suo radicale
effetto salvifico sono unici. Eppure anche il piccolo e contraddittorio
servizio di governo può, se disinteressato, esprimere un timbro
liberatorio e risvegliare la speranza, liberare dalla necessità
spirituale e corporale, portare aiuto, perdonare, favorire la pace,
promuovere la vita dei singoli e della comunità.
Per un confronto con la vita quotidiana
Afferma il Vangelo di Giovanni:
"Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi
accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste" (Gv
5,43).
"Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio?
Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il
diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli fin da
principio è stato omicida e non ha perseverato nella verità, perché in
lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è
menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete, perché
dico la verità" (Gv 8, 43-47).
"Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già
venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo (per conto
proprio) e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con
me" (Gv 16,31-32).
Il demonio è "chiuso nel suo proprio". Il demonio e i
suoi figli hanno una loro "gloria": un amore proprio, una volontà
propria, una dottrina propria, un’utilità propria. Accogliere il proprio
è farsi autoidolatra; è rifiutare di essere icona, ossia immagine di
Dio, cioè comunione.
Il "proprio" e la "gloria" del demonio sono l’esatto
contrario della parola e dell’esistenza di Gesù: la glorificazione del
Padre. Gesù, in quanto Figlio non ha un proprio, il suo proprio è
il Padre; tutto il suo essere è esclusiva comunione con il Padre, anche
nell’abbandono, e con coloro che lui stesso gli ha affidato, ossia gli
uomini tutti.
Coloro che hanno un servizio di autorità nella
comunità devono essere consapevoli del loro "proprio"; un proprio
esclusivo e demoniaco. Attraverso il rapporto con Gesù, possono aprirsi,
nello Spirito, al suo proprio autentico: il Padre e i fratelli.
Il servizio dell’autorità diviene prezioso quando
aiuta i fratelli e le sorelle a prendere contatto con le loro chiusure e
le loro rigidità. Un peculiare servizio dell’autorità consiste
nell’allargare gli orizzonti, nel far uscire dal chiuso del cuore, nel
far abbandonare modelli acquisiti troppo legati all’amore proprio, alla
volontà propria, alla dottrina propria, all’utilità propria. Questo
cammino troverà sempre critica e polemica. L’importante è non lasciarsi
scoraggiare e continuare l’offerta della profezia e novità del
Crocifisso Risorto. L’autorità che non mette in conto critica e polemica
rischia di affondare nel "proprio" demoniaco.
L’avvolgimento nel ruolo. È Nicodemo il
personaggio del quarto Vangelo decisamente avvolto nel ruolo. Questi è,
sicuramente, una persona buona, sincera, ma estremamente vincolata al
suo status sociale, alla sua prerogativa di intellettuale, alla
sua condizione giuridica di maestro. Essendo troppo legato a questi
ruoli non riesce a viverli con libertà e scioltezza, anzi ne rimane per
lo più soffocato. E questo lo frena nel suo cammino di fede e di
sequela. Ciò che vive Nicodemo può sperimentarlo chi occupa nella
comunità un posto di autorità.
L’invidia come paura di sottrazione dell’autorità.
Il quarto Vangelo registra l’invidia dei capi nei confronti di Gesù;
un’invidia che, suscitata dal timore di perdere il potere di fronte al
popolo, si trasforma in accusa nei suoi riguardi (cf. Gv
7,31-32.44-49.51-52). Coloro che hanno un compito di autorità è
importante che si interroghino sulla dimensione dell’invidia, intesa
proprio come timore di perdere l’autorità di fronte agli altri.
La vanagloria. "Come potete credere, voi che
prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene
da Dio solo?" (Gv 5,44). Gesù mette a nudo il bisogno tutto umano di
cercare la gloria e la lode vicendevole (io lodo te e tu lodi me!),
anziché la gloria di Dio. La vanagloria, collegata all’esercizio del
potere, si esprime soprattutto nell’uso dell’autorità per creare
consenso attorno alla propria persona e a quei progetti che favoriscono
esclusivi riconoscimenti personali. Nota Martini: "È certamente più
facile ricevere plausi che fischi; però è più bello accettare i fischi
perché quando si entra in contrasto con qualcuno, è possibile esprimere
un valore"; nel contrasto può emergere davvero il "peso", la "caratura"
di ciascuno, in particolare di coloro che hanno autorità.3
Il togliersi di mezzo. Il racconto del cieco
nato, che diviene vedente, evidenzia il passaggio dalle tenebre alla
luce della fede per intervento di Cristo (cf. Gv 9). L’uomo, cieco dalla
nascita, è condotto da Gesù verso una luce totalmente nuova. Egli non
recupera un bene che già possedeva, ma rinasce a una nuova esistenza.
Il servizio dell’autorità nella Chiesa dovrebbe
esprimersi in maniera analoga all’agire di Gesù nei confronti del cieco
nato. Coloro che sono rivestiti di autorità sono chiamati, con la
discrezione e non con la direzione, a incoraggiare i fratelli, affinché
ciascuno possa rintracciare il proprio nucleo originale, ossia quel
potere donato a ciascuno e che va posto a servizio di tutti.
Per operare in questa direzione è opportuno che
l’autorità lasci spazio a colui che serve. Quando l’autorità si tira
indietro, l’altro può tentare la propria responsabilità e accedere al
proprio cammino di libertà.
Un uso corretto, creativo ed educativo dell’autorità
sta nella capacità di coloro che la incarnano a togliersi di mezzo,
affinché l’altro sia quasi costretto a tirare fuori tutto il potenziale
di cui è capace nella relazione con la vita. Solo un’autorità che ha
tale coraggio è capace di conservare, condividere, permettere.
Note
1. S. Fausti, Ricorda e racconta il Vangelo. La
catechesi narrativa di Marco. Ancora, Milano 1990, 333.
2. S. Fausti, Ricorda e racconta il Vangelo,
339-340.
3. C.M. Martini, Il caso serio della fede.
Piemme, Casale Monferrato 2002, 143.
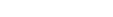 |
|
|
|