|
 |
 |
 |
 |
1.Viviamo
oggi in una società che è pluriculturale e multireligiosa,
ma anche, purtroppo, segnata da grande violenza e da un’incessante
strumentalizzazione delle religioni. La pace, laddove esiste, è
minacciata. Le religioni sono spesso accusate di fomentare l’odio e di
causare violenza. La nostra presenza qui ad Assisi vuole, al contrario,
impegnarci a mostrare che le religioni, ben lontano dall’essere un
problema, sono invece parte della soluzione auspicata per portare
armonia e pace nella società. Pertanto, spetta ai leaders
religiosi insegnare alle loro comunità a scoprire le ragioni più
profonde, basate sull’insegnamento delle rispettive tradizioni
religiose, per vivere pacificamente insieme. Le parole di Giovanni Paolo
II, nella storica Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace che
si tenne qui ad Assisi nel 1986, risuonano ancora con forza nelle nostre
orecchie poiché sono state parole profetiche. Egli invitò l’umanità a
seguire un sentiero comune. Invitò i leaders religiosi a
diventare strumenti di pace. Con parole forti egli mise in guardia i
capi religiosi: «Dobbiamo imparare a camminare insieme in pace e armonia
oppure andremo da un’altra parte e rovineremo noi stessi e gli altri»1.
2.
Per tanto tempo, molti credenti di diverse religioni hanno vissuto
lontano gli uni dagli altri. La Chiesa, con il Concilio Vaticano II,
ha invitato i cattolici a vivere pienamente la loro fede, esortandoli,
nello stesso tempo, al rispetto verso gli altri credenti e a costruire
legami di amicizia con persone di altre tradizioni religiose. Proprio
per approfondire la riflessione sulla fede della Chiesa, il Concilio
Vaticano II promulgò la Nostra Aetate, la Dichiarazione sulle
relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. La Dichiarazione
inizia riconoscendo che la Chiesa «nel suo dovere di promuovere l’unità
e la carità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo
esamina qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a
vivere insieme il loro comune destino». La dichiarazione Nostra
Aetate sottolinea il fatto che «i vari popoli costituiscono
infatti una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha
fatto abitare l’intero genere umano su tutta la faccia della terra e
hanno anche un solo fine ultimo, Dio»2. Nel suo Messaggio in
occasione della Giornata Mondiale per la Pace, Papa Benedetto XVI
ribadisce che: «Tutti gli uomini appartengono ad un’unica e medesima
famiglia. L’esaltazione esasperata delle proprie differenze contrasta
con questa verità di fondo. Occorre ricuperare la consapevolezza di
essere accomunati da uno stesso destino, in ultima istanza trascendente,
per poter valorizzare al meglio le proprie differenze storiche e
culturali, senza contrapporsi ma coordinandosi con gli appartenenti alle
altre culture»3.
3.
Oggi,
ogni credente si trova di fronte una prima, grande sfida:
approfondire la propria tradizione religiosa, non in maniera selettiva,
ma nella piena fedeltà alla propria tradizione religiosa. In altre
parole, oggi è urgente, per ogni comunità religiosa, dare una solida ed
integrale formazione ai suoi membri. La seconda sfida, per chi crede, è
incontrare i fedeli di altre tradizioni religiose in uno spirito di
reciproco rispetto, fiducia ed amicizia. Nell’incontrare altri credenti
non è assolutamente necessario ricercare i comuni denominatori nelle
diverse religioni. Lo scopo del dialogo interreligioso non è di arrivare
ad un accordo comune sulle dottrine nelle diverse tradizioni religiose.
Infatti, i credenti, nel loro incontro con gli altri, sono invitati a
capire le differenze fondamentali che esistono fra le religioni e devono
imparare a rispettarle. Dialogo interreligioso non significa ignorare,
sminuire la particolarità essenziale o distintiva di ciascuna religione.
La terza sfida è quella di promuovere una più stretta collaborazione per
creare una società più pacifica e armoniosa. Ciò vuol dire, in concreto,
combattere per la promozione della dignità di ogni persona attraverso
l’impegno nella giustizia. La tradizione cristiana insegna che ogni
essere umano è creato ad immagine e somiglianza di Dio. La Chiesa,
quindi, difende e promuove la dignità di ogni vita umana, dal
concepimento alla morte naturale.
Grazie alla propria esperienza maturata negli ultimi 40 anni, la Chiesa
cattolica ha scoperto le ragioni che hanno i credenti di diverse
religioni, per vivere insieme. Questa esperienza è stata, in generale,
positiva e costruttiva. La Chiesa, nel guidare i propri fedeli sul
cammino del dialogo, li aiuta anche a superare la tentazione di
indulgere al sincretismo e al relativismo, da una parte, e, dall’altra,
al fondamentalismo. Per la Chiesa, la ragione principale per il dialogo
con le altre religioni è la sua ferma ed inequivocabile adesione a Gesù
Cristo, nel quale l’amore di Dio per l’uomo si è concretamente
manifestato. Come ha spiegato Papa Benedetto XVI nella sua prima
Enciclica, Deus caritas est, Dio è amore, e questo amore
«consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la
persona che non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo
a partire dall’intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato
comunione di volontà arrivando fino a toccare il sentimento. Allora
imparo a guardare quest’altra persona non più soltanto con i miei occhi
e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il
suo amico è mio amico. Al di là dell’apparenza esteriore dell’altro
scorgo la sua interiore attesa di un gesto di amore, di attenzione»4.
4.
L’armonia deve essere coltivata e la pace accolta da tutti come un dono
di Dio
e costruita da ogni persona in ogni circostanza. Lavorare per la
promozione dell’armonia e della pace è un compito concreto per i
credenti. Infatti, gli antichi pregiudizi, la insufficiente conoscenza,
la mancanza di comprensione delle credenze e delle pratiche delle altre
religioni e il timore dell’altro, dovuto a tendenze egocentriche
dell’uomo, hanno spesso dominato le relazioni umane. Per questo, il
dialogo interreligioso non è sempre un obiettivo facile. Alcuni allora
esitano ad impegnarsi nel dialogo interreligioso; altri, già impegnati,
provano delusioni e si sentono scoraggiati. È importante non abbandonare
la speranza e non attendere che arrivi una crisi per cominciare a
costruire relazioni amichevoli fra credenti di diverse religioni. Noi
abbiamo sempre bisogno di rinnovarci. Dobbiamo compiere tutti gli sforzi
necessari per approfondire le reciproche fraterne relazioni attraverso
le differenze religiose, anche quando tali rapporti sono buoni.
L’opera di promozione del dialogo fra credenti di diverse religioni non
è e non deve essere considerata come un segno di debolezza da parte del
credente. La ragione dell’impegno nel dialogo interreligioso non è
l’ignoranza o l’insoddisfazione verso la propria tradizione religiosa.
Al contrario, ci si avvicina ad un altro credente perché si è fermamente
radicati nella propria tradizione religiosa. I credenti possono
divenire, – e l’esperienza mostra che attraverso la collaborazione
interreligiosa lo divengono –, un’importante forza nel promuovere
l’armonia e la pace nella società, sulla base di quei quattro pilastri
indicati da Papa Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris –
me ne ricordo ancora, sono trascorsi 43 anni, ero allora giovane
collaboratore del Pontefice –: la verità, la giustizia, l’amore e la
libertà.
5.
Prima
di essere una politica, la pace è uno spirito,
ed è, quindi, compito delle religioni educare alla pace attraverso la
purificazione della memoria, la riconciliazione e il perdono. Ritrovando
ragioni per vivere insieme, come abbiamo fatto lo scorso mese di luglio
a Mosca, all’incontro mondiale dei grandi leaders religiosi, le
religioni lanciano un invito a pensare e uno stimolo a volere la pace,
per lottare con coraggio contro le ideologie che rendono gli uomini
nemici fra loro: il fanatismo rivoluzionario, l’odio di classe,
l’orgoglio nazionalista, l’esclusivismo razziale, gli egoismi
commerciali, gli individualismi di persone o gruppi gaudenti e
indifferenti ai bisogni altrui5.
La
ricerca ostinata della pace, come quella di ogni altro bene umano, ha le
sue esigenze di pensiero e di azione, ispirate dal messaggio di amore
delle religioni per tutti gli uomini. Come un bambino fragile e
minacciato, la pace richiede molto amore. Ci vuole, dunque, un impegno
costante ed un’azione perseverante per trasformare la mentalità e gli
atteggiamenti e creare un’autentica cultura di pace ispirata dall’amore.
Viviamo senza dubbio in un’ora drammatica della storia del mondo. È
necessario, dunque, unire l’intelligenza, il coraggio e la sensibilità
di tutti per accrescere lo slancio di amore e di pace nel mondo. Bisogna
ricostruire la fiducia reciproca. E la fiducia non si acquista per mezzo
della forza e neppure si ottiene con belle dichiarazioni. La fiducia
bisogna meritarla con gesti e fatti concreti scaturiti dall’amore.
6.
La via della pace, infatti, comincia nel cuore dell’uomo,
nell’educazione a superare gli impulsi disordinati delle passioni, nella
pedagogia paziente che insegna a vincere questa lotta interiore
angosciosa e dolorosa contro una parte di noi stessi. Le religioni
aiutano l’uomo a non abbandonare questo campo interiore di battaglia e a
formare la sua coscienza. Infatti, quando la coscienza personale è
scomparsa, la pace internazionale viene gravemente minacciata. Questa
conquista dei valori fondamentali corrisponde alle più profonde esigenze
della persona e della sua crescita in umanità. L’uomo deve crescere
secondo tutte le dimensioni del suo essere, creato a immagine e
somiglianza di Dio, che è amore e sorgente inesauribile di amore per
ogni uomo affamato di pace, nel dinamismo dell’esistenza, nel dramma
delle sue scelte, nell’inquietudine del suo vissuto quotidiano, nella
mobilità della sua speranza, nel suo bisogno ansioso di comunione, nella
sua ricerca ostinata di verità e di fraternità, nella sua sete di
giustizia, nel suo sogno di bellezza, nella sua esigenza di libertà, nel
suo desiderio di coerenza, nella sua fame di amore.
7.
È questa la mia convinzione più intima: la pace è
certamente un dono di Dio, ma nello stesso tempo è anche una conquista
faticosa dell’uomo creato a sua immagine e somiglianza. L’uomo,
operatore di pace, ha bisogno di Dio per essere pienamente uomo di pace,
perché la pace è frutto dell’amore e Dio è la sua sorgente. Così, qui ad
Assisi, il nostro pensiero diventa preghiera con san Francesco:
«Signore, fammi uno strumento di pace. Fa’ che dove c’è odio, io porti
amore».
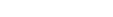 |