|
 |
 |
 |
 |
«Fate
a tutti la carità della verità». Questa frase attribuita tra gli altri
al beato don Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia paolina, è in
realtà comunemente usata e si può far risalire allo stesso apostolo
Paolo, quando, nella lettera agli Efesini, invita a vivere «secondo la
verità nella carità» (4,15). Tuttavia l’espressione, diventata ormai uno
slogan, esprime bene lo spirito del fondatore dei paolini e delle
paoline e la missione che sono chiamati a compiere nella Chiesa: una
missione di annuncio agli uomini del nostro tempo, all’interno
dell’odierna cultura della comunicazione, del Vangelo, di Cristo Maestro
che è via, verità e vita. Lo stesso don Alberione paragona questo
servizio per la verità e per il Vangelo alla carità verso i più poveri,
parafrasando le parole di Pietro allo storpio della porta Bella del
tempio (cfr. Atti 3,6): «Non ho né oro né argento, ma vi dono di quello
che ho: Gesù Cristo: Via, Verità, Vita». In questo breve articolo
vorremmo offrire una riflessione sull’attualità di «fare la carità della
verità», anche alla luce della prima enciclica di papa Benedetto XVI,
tutta incentrata sulla carità.
Due poli, carità e
verità
I due poli
dell’espressione, carità e verità, potrebbero sembrare antitetici e
prestarsi a interpretazioni opposte. Se si accentua il polo della carità
si corre il rischio di un facile irenismo che finisce col soffocare la
radicalità del Vangelo per adattarlo alle mode e alle opportunità del
momento. Un rischio ben presente oggi, con il trionfo del politically
correct, di una falsa forma di rispetto dell’altro basata sul
relativismo più assoluto: si finisce così per non avere più il coraggio
e la franchezza dello stesso Cristo Gesù e per stemperare e annacquare
la forza liberante del messaggio evangelico. Se però si accentua il polo
della verità si corre il rischio di non tener presente l’essere umano al
quale ci si rivolge e di comunicare non la verità liberante che è lo
stesso Cristo Gesù, ma la propria durezza di cuore, il proprio
attaccamento ai precetti e alle regole in quanto tali. Si rischia,
insomma, di comunicare una verità che è pura astrazione, snaturata nella
sua essenza, un’imposizione estrinseca e formale. Ricordiamo a questo
proposito le parole di Gesù: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non
l’uomo per il sabato» (Mc 2,27).
Carità e verità vanno
perciò sempre tenute insieme. E questo è possibile se siamo pienamente
radicati in Cristo, che è la rivelazione dell’amore del Padre («Dio
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna», Gv 3,16) ed è
egli stesso la verità (cfr. Gv 14,6). Lo scrive anche Benedetto XVI
nell’enciclica Deus caritas est: «Il contatto vivo con Cristo è
l’aiuto decisivo per restare sulla retta via: né cadere in una superbia
che disprezza l’uomo e non costruisce in realtà nulla, ma piuttosto
distrugge, né abbandonarsi alla rassegnazione che impedirebbe di
lasciarsi guidare dall’amore e così servire l’uomo. La preghiera come
mezzo per attingere sempre di nuovo forza da Cristo, diventa qui
un’urgenza del tutto concreta. Chi prega non spreca il suo tempo, anche
se la situazione ha tutte le caratteristiche dell’emergenza e sembra
spingere unicamente all’azione. La pietà non indebolisce la lotta contro
la povertà o addirittura contro la miseria del prossimo» (37).
Certamente il Papa si
riferisce in primo luogo all’azione caritativa intesa nel modo solito,
cioè come attenzione alle necessità materiali e alle sofferenze degli
esseri umani, ma il discorso vale anche per quella particolare forma di
carità che è il servizio alla verità. D’altra parte l’enciclica non è
estranea a questo tema, anche se non lo presenta esplicitamente. Come ha
scritto di recente monsignor Giampaolo Crepaldi, segretario del
Pontificio consiglio della giustizia e della pace, «non è possibile che
questo variegato mondo di espressioni, dirette e indirette, della
comunità ecclesiale faccia solo carità e non anche cultura della carità,
cultura sociale, cultura delle relazioni umane, cultura dell’assistenza,
cultura del malato, cultura dell’educazione, cultura del bisogno e così
via. Tocchiamo qui un punto fondamentale della purificazione della
giustizia, strettamente collegato con la dottrina sociale della Chiesa:
la fede e la carità attuano anche una “carità della verità” nei
confronti della ragione e della giustizia. Nella sua carità sociale la
comunità cristiana non può non essere anche un soggetto culturale. Dato
che la carità non è mai un agire per agire, ma un agire che porta con sé
dei significati, operando si cambia anche la mentalità, si induce a
riflettere in modo nuovo sui bisogni e sulle risposte ai bisogni stessi,
vengono suscitate ed alimentate inedite comprensioni capaci di orientare
l’agire caritativo stesso». Lo stesso esercizio tradizionale della
carità esige, insomma, una cultura, una mentalità, e in particolare
richiede la salvaguardia della piena verità sull’uomo, fatto non solo di
anima ma anche di corpo, creato a immagine e somiglianza di un Dio unico
che è comunione di tre persone, e dunque creato per l’amore, per la
relazionalità, per la comunione.
Monsignor Crepaldi
approfondisce la sua riflessione notando come «nella Deus caritas est
l’elemento della carità della verità è senz’altro presente e si fonda
teologicamente su questa affermazione: «Il Logos, la ragione
primordiale, è al contempo un amante con tutta la passione di un vero
amore» (n. 10), «Se il mondo antico aveva sognato che, in fondo, vero
cibo dell’uomo – ciò di cui egli come uomo vive – fosse il Logos, la
sapienza eterna, adesso questo Logos è diventato veramente per noi
nutrimento, come amore» (n. 13). Dio che è amore è anche verità, per
questo l’incontro con Lui «chiama in causa anche la nostra volontà e il
nostro intelletto» (n. 17). Il paragrafo 28 della Deus caritas est
è pieno di espressioni “visive”, ad indicare che la purificazione della
ragione è una forma di carità della verità. Ora si parla di “formazione
della coscienza”, che è, in fondo, un vedere meglio cosa fare; ora si
parla della “percezione delle vere esigenze della giustizia… anche
quando ciò contrastasse con l’interesse personale”, il che, ancora, è un
vedere con maggiore chiarezza; ora si dice che mediante la purificazione
della ragione le esigenze della giustizia diventano “più comprensibili”
e che la Chiesa lavora per “l’apertura dell’intelligenza” alle esigenze
del bene.
Servizio della
verità, un gesto d’amore
Il servizio della
verità è dunque una forma di carità, di amore concreto, un’opera di
misericordia. Ed è particolarmente importante oggi, nella società della
comunicazione, dove pur nel moltiplicarsi delle informazioni e dei
messaggi la verità stenta a farsi largo, soffocata com’è da pressioni di
parte, da nuove ideologie basate sul profitto. Ancora di più fatica ad
emergere la verità del Vangelo: «Da questa galassia di immagini e suoni,
emergerà il volto di Cristo? Si udirà la sua voce? Perché solo quando si
vedrà il suo volto e si udirà la sua voce, il mondo conoscerà la buona
notizia della nostra redenzione»1.
Prima di tutto bisogna
ricordare che il rispetto della verità è un presupposto fondamentale,
una regola di riferimento per tutti gli operatori della comunicazione
sociale, per i giornalisti in particolare. Nel Catechismo della
Chiesa cattolica leggiamo parole molto chiare: «Nella società
moderna i mezzi di comunicazione sociale hanno un ruolo di singolare
importanza nell’informazione, nella promozione culturale e nella
formazione. Tale ruolo cresce in rapporto ai progressi tecnici, alla
ricchezza e alla varietà delle notizie trasmesse, all’influenza
esercitata sull’opinione pubblica. L’informazione attraverso i
mass-media è al servizio del bene comune. La società ha diritto ad
un’informazione fondata sulla verità, la libertà, la giustizia e la
solidarietà: “Il retto esercizio di questo diritto richiede che la
comunicazione nel suo contenuto sia sempre vera e, salve la giustizia e
la carità, integra; inoltre, nel modo, sia onesta e conveniente, cioè
rispetti scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la
dignità dell’uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella loro
divulgazione” (Inter mirifica 5)» (2493-2494). Più avanti il
catechismo è ancora più esplicito: «“È necessario che tutti i membri
della società assolvano, anche in questo settore, i propri doveri di
giustizia e di carità. Perciò si adoperino, anche mediante l’uso di
questi strumenti, a formare e a diffondere opinioni pubbliche rette” (Inter
mirifica 8). La solidarietà appare come una conseguenza di una
comunicazione vera e giusta, e di una libera circolazione delle idee,
che favoriscono la conoscenza ed il rispetto degli altri. […] Proprio
per i doveri relativi alla loro professione, i responsabili della stampa
hanno l’obbligo, nella diffusione dell’informazione, di servire la
verità e di non offendere la carità. Si sforzeranno di rispettare, con
pari cura, la natura dei fatti e i limiti del giudizio critico sulle
persone. Devono evitare di cadere nella diffamazione» (2495.2497).
Questo rispetto della verità nella carità, cioè nell’attenzione alle
persone a cui ci si rivolge o a cui ci si riferisce, è addirittura
fissato nella legge italiana sulla stampa (n. 69/1963, art. 2): «È
diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela
della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto
della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti
dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie
che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori». Parole molto
chiare, che non sempre sono rispettate e non solo dai giornalisti, ma
anche da quei politici, imprenditori, ecclesiastici, che chiedono
giustamente il rispetto della verità dei fatti, ma vorrebbero al
contempo negare la libertà d’informazione e di critica, magari con la
scusa che “i panni sporchi si lavano in casa”. Non è nascondendo la
verità che si fa il bene delle persone. I mezzi di informazione hanno
invece una funzione di informazione, di denuncia, di approfondimento che
sono indispensabili perché una società sia davvero democratica. Non a
caso la prima mossa di ogni dittatore è quella di impadronirsi dei mezzi
di comunicazione.
Elementi costitutivi
della carità
Nell’enciclica Deus
caritas est il Papa si chiede a un certo punto quali sono gli
elementi costitutivi ed essenziali della carità cristiana ed ecclesiale,
così da non confonderla con l’attività di altre organizzazioni
assistenziali. Le risposte che egli enuclea mi sembrano adatte anche per
chi fa della comunicazione della verità attraverso i mezzi di
informazione il proprio particolare modo di esercitare la carità. Il
Papa indica tre elementi. Il primo è la competenza professionale unita
all’umanità: i cristiani «devono distinguersi per il fatto che non si
limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma si
dedicano all’altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che
questi sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla
preparazione professionale, a tali operatori è necessaria anche, e
soprattutto, la “formazione del cuore”: occorre condurli a quell’incontro
con Dio in Cristo che susciti in loro l’amore e apra il loro animo
all’altro» (31a). Il secondo elemento è l’indipendenza da partiti e
ideologie: «Ad un mondo migliore si contribuisce soltanto facendo il
bene adesso ed in prima persona, con passione e ovunque ce ne sia la
possibilità, indipendentemente da strategie e programmi di partito. Il
programma del cristiano – il programma del buon Samaritano, il programma
di Gesù – è “un cuore che vede”. Questo cuore vede dove c’è bisogno di
amore e agisce in modo conseguente» (31b). Infine, il terzo elemento è
la gratuità: «Chi esercita la carità in nome della Chiesa non cercherà
mai di imporre agli altri la fede della Chiesa. Egli sa che l’amore
nella sua purezza e nella sua gratuità è la miglior testimonianza del
Dio nel quale crediamo e dal quale siamo spinti ad amare. Il cristiano
sa quando è tempo di parlare di Dio e quando è giusto tacere di Lui e
lasciar parlare solamente l’amore». (31c)
Nella confusione di
suoni e immagini del mondo di oggi si potrà scorgere il volto di Cristo?
È un impegno al quale tutti noi cristiani e religiosi dobbiamo dare una
risposta, in particolare se impegnati nel mondo dei media. La risposta è
racchiusa nella frase “fare a tutti la carità della verità”, non
nascondendo le esigenze e la forza liberante del Vangelo e avendo il
coraggio di denunciare le ingiustizie e i soprusi contro i più deboli;
offrendo nello stesso tempo questa verità nella carità, cioè con quell’umanità,
quell’attenzione all’altro, quella gratuità che sono tipiche del
cristiano, che non odia nessuno ma tutti accoglie e con tutti cerca
sempre la via del dialogo.
*Direttore di Vita Pastorale. [Torna
al testo]
1. Giovanni Paolo II, Messaggio per la 36° Giornata
mondale delle comunicazioni sociali, p. 6. [Torna
al testo]
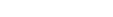 |