|
n. 6 giugno 2008

Altri articoli
disponibili
|
|
 English
English
Medicina e valori etici
Alcuni principi fondamentali della bioetica
di Angelo Amato
|
|
 |
 |
 |
 |
Ricercare nella verità
D a profano, ritengo che
una Facoltà universitaria di medicina1 abbia un duplice
compito: la trasmissione aggiornata del sapere nelle varie discipline,
mediante l’insegnamento e le pubblicazioni; e la ricerca per
l’acquisizione di sempre nuove conoscenze, metodologie e tecniche utili
a migliorare sempre più il servizio che il paziente si aspetta dal
medico.
Ed è con grande gioia e stupore che si assiste oggi
allo straordinario progresso della medicina in tutti i suoi campi. Non
sto ad elencare gli innumerevoli benefici della ricerca medica in questi
ultimi decenni. Tutti noi ne abbiamo esperienza positiva. Per questo noi
ringraziamo gli scienziati per questa loro straordinaria fatica fatta
con perseveranza, pazienza e amore al sapere e alla persona umana.
Munito di questo bagaglio tecnologico, il medico
imita un gesto tipico di Gesù, il quale passava per i villaggi guarendo
ogni sorta di infermità e di malanni. L’evangelista medico, san Luca (cf.
Col 4,14), dice al riguardo che la fama di Gesù si diffondeva sempre
più: "folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro
infermità" (Lc 5,15). A ragione, quindi, Gesù viene chiamato medico
delle anime e dei corpi.
Ci poniamo subito la domanda: come deve essere fatta
questa ricerca per essere veramente umana? Ogni ricerca, come ogni
azione umana, deve essere eticamente corretta. Come non si può separare
la politica dall’etica, così non si può separare la ricerca medica
dall’etica. Se la ricerca è un atto di apertura alla verità, la ricerca
eticamente corretta è un atto di apertura e di accoglienza non solo del
vero ma anche del bene. Il vero autentico è anche buono così come il
bene autentico è anche vero.
Nella ricerca, oggi più che mai, c’è bisogno di
questo approccio eticamente corretto, soprattutto nel campo della
biotecnologia. Non si può negare come - nella cosiddetta cultura
postmoderna - si abbia sfiducia nella verità. Non ci sarebbe una verità,
ma solo opinioni tutte ugualmente valide, anche se sganciate dal vero e
dal bene e contraddittorie tra di loro. Di conseguenza, non ci sarebbe
più una natura data, da rispettare, ma solo materiale genetico,
manipolabile a piacimento. In tal modo l’essere umano, ridotto a
prodotto biologico, non è più inviolabile, non è più un mistero da
rispettare nella sua trascendenza.
Il compito del magistero della Chiesa è quello di
offrire un quadro di riferimento veritativo che promuova la ricerca del
bene dell’uomo, senza farla naufragare nella falsità e nella disumanità.
Ma c’è una difficoltà: quella, cioè, di determinare
ciò che è naturale da ciò che è culturale. Al riguardo, si danno due
categorie interpretative antagoniste, quella cristiana della sacralità
della vita e quella postmoderna della disponibilità della medesima.
Nella prospettiva della sacralità della vita
l’imperativo assoluto è la difesa della vita, considerata sempre e
comunque indisponibile.
Nella prospettiva della disponibilità, invece, la
norma fondamentale sarebbe la difesa della cosiddetta "qualità" della
vita. La qualità della vita, non la vita, sarebbe l’assoluto bioetico.
Ma tale qualità non dipenderebbe da riferimenti etici, bensì
dall’arbitrio individuale e soprattutto dalla biotecnologia. È la
biotecnologia che si arroga oggi il diritto-dovere di fornire il metro
di valutazione della identità. La difesa dell’identità umana è, quindi,
il cuore del problema bioetico: <<"Infatti, ciò che le nuove possibilità
tecniche della biomedicina giungono a mettere in questione, prima ancora
che la sacralità o la dignità della vita, è l’identità stessa
dell’essere dell’uomo, prima come identità biologica, organica, e poi,
come identità antropologica. Qualora essa cada, qualora, cioè, cada la
nostra identità, cade ogni ulteriore possibilità di problematizzazione
etica. La norma fondamentale della bioetica è dunque la difesa
dell’identità. È solo a partire dalla difesa dell’identità che è
possibile operare per la difesa della dignità della vita".2
La bioetica garantisce la difesa dell’identità sia
mediante la tutela generale della fisicità e del diritto a un patrimonio
genetico non manipolato; sia mediante l’imposizione di specifici doveri,
primo tra i quali la non alterazione dell’identità di altri soggetti sia
viventi, attraverso la commercializzazione degli organi, che futuri,
attraverso il divieto della clonazione. Il principio della difesa
dell’identità opera anche in numerosi altri piani rilevanti
bioeticamente: "È il caso dell’aborto volontario che va ritenuto
illecito come forma di negazione aprioristica dell’identità umana del
nascituro; il caso delle diagnosi prenatali, quando vengano finalizzate
a favorire aborti selettivi".3
A questo riguardo vorrei citare l’ottimo articolo dei
prof. Giovanni Neri e Angelo Serra, sulla diagnosi prenatale oggi,
pubblicato dalla rivista "La Civiltà Cattolica".4 Giustamente
gli autori fanno notare un paradosso della diagnosi preimpianto, citando
il biologo molecolare Craig Venter, che ha annunciato di aver completato
l’analisi del proprio genoma ossia dell’intera sequenze del proprio DNA.
Non ha esitato a riconoscere che in questa sequenza sarebbero presenti
numerose varianti associate a rischio di alcolismo, comportamento
antisociale, tabagismo, abuso di sostanze, infarto, malattia di
Alzheimer: "Il minimo che se ne possa concludere – dicono giustamente
gli autori – è che se queste varianti genetiche fossero state
riscontrate in una diagnosi preimpianto, il grande scienziato Venter non
sarebbe mai nato".5
L’uomo biotecnologico
Qui si apre l’importante capitolo del passaggio
dall’uomo creatura di Dio all’uomo biotecnologico creatura dell’uomo.
Nel contesto della postmodernità, che ha detronizzato l’idea di natura,
le biotecnologie hanno assunto una importanza tutta particolare: "Nelle
loro pressoché illimitate possibilità di ricostruire e reinventare il
corpo, spostare Dna tra specie diverse, cancellare il passato genetico,
e pre-programmare il futuro genetico, i nuovi genetisti danno alla
biologia della vita un nuovo spirito proteiforme. La vita, a lungo
pensata come opera di Dio, e più recentemente vista come un processo
casuale guidato dalla mano invisibile della selezione naturale, viene
ora ripensata e re-immaginata come uno strumento artistico dalle
illimitate possibilità".6
Si tratta di un cambiamento significativo
dell’identità dell’uomo: il passaggio, cioè, da una mentalità
creazionistica ad una mentalità tecno-efficientista determinata dalla
rivoluzione biotecnologica, con il risultato di considerare l’uomo non
più come una creatura di Dio o come un risultato dell’evoluzione
naturale, ma come un prodotto della biotecnologia.
La rivoluzione biotecnologica ha dischiuso la
possibilità di modificare la stessa natura dell’uomo. Il testo genetico,
il DNA, una volta decodificato, porta inevitabilmente a superare i
limiti impostici dalla natura. Se Galileo aveva decifrato il linguaggio
che Dio ha usato per creare il mondo, oggi si sta decifrando il
linguaggio che Dio ha usato per creare la vita.
Alcuni biologi e filosofi hanno già annunciato il
congedo da Dio e dalla sua presenza nel mondo in nome della tecnica, che
avrebbe tolto la parola alla rivelazione divina. In tal modo si intende
ghettizzare la fede e la teologia, assolutizzando il ruolo della scienza
e della tecnologia.
L’uomo sarebbe ridotto alle sole connessioni
sinaptiche, per cui le trasmissioni degli impulsi da un neurone
all’altro permetterebbero l’emergere del senso di continuità necessario
alla costituzione dell’identità personale. Insomma tutto quanto avviene
nell’uomo sarebbe solo espressione di circuiti neuronali, generatori di
fenomeni come ragione, emozione, immaginazione e spiritualità. In altre
parole si azzera la coscienza e il libero arbitrio. Anche la teoria del
neodarwinismo – che predomina nelle trasmissioni cosiddette scientifiche
ma fortemente ideologizzate dei massmedia – concepisce gli esseri umani
come animali evoluti. Tutto ciò porta a negare la libertà e l’amore, che
sono le attitudini più specifiche dell’uomo.
La neurofilosofia pretende, poi, di spiegare la sfera
dei sentimenti tramite la chimica; le qualità morali e personologiche
tramite la neurologia; e la realtà spirituale tramite la fisica. La tesi
secondo cui la chimica e la fisica spiegherebbero i processi spirituali
ha spinto il microbiologo americano Dean Hamer a sostenere che il senso
del divino avrebbe una sua base nel patrimonio genetico e che la
spiritualità per gli adulti non sarebbe altro che un istinto biologico
così come l’allattamento per i bambini.7
Un’ulteriore affermazione della mentalità
tecno-efficientista sostiene che sarebbe possibile sia umanizzare i
meccanismi artificiali sia robotizzare la sensibilità e la coscienza
dell’uomo: "La rivoluzione biotecnologica sta cambiando la tecnologia
del nostro corpo, mentre quella robotica finirà per produrre esseri che
sono dei robot, non solo, ma esseri viventi artificiali. La conseguenza
è che la distinzione fra noi e il robot sparisce: le macchine saranno
come esseri umani e gli esseri umani come macchine".8
Siamo al cosiddetto transumanesimo di Kevin Warwick,
professore di cibernetica all’università inglese di Reading, che crede
nella trasformazione della razza umana in tanti cyborg. Per il
transumanesimo l’uomo non sarebbe il prodotto finale della evoluzione,
ma solo l’inizio, ponendo l’enfasi sulle potenzialità enormi del
divenire dell’uomo. Si tratta di una riprogettazione tecnologica
dell’umanità, che avrebbe come finalità l’eliminazione del processo di
invecchiamento, della limitazione dell’intelletto umano e della
sofferenza in generale.
Altre problematiche derivano dal cosiddetto "uomo
on-line", che ha dilatato in modo inimmaginabile le capacità
quantitative di elaborazione, di trasmissione e di conservazione delle
informazioni, riducendo allo stesso tempo la sua capacità di
valutazione; dall’uomo "chimera", e cioè degli incroci biologici
uomo-animale; dall’uomo fotocopia mediante il processo biotecnologico
della clonazione, apertamente ripudiato da una dichiarazione
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’8 marzo del 2005.
Il richiamo etico
Come si vede queste innovazioni biotecnologiche
implicano una ineludibile domanda etica, dal momento che le sue
applicazioni fanno sì che la natura non sia più considerata come
immutabile in se stessa ma manipolabile e modificabile dall’intervento
tecnico. Si assiste al passaggio della tecnica come strumento, a tecnica
come soggetto della storia, con il suo strapotere sull’uomo e sulla
natura.
Di fronte a ciò il richiamo all’etica non solo è
utile ma necessario. L’etica non è la proibizione della ricerca, dal
momento che l’uomo è sempre aperto alla comprensione ogni volta più
profonda della verità. Essa è piuttosto un sostegno della ragione per
non umiliare l’umanità dell’essere uomo e per non eliminare i giudizi
della sua coscienza morale nel perseguire la bontà esistenziale della
sua vita. L’uomo, cioè, è più grande delle sue conquiste tecniche, che
mai possono cogliere ed esaurire tutto il dinamismo spirituale e morale
della sua libertà e della sua coscienza. Si tratta cioè di stabilire dei
limiti provenienti dalla ragione illuminata dalla fede.
Affrontando un tema tanto ampio e complesso, è
necessario anzitutto delimitarne i contorni. In questa sede, infatti,
non si tratta di offrire un intervento circa i singoli problemi
scientifici, che sono competenza degli esperti; non si tratta neppure di
una presentazione della valutazione morale delle singole tecniche
biomediche, che costituiscono l’ambito proprio degli scienziati
cristiani e dei teologi moralisti.
Si intende invece presentare alcuni principi
fondamentali della bioetica a partire dal Magistero della Chiesa, e cioè
del Concilio Vaticano II (Costituzione Gaudium et spes), di
Giovanni Paolo II (Catechismo della Chiesa Cattolica, Enciclica
Evangelium vitae), di Benedetto XVI (Encicliche Deus caritas
est e Spe salvi) e della Congregazione per la Dottrina della
Fede (Istruzione Donum vitae), al fine di rispondere ad alcune
critiche diffuse nella società contemporanea, delineando al contempo
l’apporto positivo che anche sul piano umano e della legge naturale la
dottrina della Chiesa offre alla comunità scientifica impegnata sulle
nuove frontiere delle scienze biomediche.
Do spazio qui ad alcune obiezioni ricorrenti circa il
rapporto tra magistero della Chiesa e la ricerca scientifica.
La morale e l’annuncio di Gesù Cristo
Il Magistero della Chiesa, secondo il giudizio di
molti, parlerebbe troppo di morale, con un linguaggio molte volte
autoritario e con proposte difficili da seguire.
Di fronte a questa obiezione, si deve anzitutto
affermare che il cuore del cristianesimo, e quindi anche dell’annuncio
della Buona Novella, non è la morale, ma la persona di Gesù Cristo, così
come ha recentemente ricordato nella sua prima Enciclica papa Benedetto
XVI: "All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una
grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che
dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva" (Deus
caritas est, 1).
Cristo, infatti, rivela all’uomo in pienezza il suo
mistero e la sua vocazione: "In realtà solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo
uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che
è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore
svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua
altissima vocazione" (Gaudium et spes, 22). Di conseguenza, la
comunione con il Signore - nella fede, nei sacramenti e nella preghiera
- comporta anche un nuovo modo di pensare e di vivere, una scelta di
vita secondo il Vangelo. La Chiesa, quindi, annuncia Gesù Cristo e,
all’interno di questo contesto cristologico ed antropologico, presenta
la dottrina morale, che scaturisce dall’incontro con il Signore.
La morale e la scienza
Sovente viene anche avanzata una critica al Magistero
della Chiesa, accusato di impedire il progresso e d’interferire
nell’autonomia della scienza. In tal modo si rischierebbe una
contrapposizione tra fede e ragione. Al riguardo si deve affermare che
la Chiesa è stata ed è sempre favorevole al progresso della scienza.
Prova ne sia il fatto che le Università sono nate nel seno della stessa
Chiesa, che da secoli si impegna nel campo della formazione e della
ricerca, gestendo Centri universitari in tutto il mondo, come è questa
stessa prestigiosa Istituzione. Convinta che tra fede e ragione non c’è
contrapposizione, dal momento che sono le due ali per volare verso la
verità, la Chiesa riconosce l’autonomia della scienza, ma ribadisce
l’importanza di rispettare le norme etiche che scaturiscono dalla natura
umana.
In merito, conservano ancora attualità le parole del
Vaticano II, quando nella Costituzione Apostolica Gaudium et spes
(n. 36) afferma: "Se per autonomia delle realtà terrene si vuol dire che
le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che
l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di
una esigenza d'autonomia legittima: non solamente essa è rivendicata
dagli uomini del nostro tempo, ma è anche conforme al volere del
Creatore... Se invece con l'espressione "autonomia delle realtà
temporali" si intende dire che le cose create non dipendono da Dio e che
l'uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore, allora a nessuno che
creda in Dio sfugge quanto false siano tali opinioni. La creatura,
infatti, senza il Creatore svanisce" (n. 36).
La Chiesa afferma l’importanza della formazione
scientifica e tecnica, accompagnata da una dimensione etica, la quale
garantisca che il progresso non distrugga l’uomo, ma favorisca il suo
bene. Nell’intervista prima del suo viaggio in Germania (5/8/2006)
Benedetto XVI affermava: "Il progresso può essere progresso vero solo se
serve alla persona umana e se la persona umana stessa cresce… Penso che
il vero problema della nostra situazione storica sia lo squilibrio fra
la crescita incredibilmente rapida del nostro potere tecnico e quella
della nostra capacità morale, che non è cresciuta in modo proporzionale.
Perciò la formazione della persona umana è la vera ricetta, la chiave di
tutto direi, e questa è anche la nostra via... Noi abbiamo bisogno di
due dimensioni: ci vuole allo stesso tempo la formazione del cuore - se
così posso esprimermi - con cui la persona umana acquisisce dei
riferimenti e impara così anche ad usare correttamente la tecnica, che
pure ci vuole".
Il secondo principio, quindi, a cui si attiene la
Chiesa è il riconoscimento della giusta autonomia della scienza e della
tecnica, ritenendo tuttavia che esse, per poter essere al servizio della
persona, debbano seguire i criteri fondamentali della moralità.
La dignità di ogni essere umano
Questo principio spesso si scontra con la critica
secondo la quale nel campo della bioetica il Magistero dice troppi "no",
dichiarando illeciti numerosi interventi che sono tecnicamente possibili
e in parte promettenti. Nell’assumere queste prese di posizione, invece,
la Chiesa è guidata dalla difesa della dignità di ogni vita umana. "La
vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta l’azione
creatrice di Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il
Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo
inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a
sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente" (Donum
vitae, Introduzione, n. 5).
Ciò vale anche per l’embrione umano: "Il frutto della
generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a
partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato
che è moralmente dovuto all’essere umano nella sua totalità corporale e
spirituale. L’essere umano va rispettato e trattato come una persona fin
dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono
riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto
inviola-bile di ogni essere umano innocente alla vita" (Donum vitae,
I, 1). Tale posizione ha un solido fondamento scientifico e filosofico:
sono, infatti, le stesse conclusioni della scienza sull’embrione umano a
fornire "un’indicazione preziosa per discernere razionalmente una
presenza personale fin da questo primo comparire di una vita umana: come
un individuo umano non sarebbe una persona umana?" (ivi). È
pertanto moralmente accettabile ogni intervento che rispetti la vita e
l’integrità dell’embrione, non comporti per lui rischi sproporzionati e
sia finalizzato alla sua guarigione, al miglioramento delle sue
condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale (ad esempio:
la diagnosi prenatale se non contempla l’eventualità dell’aborto;
interventi con finalità terapeutica, ecc.).
Al contrario, è moralmente illecito ogni intervento
che non rispetti la vita e l’integrità dell’embrione (esempi: diagnosi
prenatale quando contempli l’eventualità di provocare un aborto; pillola
abortiva, pillola del giorno dopo, ecc.), lo produca con una intenzione
selettiva (ad esempio: secondo il sesso) oppure lo sfrutti come
"materiale biologico" (esempio: creazione di embrioni per ottenere
cellule stamina-li embrionali, con la conseguente distruzione dei
medesimi embrioni; anche se l’intenzione può essere buona, vale il
principio che il fine non giustifica i mezzi; occorre continuare la
ricerca sulle cellule staminali adulte - del resto molto più
promettente).
Giovanni Paolo II, nell’Enciclica Evangelium vitae
affermava al riguardo: "La vita umana, dono prezioso di Dio, è sacra
e inviolabile e per questo, in particolare, sono assolutamente
inaccettabili l'aborto procurato e l'eutanasia; la vita dell'uomo non
solo non deve essere soppressa, ma va protetta con ogni amorosa
attenzione; la vita trova il suo senso nell'amore ricevuto e donato, nel
cui orizzonte attingono piena verità la sessualità e la procreazione
umana; in questo amore anche la sofferenza e la morte hanno un senso e,
pur permanendo il mistero che le avvolge, possono diventare eventi di
salvezza; il rispetto per la vita esige che la scienza e la tecnica
siano sempre ordinate all'uomo e al suo sviluppo integrale; l'intera
società deve rispettare, difendere e promuovere la dignità di ogni
persona umana, in ogni momento e condizione della sua vita" (n. 81).
In questo senso si comprende anche il terzo
principio, secondo il quale i "no" della Chiesa a certe pratiche sono in
realtà un grande "sì" alla dignità di ogni essere umano, soprattutto di
coloro che non hanno voce, che sono tra i più vulnerabili, che non
vengono difesi da nessuno.
Il valore del matrimonio e dell’amore coniugale
In questo orizzonte si delinea anche la critica
secondo la quale il Magistero della Chiesa, essendo contrario alla
fecondazione in vitro, non ha compassione per le coppie sterili o altre
persone non sposate che desiderano avere un figlio e potrebbero averlo
tramite le tecniche di fecondazione in vitro…
In nome della salvaguardia e della promozione della
dignità intangibile di ogni essere umano, invece, la Chiesa ha
compassione per le coppie sterili e incoraggia le ricerche finalizzate a
ridurre la sterilità umana. Gli sposi che, dopo aver esaurito i
legittimi ricorsi alla medicina, soffrono di sterilità, "possono
mostrare la loro generosità adottando bambini abbandonati oppure
compiendo servizi significativi a favore del prossimo" (CCC,
2379).
La Chiesa ritiene quindi lecito ogni intervento
medico che non è sostitutivo dell’atto coniugale, ma si configuri "come
una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo
naturale" (Donum vitae, II, 6).
Conseguentemente, essa è contraria alle tecniche che
provocano una dissociazione dei genitori, con l’intervento di una
persona estranea alla coppia (dono di sperma o di ovocita, prestito
dell’utero). Le tecniche di fecondazione eterologa ledono il diritto del
figlio a nascere da un padre e da una madre conosciuti da lui e tra loro
legati dal matrimonio. Tradiscono il diritto esclusivo degli sposi a
diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro. Il "no" della
Chiesa alla fecondazione eterologa, quindi, è un "sì" al matrimonio e
alla famiglia, cellula della società.
Ugualmente, la Chiesa è anche contraria alla
fecondazione artificiale omologa, che, oltre ad essere sempre collegata
con la distruzione di numerosi embrioni, dissocia l’atto sessuale
dall’atto procreatore. L’atto che fonda l’esistenza del figlio non è più
un atto con il quale due persone si donano l’una all’altra, bensì un
atto che "affida la vita e l’identità dell’embrione al potere dei medici
e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull’origine e sul
destino della persona umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé
contraria alla dignità e all’uguaglianza che dev’essere comune a
genitori e figli" (Donum vitae, II, 5). Il "no" della Chiesa alla
fecondazione artificiale omologa, quindi, è in realtà un "sì" all’amore
coniugale. Secondo la volontà di Dio, il figlio deve essere il frutto di
un atto di amore e non di una procedura tecnica. Infatti, il figlio ha
il diritto di essere "il termine e il frutto di un atto coniugale in cui
gli sposi possono farsi cooperatori con Dio per il dono della vita a una
nuova persona" (Donum vitae, II, 5).
La produzione artificiale di embrioni, del resto, ha
creato una serie di ulteriori e gravissimi problemi etici: ad esempio,
quello del congelamento di embrioni umani, della distruzione dei
medesimi in molti Paesi dopo alcuni anni, della loro strumentalizzazione
per scopi commerciali o di ricerca… Il dilemma etico circa la sorte
degli embrioni congelati fa vedere la gravità della problematica della
produzione artificiale di embrioni. In questo orizzonte di problemi di
difficile soluzione, i "no" della Chiesa alle diverse tecniche di
fecondazione artificiale sono in realtà un grande "sì" alla dignità del
matrimonio e dell’amore coniugale, che non può essere sostituito dalla
tecnica.
La Chiesa al servizio della società
Affermando questi principi fondamentali, ci si avvede
come la Chiesa si ponga, in nome di Cristo, al servizio della società
umana. Il primo compito dei Pastori, pertanto, è di annunciare il
Vangelo di Gesù Cristo e quindi anche il Vangelo della vita (la dignità
e i diritti di ogni essere umano) e il Vangelo dell’amore (il valore e i
diritti del matrimonio e della famiglia). Un secondo e non meno
impegnativo compito è costituito dall’impegno, secondo le possibilità di
una società democratica e anzitutto tramite i laici impegnati nella vita
politica, per la promulgazione di leggi giuste ed eque oppure per
l’abrogazione di leggi ingiuste.
Al riguardo vale il seguente principio fondamentale:
"Compito della legge civile è assicurare il bene comune delle persone
attraverso il riconoscimento e la difesa dei diritti fondamentali, la
promozione della pace e della pubblica moralità. In nessun ambito di
vita la legge civile può sostituirsi alla coscienza né può dettare norme
su ciò che esula dalla sua competenza; essa deve talvolta tollerare in
vista dell'ordine pubblico ciò che non può proibire senza che ne derivi
un danno più grave. Tuttavia i diritti inalienabili della persona
dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile
e dell'autorità politica, perché tali diritti dell'uomo non dipendono né
dai singoli individui né dai genitori e neppure rappresentano una
concessione della società e dello Stato: "appartengono alla natura umana
e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso
origine". Fra tali diritti fondamentali bisogna a questo proposito
ricordare: 1. il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere
umano dal momento del concepimento alla morte; 2. i diritti della
famiglia e del matrimonio come istituzione e, in questo ambito, il
diritto per il figlio a essere concepito, messo al mondo ed educato dai
suoi genitori" (Donum vitae, III).
Impegnandosi in questo senso, la Chiesa non impone
alla società una morale "cattolica", ma offre un prezioso servizio
all’umanità e difende quei valori che sono accessibili alla ragione e
quindi condivisibili da tutti gli uomini di buona volontà. Oltre ad
annunciare la Buona Novella, la Chiesa, attraverso gli strumenti
democratici e anzitutto i laici impegnati nella vita politica, cerca
quindi di promuovere legislazioni giuste nel campo della bioetica.
Questo impegno è un grande "sì" ad un vero umanesimo. Oggi pare molto
importante ribadire con forza che dietro ogni "no" del Magistero della
Chiesa nel campo della bioetica rifulge, nella fatica del discernimento
tra il bene e il male, un grande "sì" alla dignità di ogni singolo
essere umano e al valore insostituibile del matrimonio tra un uomo e una
donna: un "sì" che è riconoscibile non solo ai credenti, ma anche a
coloro che con la ragione cercano la verità.
Angelo Amato
Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede
Piazza Città Leonina, 1 - 00193 Roma
NOTE
1. Conversazione tenuta agli studenti
della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma il 10 aprile 2008. Si tratta di problematiche altamente discusse e
attuali oggi e alle quali anche le consacrate sono chiamate a dare il
loro contributo di conoscenza e di testimonianza.
2. I. SANNA, L’identità aperta,
Queriniana, Brescia 2006, 161.
3. Ibidem, 161.
4. G. NERI-A. SERRA,
"La
diagnosi prenatale oggi",
in La Civiltà Cattolica, 158 (2007) IV, 453-463.
5. Ibidem, 459.
6. I. SANNA, L’identità aperta,
164.
7.Ibidem, 170.
8. Ibidem, 171.
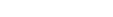 |
|
|
|