|
 |
 |
 |
 |
L'acqua
è vita, è sorgente di vita. Senz’acqua non c’è vita: come tutti
sappiamo, la prima immagine che si ha dello “Spirito di Dio”, nella
Bibbia, è quella del vento divino che spira sulle acque primordiali del
cosmo.
Come ha scritto Riccardo Petrella,
l’acqua ha dato il nome del colore del nostro pianeta. Se il pianeta
Marte è chiamato “pianeta rosso”, la Terra è il pianeta blu perché,
vista dall’alto, dalle navicelle spaziali, essa appare come una palla
blu sospesa nel cielo, ricoperta come è dall’acqua per circa il 72%
della sua superficie globale.
Con l’aria e la luce del sole, l’acqua
è uno dei tre elementi senza i quali non possiamo sopravvivere. L’acqua
è, quindi, un bene comune dell’umanità. Da dove nasce la carenza
d’acqua? Secondo alcune ricerche, la siccità dipende da quattro fattori:
cambiamento degli ecosistemi derivante dalle attività umane; aumento
demografico; crescita dei consumi pro-capite; inquinamento. La somma di
queste pressioni sta portando in rosso il bilancio idrico del pianeta.
Oggi 80 Paesi, con il 40% della popolazione mondiale, si trovano in una
situazione di carenza d’acqua.
E il controllo delle sorgenti sta
diventando motivo di tensione internazionale sempre più forte: l’acqua
rischia di essere causa di guerra in varie aree del pianeta, a
cominciare dal Medio Oriente (cfr. Vandana Shiva).
A rendere drammatico il quadro si
aggiungono dati che raccontano che dei 2,7 miliardi di poveri (su 6
miliardi), 1,5 sono senza accesso all’acqua potabile sana; poi la
gravità dei processi di devastazione dell’ecosistema Terra, in
particolare delle risorse idriche (inquinamento e contaminazione dei
fiumi, dei laghi, delle falde sotterranee, piogge acide, svuotamento e
ingorgo delle falde, salinizzazione); infine i cambiamenti climatici, le
inondazioni e siccità.
Oggi l’acqua è diventata un grosso
affare per le multinazionali, che vedono in essa le potenzialità per un
mercato sconfinato. La privatizzazione dei servizi idrici è il primo
passo verso la privatizzazione dell’acqua. Aprire ai mercati può
diventare pericoloso, in quanto l’acqua è una risorsa insostituibile per
l’uomo.
Esistono almeno due ordini di ragioni
che fanno dubitare che i gestori dell’acqua non potranno influenzare i
prezzi del mercato dei servizi idrici. In primo luogo, la “produzione” e
il trasporto dell’acqua richiedono investimenti talmente elevati da
farne un esempio di monopolio naturale. Infatti, già ora il mercato
dell’acqua è dominato da un esiguo numero di multinazionali. Si pensi a
Vivendi che estende il suo impero su 120 Paesi del mondo, oppure alla
Nestlé che vende diversi tipi di acqua minerale, come l’acqua Terrier,
la Vittel, l’acqua Vera, la S. Bernardo, la S. Pellegrino, l’acqua
Panna, la Levissima, la Pejo, la Recoaro.
In secondo luogo, l’uso dell’acqua non
implica necessariamente le modalità del suo impiego: anzi, per
l’economia dei costi i servizi, all’interno di una stessa impresa, vanno
integrati. Anche la Banca Mondiale si è espressa a favore di questa
necessità. Una tale situazione potrebbe causare numerosi danni e
inconvenienti: ad esempio, la stessa acqua potrebbe essere usata per il
lavaggio di minerali e per l’irrigazione.
Forse non siamo ancora sufficientemente
consapevoli della gravità della situazione attuale. Vandana Shiva è
drastica: «La crisi dell’acqua è la dimensione più pervasiva, più grave
e meno visibile della devastazione ecologica della terra (…). L’acqua è
la matrice della cultura, la base della vita. In arabo, in urdu e in
indostano si chiama ‘ab’; ‘abad raho’ è un augurio di
prosperità e abbondanza. Il nome stesso dell’India deriva dal grande
fiume Indo».
Acqua: diritto o
bisogno?
La differenza tra diritto e bisogno è
importante. Sostenere che l’accesso all’acqua è un diritto significa
riconoscere che fa parte della responsabilità della collettività
assicurare le condizioni necessarie per garantire il diritto a tutti.
Concretamente, è compito delle autorità pubbliche (locali, regionali,
nazionali, internazionali…) il compito/dovere di mobilitare le risorse,
soprattutto finanziarie, adeguate alla soddisfazione del diritto. La
realtà è ben lontana da quella che dovrebbe essere: ad esempio, in
Italia, sesta potenza economica mondiale, circa il 70% delle popolazioni
delle regioni del Mezzogiorno non ha un accesso all’acqua potabile in
quantità sufficiente su base regolare.
Perché qualcuno pensa all’acqua come
bisogno e non come diritto? Perché c’è un preoccupante tentativo di
passare da una “cultura dei diritti” a una “cultura dei bisogni” in
quanto, se i diritti sociali diventano revocabili, nessun diritto
resterebbe accordato per sempre e vincerebbero i bisogni “reali”, quelli
espressi nel e dal mercato in termini monetari.
A chi appartiene l’acqua? Se è uno
degli elementi naturali e insostituibili alla vita, essa dovrebbe essere
considerata un bene comune “appartenente” a tutti gli esseri viventi, e
in particolare all’umanità. L’acqua non è res nullius. Le società
umane hanno generalmente considerato l’acqua come un “patrimonio”
comune, ma non sono arrivate a pensarla come un bene comune a livello
mondiale. Il riconoscimento dell’acqua come “bene comune” non ha
oltrepassato i limiti delle frontiere degli Stati e del principio di
sovranità nazionale.
Perciò possiamo evidenziare l’emergenza
di due nuove tendenze: da una parte quella che va verso il
riconoscimento dell’acqua, dell’aria, della terra e dell’energia solare
come beni comuni mondiali. Essa si fonda su una triplice matrice
culturale: quella religiosa, legata alla tradizione cristiana,
universalista e terzomondista e anche alle tradizioni eco-centriche e
non violente indiane, africane…; quella ecologica, con le sue varianti
(ecologia politica, deep ecology, eco-femminismo, sviluppo
sostenibile; quella sociale, rappresentata dalla lotta dei contadini per
il diritto alla Terra, dall’opposizione agli OGM, dal rifiuto della
brevettabilità degli organismi viventi, dall’opposizione alla
costruzione di grandi dighe.
L’altra tendenza è quella della
“petrolizzazione” dell’acqua, che si è affermata soprattutto a partire
dagli anni ’80. Essa considera la società come un insieme di transazioni
di scambio di beni e servizi, e il valore di un bene è determinato dal
suo contributo alla creazione di plusvalore per il capitale. L’impresa e
l’investimento privato sono posti come il motore principale della
creazione della ricchezza: l’acqua deve essere trattata come una merce
che si vende e si compra in funzione del prezzo del mercato. Così
l’acqua apparterrebbe a chi investe, a chi prende a carico i costi per
assicurarne la captazione, l’epurazione, la distribuzione, la
manutenzione, il riciclaggio.
Secondo questa tendenza, a partire dal
momento che c’è un intervento umano, e quindi un costo per trasformare
le acque in acqua potabile o per l’irrigazione, l’acqua cesserebbe di
essere un bene comune naturale per diventare un bene economico, oggetto
di scambi e di appropriazione privata. Chi sostiene questa posizione,
ritiene che i mali del settore dell’acqua avrebbero soprattutto origine
nel fatto che l’acqua costa poco o quasi nulla per chi la consuma e
quindi ne usa senza limiti. L’imposizione di un prezzo di mercato,
secondo il duplice principio del “chi consuma paga” e “chi inquina
paga”, corrispondente ai costi effettivi totali sopportati dal
produttore e dal distributore, più un margine convenevole di profitto,
eliminerebbe una tale situazione e assicurerebbe una gestione
“economica” ottimale della risorsa.
Imporre un prezzo significa anche
privatizzare i servizi d’acqua e liberalizzarli, come sta accadendo in
un numero sempre maggiore di Paesi del mondo, dove assistiamo a
un’ondata di privatizzazione dei servizi di distribuzione dell’acqua e
di trattamento delle acque reflue.
Per una politica
alternativa dell’acqua. Come impegnarsi?
L’accesso all’acqua, nella quantità e
qualità sufficiente alla vita, deve essere riconosciuto come un diritto
costituzionale umano e sociale. I meccanismi di mercato non sono
adeguati a gestire il diritto alla vita: non è detto che il costo
dell’acqua debba essere necessariamente coperto dal consumatore
attraverso il pagamento di un prezzo. Del resto, l’esperienza dei Paesi
dove l’acqua fa parte dei servizi di proprietà e gestione pubblica,
confrontata con l’esperienza dei Paesi dove l’acqua è stata
privatizzata, dimostra che non solo la privatizzazione non è
indispensabile, ma anche che essa non è necessariamente una soluzione
efficace e adeguata.
La democrazia necessita della
promozione di un “pubblico” nuovo, democratico, partecipato e solidale,
e l’attivazione di luoghi di partecipazione diretta, di prossimità, che
includano i cittadini e le comunità locali, i lavoratori e le
lavoratrici, gli enti locali, e la valorizzazione di tutte le forme che
nei vari Paesi rappresentano la ricchezza dell’esperienza democratica.
Perciò occorre:
- Promuovere una campagna “sete zero”.
Tutti gli abitanti della terra devono avere accesso all’acqua potabile
entro il 2020. “Sete zero” deve diventare un obiettivo scritto, un
impegno politico formale.
- Dichiarare illegale la povertà.
Visto il legame stretto esistente tra povertà e non accesso all’acqua,
la proposta “sete zero” significa praticamente “povertà zero”. Come nel
XIX° secolo l’abolizione della schiavitù aprì un’era di sviluppo
considerevole dei diritti umani, civili, sociali e politici, così la
dichiarazione d’illegalità della povertà costituisce uno degli obiettivi
prioritari della costruzione di un “altro mondo” e di un’altra politica
dell’acqua.
- Sostenere le lotte in corso contro
la costruzione di grandi dighe
in America Latina, in Asia (soprattutto in Cina), in Africa, in Russia,
nell’Asia Minore (in particolare nel Kurdistan) in Europa (specie nei
Paesi dell’Est). In particolare, bisogna favorire interventi su scala
locale comportanti bassi livelli di rischio tecnologico, sociale, umano,
ambientale e culturale, e ispirati ai principi di precauzione e di
reversibilità.
- Promuovere sistemi agricoli
diversificati, legati ai
territori, al ciclo corto produzione-consumo, alla manutenzione e tutela
dei processi ecologici, alla promozione, ove possibile, di coltivazioni
poco idroesigenti, e a un uso dell’acqua più funzionale agli interessi
di contadini e cittadini che a quelli delle industrie.
In questo senso, occorre far rispettare
norme miranti a ridurre i livelli attuali inaccettabili d’inquinamento e
contaminazione del pianeta provocati dalle attività industriali e
terziarie; occorre lottare contro le varie forme di privatizzazione dei
servizi d’acqua per puntare a promuovere la democrazia dell’acqua a
tutti i livelli, sia al livello dei bacini, sia al livello dei fiumi,
con la creazione di assemblee rappresentative di cittadini dei Paesi
appartenenti allo stesso bacino idrologico.
Inoltre, dal 1998 c’è stata una
“Campagna sull’acqua” che coinvolge organizzazioni non governative,
associazioni, movimenti, esperti e studiosi. L’obiettivo della campagna
è il riconoscimento di quattro punti indispensabili che si possono
estrapolare dal suo “Manifesto”:
1. Fonte insostituibile di vita,
l’acqua deve essere considerata un bene comune patrimoniale dell’umanità
e degli altri organismi viventi.
2. L’accesso all’acqua, potabile
in particolare, è un diritto umano e sociale imprescrittibile che deve
essere garantito a tutti gli esseri umani indipendentemente dalle etnie,
l’età, il sesso, la classe, il reddito, la nazionalità, la religione, la
disponibilità locale d’acqua dolce.
3. La copertura finanziaria dei
costi necessari per garantire l’accesso effettivo di tutti gli
esseri umani all’acqua, in modo che sia sufficiente alla vita, deve
essere a carico della collettività.
4. La gestione della proprietà e dei
servizi è una questione di democrazia. Essa è fondamentalmente un
affare dei cittadini e non (solo) dei distributori.
Bibliografia
Aa.Vv., Acqua. Bene comune
dell’umanità, Punto Rosso, Milano 2002.
Barlow M.- Clarke T.,
Oro blu. La battaglia
contro il furto mondiale dell’acqua,
Arianna Ed., Casalecchio di Reno (Bo) 2003.
Moretuzzo M.- Tosolini A.- Zoletto D.
(a cura di), L’acqua come cittadinanza attiva. Democrazia e
educazione tra i Nord e i Sud del mondo, EMI, Bologna 2003.
Petrella R., Il Manifesto dell’Acqua,
Edizioni Gruppo Abele, Torino 2001.
Shiva V., Le guerre dell’acqua,
Feltrinelli, Milano 2003.
Sironneau J., L’acqua. Nuovo
obiettivo strategico mondiale, Asterios, Trieste 1997.
Villiers M.D., Acqua. Storia e
destino di una risorsa in pericolo, Sperling & Kupfer, Milano 2003.
Sitografia
www.cipsi.it/contrattoacqua/home (sito del Coordinamento di
Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale che associa ONG e
associazioni).
www.desertification.it
(Comitato nazionale per la lotta alla siccità, curato dall’Enea).
www.lifewater.org (acqua per la vita: organismo cristiano che aiuta
i poveri del mondo rurale per ottenere acqua).
www.oieau.fr (l’Ufficio
internazionale dell’acqua è un’associazione non-profit francese che mira
al coordinamento dei partners che si occupano delle risorse acqua).
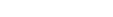 |