|
n. 12
dicembre 2010

Altri articoli
disponibili
|
|
 English
English
Le colonne
della dimora
di ANNA BISSI |
|
 |
 |
 |
 |
U n
giorno il piccolo Placido1 ricevette una comunicazione da una
figura drappeggiata di raccoglimento, la quale lo istruì in merito alla
vita interiore. "La Vita interiore - disse - è una Vita che è
interiore". Il piccolo Placido si precipitò a informare il padre Maestro
a proposito della sensazionale rivelazione, che avrebbe sconvolto tutti
i monasteri e la cristianità intera, domandandosi se sarebbe stato
opportuno avvertire il Santo Padre, il Papa. Il nostro giovane monaco ci
rivela così, attraverso la sua "stupefacente scoperta", che la nostra
dimora interiore non è una realtà statica, immobile, ma vitale. Questa è
la prima colonna su cui possiamo edificare il luogo della nostra
interiorità: la consapevolezza che dentro di noi abita una vita.
Vita è un termine difficile da spiegare. Il card.
Tomas Spidlik ci propone questa definizione: noi "spontaneamente
consideriamo vivo ciò che si muove da sé, che ha il principio del
movimento interno e dunque, muovendosi, sviluppa se stesso. Inoltre
esigiamo che tale sviluppo sia organico, armonico".2
Tali parole ci permettono di cogliere altre "colonne"
su cui costruire la dimora della coscienza. Innanzitutto il dinamismo,
il movimento interno: perché ci sia vita è necessario il
superamento della staticità, poiché ogni vita comporta sempre una
crescita incessante, uno sviluppo. Ricordo un sacerdote il quale mi
confessava la sua sofferenza quando, domandando ai suoi parrocchiani
anziani come stavano, si sentiva rispondere: "Tiriamo avanti". Ancor più
doloroso è pensare alle comunità religiose che parlano del loro "tran
tran". Questi termini, che offrono un’immagine della vita come il
susseguirsi di istanti da catturare e trattenere, in cui ciò che è
importante è il sopravvivere più che il vivere, è fondamentalmente
anti-cristiana. La nostra vocazione è, infatti, una chiamata alla vita
da intendersi in senso dinamico, un invito alla crescita, allo sviluppo:
Gesù è venuto a portarci una vita abbondante (cf Gv10,10).
Siamo allora invitati a riflettere sulla nostra vita
e domandarci se essa sia davvero tale. Il rischio, infatti, è quello di
ridurre l’esistenza, esperienza spirituale inclusa, a un ritualismo,
alla ripetizione di gesti che hanno perso di significato; altro pericolo
possibile è quello di irrigidirsi di fronte a ciò che non corrisponde ai
nostri desideri e sentirsi così delusi, senza più vita, delle "anime
morte" interamente o parzialmente, perché scontente e amareggiate,
incapaci di sperare in se stesse e negli altri o, ancor peggio, in Dio.
Un invito evangelico ci ammonisce rispetto alla possibilità di non-vita
presente anche in coloro che cercano il Signore o a cui egli si rivolge:
"Lascia che i morti seppelliscano i loro morti", dice Gesù all’uomo che
gli chiede di andare al funerale del padre prima di seguirlo (cf Lc
9,59).
La dimora e le sue leggi
Se la dimora interiore è il luogo dove nasce e cresce
la vita, e se questo sviluppo vuole essere organico e armonico, ciò
significa che tale costruzione non può essere pensata in termini
soggettivi, ma deve rispettare alcune leggi. Nella nostra epoca
caratterizzata dal sincretismo, le esperienze più diverse– psicologiche,
religiose, di benessere fisico – si possono accostare l’una all’altra,
senza apparire contraddittorie. Per il cristiano, al contrario, la vita
interiore è vita, se risponde a dei criteri definiti, esterni al
soggetto che la vive. Essa è vita se lo mette in relazione, se lo
orienta verso colui che è la Vita.
La dimora della coscienza è il luogo dove Dio abita e
non tutte le esperienze sono atte a preparargli un posto, in cui egli
può venire a dimorare presso di noi (cf Gv 14,23). Essa non si
costruisce dunque in modo spontaneo e superficiale e richiede la
capacità di andare contro corrente rispetto al riduzionismo
contemporaneo. Tale fenomeno tende innanzi tutto a far coincidere la
vita interiore con la vita psichica; di questa, poi, prende in
considerazione solo le funzioni più primitive e inconsistenti, le
emozioni epidermiche, le sensazioni di benessere che pongono allo stesso
livello un’esperienza di preghiera e una seduta di ginnastica
rilassante, la lettura della Bibbia o il testo di un qualche "santone"
indiano.
La dimora della coscienza si costruisce invece là
dove la dimensione psichica si lascia illuminare dalla luce ricevuta nel
Battesimo. Essa ci abita interiormente e, se glielo permettiamo, può
informare tutto il nostro vissuto, orientando le scelte, il sentire, il
riflettere e tutte quelle capacità psicologiche che possono essere messe
al servizio del fine per cui costruiamo la dimora: l’incontro con Dio.
Relazioni intime e profonde
La dimora della coscienza è, quindi, il laboratorio
dove si apprende la vita relazionale nel senso più vero e
profondo del termine, vale a dire dell’apice a cui possono giungere i
legami: l’amore. Non è la meditazione in cui si dilettano molti nostri
contemporanei, non è la preghiera recitata con le labbra, ma senza
toccare il cuore. Non è nemmeno la riflessione teologica, che talvolta
può ridursi a un insieme di elucubrazioni teoriche. Ciò che rende la
nostra vita veramente interiore è piuttosto una vita in cui si
intrecciano rapporti, si creano dei nessi, si coglie il filo d’oro
dell’amore, capace di tenere insieme tutte le realtà. La dimora della
coscienza è l’ambito dove si intessono i legami, in cui il nostro
spirito impara a integrare le varie dimensioni dell’esistenza, cogliendo
in esse un senso, un significato sempre uguale e, nello stesso tempo,
sempre diverso: l’amore di Dio donato all’uomo.
La dimora della coscienza è il luogo della relazione,
ma gli incontri che in essa avvengono devono avere due caratteristiche:
l’intimità e la profondità. Una coscienza matura, infatti,
presuppone la capacità di un vero incontro con l’altro e dunque la
presenza di un Io che ha superato modalità primitive di mettersi in
relazione, basate sulla gratificazione e sul rapporto strumentale, dove
l’altro è usato – anche se spesso inconsapevolmente – per i propri scopi
personali. Essa tende piuttosto al vero incontro, fatto di dono e di
accoglienza, di dimenticanza di sé e di generosa disponibilità. I legami
instaurati da una persona interiore, inoltre, hanno la caratteristica
dell’intimità, vale a dire della capacità di stare davanti all’Altro/
altro così come si è, senza il bisogno di difendersi, proteggersi,
mascherarsi e apparire diversi.
Un laboratorio di simboli
Infine, la dimora interiore è un laboratorio, dove
tutta la realtà può venire letta in chiave simbolica. Per l’uomo
interiore, che mantiene salda la relazione con Dio e con i fratelli,
tutto – in particolar modo il cosmo e la storia – diventa un simbolo,
vale a dire una realtà che lega, tiene insieme il visibile e
l’invisibile o manifesta la presenza dell’invisibile nel visibile. Per
questo l’uomo interiore è un po’ come l’innamorata, che vede le tracce
dell’amato in tutto ciò che la circonda. La vocazione dell’uomo alla
relazione, all’amore, è data infatti a una creatura inserita in un mondo
con cui è necessario creare un legame. La dimora interiore è dunque il
luogo in cui si riacquista una giusta relazione con il cosmo: innanzi
tutto attraverso un atteggiamento rispettoso nei confronti della natura,
dove l’uomo non si pone come colui che usa e sfrutta, ma come chi
accoglie e ha cura. Il cosmo, però, è anche il dono che Dio ha fatto
alla sua creatura ed esso acquista valore prima di tutto perché ci parla
del donatore, di colui da cui l’abbiamo ricevuto.
La vita interiore è la vita in cui colleghiamo
costantemente il dono accolto alla persona di colui che ce l’ha donato,
in un gioco di continui rimandi: per l’uomo interiore tutto è un
richiamo a un Amore da cui tutto proviene.
La vita interiore diventa allora lo spazio in cui la
persona esercita il suo ministero regale, risponde alla vocazione di
introdurre il cosmo creato nel mondo spirituale, di creare il nesso tra
il visibile e l’invisibile, perché, come dice Gregorio di Nazianzo,
tutto l’universo, visibile e invisibile, "sia riempito della gloria di
Dio, dal momento che tutto è di Dio".3 La vita interiore è
anche il luogo in cui si esercita la profezia. La capacità simbolica,
animata dallo Spirito Santo, trasforma anche il modo di interpretare la
storia: essa non si configura più come un susseguirsi di eventi, ma come
una realtà attraversata dal Mistero, in cui le vicende personali e
collettive sono interpretate alla luce della Pasqua.
Nella dimora della coscienza si creano così dei nessi
tra funzione simbolica e relazione: la capacità di interpretare la
realtà al di là dei fatti specifici che la attraversano si associa alla
fiducia, grazie alla quale è possibile trascendere il dato reale e
l’apparenza, per cogliere tutto ciò che avviene, a livello personale e
nella storia degli uomini, come segno della presenza di un amore, da
rintracciare oltre il visibile. Allora, come scrive Olivier Clément:4
"Nella contemplazione della natura" - ma noi potremmo anche
aggiungere: e in quella dei volti e della storia - "il cuore
intelligente diventa … "dimora di luce" che raggiunge la luce segreta
delle cose".
1 Personaggio uscito dalla penna di suor G. Gallois che, sotto le
apparenze di un fumetto, presenta
in modo ricco e profondo la vita monastica. G. GALLOIS,
La vita del piccolo san
Placido, Gribaudi,
Milano
1993, 29.
2 T. SPIDLIK,
Maranatha. La vita dopo la morte,
Lipa, Roma 2007, 37.
3 GREGORIO DI NAZIANZO,
Orazione
39, 13.
4 O. CLÉMENT, I
volti dello Spirito,
Qiqajon, Bose 2004, 145.
Anna Bissi
Psicoterapeuta
Basilica sant’Andrea
p.za Roma 35 - 13100 Vercelli
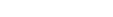 |
|
|
|