|
n. 12
dicembre 2010

Altri articoli
disponibili
Per coltivare la
vita interiore.
Intimità con Dio: vocazione cristiana
(ANNA MARIA CANOPI)
[ English]
English]
Le colonne della dimora
(ANNA BISSI) [ English]
English]
L’Egitto
interiore.
Scoprire le "dieci piaghe" dell’anima
(FRANCESCO GEREMIA)
[ English]
English]
|
|
 English
English
Questione educativa
Rischi
e urgenze
di UGO SARTORIO
|
|
 |
 |
 |
 |
Oggi
non vi è chi non si esprima sulla questione educativa: ne parlano la
Chiesa e la società civile, tutti coloro che ricoprono ruoli formativi,
la gente comune.1 Varie espressioni sono state ormai
codificate per esprimere il persistente disagio in questo ambito.
Emergenza educativa
Innanzitutto emergenza educativa, per dire la novità
della questione, il suo venire allo scoperto in modo dirompente, tanto
da richiedere l’attivazione di strategie di contenimento e contrasto di
fenomeni degenerativi, di cui il bullismo è solo un sintomo. Non che nel
passato l’educazione fosse cosa tranquilla, per il semplice fatto che
ogni generazione di giovani ha avuto i suoi sussulti, le sue
trasgressioni, i suoi confronti a muso duro con il mondo degli adulti,
le sue lacerazioni. In passato, però, questa conflittualità
intergenerazionale alla fine doveva fare i conti con la solidità di una
fascia adulta consapevole del suo ruolo, convinta di poter e dover dare
risposte e con la ferma volontà di orientare le nuove generazioni nel
solco di una tradizione riconosciuta come buona e affidabile e di un
mondo di valori condivisi.
Se dunque l’emergenza educativa può valere solo in
parte per le nuove generazioni, è applicabile in senso pieno alle
generazioni adulte, almeno anagraficamente. Noi tutti conosciamo alla
perfezione i luoghi comuni, che attribuiscono alla condizione giovanile
i tratti anche intensi del disagio, fino al nichilismo estremo,
l’"ospite inquietante" (l’espressione è di Nietzsche) di cui parla
Galimberti;2 conosciamo e tematizziamo meno le latitanze
educative del mondo adulto, di quegli adulti – e sono molti – che si
sono dati alla macchia, che hanno gettato la spugna, mettendo in atto un
vero e proprio tradimento educativo.
Urgenza educativa
È la seconda espressione che consideriamo, e che
sembra dire: bisogna fare in fretta perché non c’è tempo da perdere,
stiamo arrivando a un punto di non ritorno per cui è necessario porre
subito rimedio alla situazione. Cosa dire? Non sempre l’urgenza porta a
compiere le cose giuste, soprattutto a cominciare dalla parte giusta.
L’urgenza, nella maggior parte dei casi, non è amica della riflessione e
della ponderatezza; orienta piuttosto al fare, a tamponare gli eccessi
del momento, invece di aprire cammini che si inoltrano nel futuro, e a
volte favorisce la riabilitazione di modelli educativi - anche
discutibili - del passato. Urgenza e semplificazione vanno troppo spesso
insieme, determinando un confronto della questione educativa solo
declamatorio da una parte, o sbrigativamente interventista dall’altra.
Nessuno nega che vi sia effettivamente urgenza; al contempo, si deve
essere consapevoli che una situazione, la quale è degenerata negli anni
e che può persino apparire fuori controllo, non si rimette in
carreggiata con gli slogan o a colpi di bacchetta.
Il fatto dell’urgenza, poi, determina certamente un
aumento e un accumulo di preoccupazione, che non sempre si trasforma in
"occupazione".
Sfida educativa
È la terza espressione che vogliamo esaminare. Una
sfida per chi? Ma prima ancora, lanciata da chi? Il rischio di una
risposta parziale o settoriale, a questo livello, è in agguato. La colpa
- si dice - è del mondo caotico dei mass-media e dei falsi modelli che
propongono. Oppure, la colpa è della demotivazione degli educatori e
della superficialità degli educandi. O anche, la colpa è della fragilità
dei giovani e dell’immaturità degli adulti. Una sorta di rimpallo delle
responsabilità, in cerca di un capro espiatorio contro il quale puntare
il dito per decretare, infine, la condanna. Ancora una volta la
complessità - elemento primario e inaggirabile del postmoderno3
- orienta a tenere il più possibile il giudizio sospeso. Non perché non
vi siano indiziati, ma molto più semplicemente perché sono troppi, tra
loro imbricati, ed è quanto mai arduo dipanare la matassa. Non è quindi
con esecuzioni sommarie che si risolvono le cose.
Mentre un tempo educare era un compito di
tutta evidenza, che si svolgeva da sé, quasi per consequenzialità
sociale (sostanzialmente era la società nel suo insieme ad educare),
oggi invece è una sfida, realtà da ricomprendere e riformulare.
Una sfida a tutto campo, da tutti i lati e per tutti i soggetti, nessuno
escluso. Che spinge a condividere, spostandone appena la prospettiva: è
l’invito del sociologo francese Edgar Morin affinché "tutti quelli che
hanno il compito di insegnare [che per noi diventa "educare"] si portino
negli avamposti dell’incertezza del nostro tempo".4 Non per
fomentarla, bensì per attraversarla.
Crisi educativa
È un’ulteriore espressione che va per la maggiore. Si
sottintende il fatto che l’educazione è in crisi, anche se detta così
appare come una tesi piuttosto rozza e imprecisa. Qui mi rifaccio alle
parole di Angelo Scola, Patriarca di Venezia, che rispondendo a una
domanda circa la tentazione oggi diffusa di rinunciare al compito
educativo,5 risponde: "La sfiducia deriva da un dato di fatto
ben illustrato da un’affermazione di Péguy: "Le crisi dell’insegnamento
non sono crisi di insegnamento; denunciano, rappresentano crisi di vita
e sono crisi di vita esse stesse". Intendo dire che non esiste mai,
propriamente parlando, una crisi di educazione, una crisi "educativa",
ma appunto una crisi di vita: dove non esiste una vita adeguata non si
può comunicare nulla, non si può insegnare nulla ai giovani".
In qualche modo il Patriarca insinua un azzeramento
della questione a livello tecnico-pratico, riportandola nell’alveo
vitale delle relazioni, degli stili di vita, dei percorsi esistenziali,
dei significati e del senso.6 Questa particolare sensibilità
porta alla declinazione della categoria di testimonianza in tutta la sua
estensione, umana e cristiana.
Ma veniamo ora all’espressione più connotata, per il
fatto che ha dietro di sé una lunga storia.
Rischio educativo
È infatti il titolo di uno dei libri più incisivi
scritti da don Giussani,7 il sacerdote di Desio che ha
dedicato l’intera vita all’impresa formativa. L’azione educativa è
introduzione all’esperienza integrale della realtà, e nella sua essenza
il legame educativo mette in relazione due liberi soggetti - l’educatore
e l’educando – coinvolti in un rapporto modulato dall’imporsi del reale.
Il rischio è quindi innanzitutto quello del coinvolgimento: l’educatore
che per primo, rispondendo all’appello della verità, si auto espone nei
confronti dell’educando. Vi è poi il rischio, imponderabile, di una
risposta che può non venire, di un assenso che può essere negato, di una
libertà che non può essere posseduta e che decide altrimenti. Questo
significa che il compito educativo comporta dei tratti drammatici,
poiché il suo esito non è mai predeterminato; perciò non è fuori luogo e
tanto meno enfatico parlare di "avventura educativa".
È facile comprendere il collegamento di questa
posizione con il nostro tema: l’educazione si fonda sul legame, non
estrinseco e neppure formale, tra due soggetti. Necessita inoltre di una
volontà educativa e quindi propositiva, che non intende prevaricare
l’altro, anzi vuole suscitare la sua libertà in pienezza: l’espressione
adeguata per indicare tale intento potrebbe essere "liberare la
libertà".
Anche se a questo punto si apre il non facile
capitolo dei diversi modi di intendere la libertà nel postmoderno: là
dove essa è concepita come assenza di legami, viene meno anche la
possibilità del legame e quindi del processo formativo. Il rischio
educativo, inoltre, fa riferimento alla realtà, alla forza educativa del
reale: oggi però, come tutti constatiamo quotidianamente, la realtà è
deformata, travisata, e sono molti coloro che preferiscono la
scorciatoia e le nicchie del virtuale. C’è di più, perché il pensiero
postmoderno non solo porta a una manipolazione della realtà, ma si
spinge oltre fino a dissolvere il reale nel gioco senza fine delle
interpretazioni. Non esiste una realtà da interpretare, ma esistono solo
infinite interpretazioni della realtà.
Alleanza educativa
È l’ultima espressione della nostra serie. Un tempo
non era neppure necessario parlarne, dal momento che la società era
orientata in modo compatto verso gli stessi fini. Non esisteva
contrapposizione tra famiglia, chiesa e scuola, e ogni soggetto
educativo poteva contare sull’altro, se non per i contenuti sicuramente
per i metodi formativi. Oggi questa omogeneità d’intenti è solo un vago
ricordo, e, senza trascurare alcune forzature che quella situazione
poteva comportare (non vanno dimenticati, lo ripeto, i limiti di certi
stili educativi del passato), alcune sinergie sono da recuperare e da
rilanciare.8 Il dialogo scuola-famiglia, tanto cruciale
quanto problematico; il dialogo scuola e chiesa, filtrato dal concetto
di "nuova laicità" così com’è stato formulato dal cardinal Angelo
Scola:9 il rapporto chiesa-famiglia, per una collaborazione che può
essere feconda.
1 Ne dà testimonianza il volume SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO
CULTURALE DELLA CEI, L’"emergenza educativa". Persona, intelligenza,
libertà, amore. IX Forum del Progetto Culturale, Dehoniane, Bologna
2010.
2 Cf U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i
giovani, Feltrinelli, Milano 2007.
3 Che è il contesto dei nostri giorni, letto in modo sapienziale da
C.M. MARTINI, Educare nella postmodernità, a cura di F. Monaco,
Editrice La Scuola, Brescia 2010.
4 E. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro,
Raffaello Cortina, Milano 2001, 14.
5 Intervista di S. PERALDO, in Il Biellese, 16 maggio 2009.
6 In questa linea, più che di crisi educativa si dovrebbe parlare di
"eclissi dell’agire educativo", vale a dire "della responsabilità
educativa del mondo adulto nei riguardi delle nuove generazioni": R.
SANI, "L’educazione tra rischio e libertà", in G. CHIOSSO (ed.),
Sperare nell’uomo. Giussani, Morin,
MacIntyre e la questione educativa,
Sei, Torino 2009, 27.
7 Cf L. GIUSSANI, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2006.
8 Insiste sulla necessità di "promuovere nel nostro Paese una sorta
di alleanza per l’educazione": C. RUINI, "Prefazione", in AA.VV.,
La sfida educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, a cura del
Comitato per il progetto culturale della CEI, Laterza, Roma-Bari 2009,
XVI.
9 C. A. SCOLA, Un nuova laicità. Temi per una società plurale,
Marsilio, Venezia 2007.
Ugo Sartorio ofmconv
Direttore de Il Messaggero di sant’Antonio
Via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova
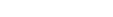 |
|
|
|