Per coltivare la
vita interiore.
Intimità con Dio: vocazione cristiana
(ANNA MARIA CANOPI)
[ English]
English]
Le colonne della dimora
(ANNA BISSI) [ English]
English]
L’Egitto
interiore.
Scoprire le "dieci piaghe" dell’anima
(FRANCESCO GEREMIA)
[ English]
English]
|
|
 English
English
L’Egitto interiore
Scoprire le "dieci piaghe" dell’anima
di FRANCESCO
GEREMIA
|
|
 |
 |
 |
 |
L'uscita
dall’Egitto o esodo-pasqua, in quanto fatto storico, fa solo da cornice
per una riflessione simbolica del testo biblico da parte di A. De
Souzenelle,1 secondo i criteri ermeneutici della
kabalà-mistica ebraico-cristiana.2 Il classico racconto
biblico delle "dieci piaghe" (Es 7,1-29; 8,1-10,29; 12,29-34) necessita
di una rilettura profonda capace di sviscerarne i significati reconditi.
In realtà, all’autrice interessa dimostrare come sia possibile compiere,
con l’intervento divino, la liberazione dalle schiavitù, paure, odi,
alienazioni interiori, proprie ad ogni essere umano, ed entrare in uno
spazio di coscienza sempre più ampio in una successione ininterrotta di
passaggi e di mutazioni.
L’‘ebreo’ e l’‘egiziano’ diventano rispettivamente in
questo senso le metafore dell’uomo che accoglie l’invito verso la terra
della libertà, o invece di colui che si chiude sempre più in se stesso,
incontrando così distruzione e morte. E l’Egitto appare, in quanto
territorio esterno, la ‘matrice’, il territorio interiore ai singoli e
alle collettività, in cui si opera questa continua trasmutazione.
Esterno e interno si corrispondono nella misura in cui uno è immagine
dell’altro, il visibile dell’invisibile, il dicibile dell’indicibile, il
precario del permanente.
Mosè, l’Egitto e la rivelazione del nome
La figura di Mosè sintetizza e anticipa a livello
personale la trasmutazione che riguarda l’intera collettività di Israele
e dell’umanità. Salvato in modo prodigioso
dalle acque, educato ai valori della civiltà
egiziana, in un primo tempo egli tenta di rovesciare con i suoi mezzi
(l’uccisione di una guardia egiziana e il tentativo di pacificazione fra
ebrei) la situazione di sfruttamento in cui vive il suo popolo. L’azione
è destinata al fallimento. Fugge in terra di Madian, dove sposa Zippora
– figura del suo femminile interiore di cui deve ricordarsi, cioè
conoscerlo in profondità e ricomporre l’unità originaria - e si
sottomette al rito della circoncisione, segno fisico di un mutamento
radicale a livello dello spirito.
In questa unità restaurata ha la rivelazione del
nome, la realtà ineffabile del suo Dio. Comprende subito che con i
soli valori umanistici assimilati in Egitto non può attuare nessuna
liberazione: solo nell’affidamento totale alle energie che vengono
dall’alto, egli potrà affrontare il faraone e iniziare la vicenda
dell’esodo verso la terra promessa.
L’Egitto, dunque, con la sua grande estensione
territoriale, è figura della ‘terra interiore’ di ognuno e dei popoli,
nella quale si vive in stato di ‘schiavitù’: l’intenzione divina è
quella di avviare un processo, anche doloroso, perché ogni legame decada
e tutti aspirino alla ‘terra promessa’ come paese di vera libertà.
Non si tratta però di un fatto meccanico e
automatico, perché le perplessità e le obiezioni al volere divino si
rinnoveranno nel corso della vicenda: molta strada è ancora da
percorrere. Egli fa esperienza di quanto preannunciato dal racconto
dell’Eden, dove Dio pianta un albero, chiamato della conoscenza del
compiuto e del non compiuto, dell’umido e dell’asciutto, delle tenebre e
della luce. In quest’uomo si svolge, per intervento anche divino, una
gradualità di passaggi e trasformazioni che lo abilitano a
verticalizzarsi nell’albero che egli è (nella scrittura l’albero è
simbolo dell’uomo) fino a portare i frutti che gli sono propri. In Mosè
si rinnova la vicenda propria anche degli antichi patriarchi, in
particolare Abramo e Giacobbe. Reso forte e stabile dalla potenza di
Dio, affronterà il faraone e assisterà alla rinascita del suo popolo che
le piaghe vogliono illustrare.
Le "dieci piaghe" dell’anima
Al seguito di Mosè anche l’intero popolo d’Israele
deve scoprire e diventare il ‘nome’ svelato nel racconto del roveto
ardente: yodhe- waw-he. Come viene asserito nello Zohar
(Libro dello splendore) dei mistici cabalisti, "il tetragramma è una
spada: yod è il pomo, waw la lama, e le due he i
due tagli". Nel suo intimo Israele deve diventare questa spada e
lasciarsi modellare da essa, secondo il detto di Gesù: "Non sono venuto
a portare la pace, ma la spada " (Mt 10,34). Il percorso tendente a tale
scopo è raffigurato nel testo biblico da forme viventi o da animali,
immagini delle indefinite possibilità insite nell’uomo (analoghe ai
dieci animali che Dio presenta a Giobbe perché scopra il suo vero io: cf
Gb 38-39).
Sono normalmente chiamate ‘piaghe’ e a prima vista
sembrano inviare a un quadro di assurdità e inconsistenza pratica. In
realtà, il testo parla di "portenti, azioni stupende, meraviglie" di Dio
in favore del suo popolo perché si avvii il cammino di crescita a
livello di collettivo. Ognuna di esse mantiene sempre una duplicità di
significato: negativo e positivo.
Dal racconto emerge anche una apparente
contraddizione nell’agire divino: egli che vuole liberare il suo popolo,
dopo ogni prova indurisce il cuore del faraone,
quasi a prolungare l’agonia di quella gente. In
realtà essa rivela la sapienza divina: da una parte richiama il fatto
che nella vicenda umana nulla è meccanico e compiuto una volta per
sempre: tutto è sempre inizio di un cammino che attende passi
successivi; dall’altra, l’intralcio divino tende a solidificare, prova
dopo prova, la consistenza interiore degli ebrei, liberando in essi
energie sopite e responsabilità nuove da incorporare.
Le acque cambiate in sangue
La successione delle prove si apre con
l’evento dell’acqua mutata in sangue: slegata dal rapporto con il
Nome, lo yod del tetragramma, in esilio da Dio e da noi
stessi, l’esistenza umana si trascina in un vortice di omicidi,
massacri, tragedie sanguinose, eventi distruttivi di cui è ricca ogni
giorno la cronaca. La presa di coscienza del baratro in cui si è caduti,
porta a scoprire il senso del gesto di Gesù di mutare l’acqua in vino:
questo segno, secondo Giovanni, è l’inizio dei misteri messianici per
Gesù, ma segna ugualmente l’avvio di trasmutazione all’interno del
popolo ebraico e dell’umanità intera dove la spada-parola accolta
e forgiata costituisce il primo passo di un cammino di maturazione del
proprio io e della distinzione di ciò che prima era confuso a livello
puramente biologico-animale.
"La vinificazione del sangue degli ebrei ha aperto il
cuore proprio all’amore divino, l’amore che in loro e in noi tutti, un
giorno, sarà capace di "scusare tutto, sperare tutto, sopportare tutto,
di essere paziente e non tener conto del male…". L’ebreo è istradato. Ma
deve andare oltre".
Le rane
La seconda tappa della crescita umana è quella
relativa alla conoscenza, significata dalle rane. Già
nell’Eden l’essere umano era descritto come un albero tendente al
proprio compimento in fiori e frutti. Qui le rane, animali che vivono
nell’umido e possono saltare sull’asciutto, traducono in immagine il
compito umano: se si rimane nell’umido (le nostre energie profonde
sconosciute) si vive nell’incoscienza; se invece si opera il passaggio
al terreno solido, si accoglie la spinta alla presa di coscienza di se
stessi, allo sposalizio interiore con tutte le proprie forze,
indirizzandole verso la maturazione.
Israele in Egitto vive per intervento divino questa
fase decisiva e si dispone sulla via della verticalizzazione. Gli
egiziani, al contrario, che rifiutano tale passaggio, sono divorati
dalle rane, dalle energie potenti che lo abitano: immagini dell’umanità
attuale che, smemorata della propria interiorità, si trova in balia dei
risultati delle scoperte e delle tecniche da essa creati.
Il parassita
Come diretta conseguenza appare il parassita,
suscitato dal colpo di bastone di Mosè sulla polvere, immagine delle
indefinite energie di cui ogni essere umano è fornito (cf Gen 2,7).
Nella sua situazione di esilio, questi concretizza le sue
potenzialità nella miriade di scienze, tecniche, conoscenze, invenzioni,
leggi, ordinamenti che danno solo un’apparenza di ordine reale. In
realtà, l’ebreo come l’egiziano vivono in un mondo di magie slegato
dagli archetipi fondatori della loro esistenza e perciò produttori di
sofferenze e morti indicibili. Mosè, colpendo la polvere che diviene
parassita, indica al suo popolo che il dito di Dio mette un
argine al potere dei maghi e all’idolatria delle scienze, perché
scopra la necessità di collegare intelligenza e saggezza al modello
divino.
L’insetto
Sulla strada della luce, gli ebrei vedranno il loro
Dio invadere la loro esistenza con lo sciame degli insetti. Il
termine ebraico arob richiama inevitabilmente quello di ereb,
la sera (le tenebre della creazione), e oreb, il corvo(il mito
del diluvio). Composti dalle stesse lettere, ma vocalizzati in modo
diverso, i tre termini svelano al popolo in esilio la necessità di
rivolgersi all’adamah, madre delle profondità. Come Noè entra
nell’arca con tutti gli animali, compie perciò un cammino di immersione
del proprio io più profondo, ne assume tutte le energie-animali e ne
esce con la luce della colomba, celebrando così le nozze fra tenebre e
luce, ebbro di Spirito santo di cui corvo e colomba ne sono i simboli. "Arob,
che simboleggia lo Spirito di Dio, disgrega chi non entra nel suo
soffio…, ma struttura lo spirito dell’ebreo’ in terra di Gosen".
La peste
In ognuno di noi vive il divino tetragramma, come "io
sono in divenire ". Nella prima piaga la parola- spada
uccideva o liberava: in questa invece essa appare sotto il segno
della peste, deber, opposto a dabar, parola di Dio
che indica anche la cosa, perché la parola divina opera ciò che
dice. "In ogni cosa-dabar è il Verbo-dabar che, non
riconosciuto, fa di quella cosa la peste-deber". Gli ebrei sono
condotti da Dio a questo confronto decisivo di vita e di morte come a un
giudizio rivelatore. "È la spada che porta a compimento il
nome nell’uomo interiore, ma che si rivolta contro l’uomo rimasto
incosciente, affinché entri nella rivelazione del nome santo… In
questa prospettiva, la peste stessa concorrerà alla salvezza; la spada
agisce solo in vista del compimento del creato e per la gloria di Dio".
La lebbra e la grandine
La lebbra, sehyne in ebraico, sesta ‘piaga’,
appare come immagine dell’io narcisistico che può giungere fino alla
paranoia. Anche Giobbe, tutto incentrato su di sé, è da Dio colpito con
lebbra maligna perché superi il proprio infantilismo e
riprenda la strada della luce. Con la settima prova, la grandine,
provocata dalla verga di Mosè, l’agire di Dio si intensifica: egli vuole
che le ‘terre interiori’ degli ebrei siano sconvolte perché sorga un
campo di coscienza nuovo. Il compito affidato ad Adamo "di custodire e
coltivare la sua terra" (Gen 2,15) diventa quello dell’intero popolo:
non più schiavo degli impulsi animali che lo abitano - la sessualità
infantilizzata e il chiacchiericcio fatuo, che soffocano la voce del
Verbo - prende coscienza della necessità di sposare la realtà più
profonda del suo essere e di iniziare la verticalizzazione del suo io
(risurrezione, anastasis).
La cavalletta e le tenebre
La cavalletta e le tenebre, ottava e
nona prova, ribadiscono ognuna a suo modo la necessità di scendere nelle
tenebre del proprio io per risalire alla luce. Tenebre e luce si
richiamano a vicenda. Già il racconto della Genesi lo annunciava
e Giobbe vede Dio dopo la lunga e dolorosa discesa dentro di sé;
così gli ebrei, schiavi in Egitto ed estranei all’interiorità del loro
essere, sono stati condotti per tappe successive a risvegliarsi e a
conoscersi fin nell’intimo. Le tenebre non sono affatto il nulla
o l’assenza di visione: rappresentatoì il potenziale di luce che è
inscritto in ogni essere e che chiede di essere assunto consapevolmente
per tramutarsi in luce e in amore sponsale. "È una sera, è un mattino…",
dice ognuno dei giorni della Genesi.
"Le tenebre sono l’emergere dell’abisso; e l’abisso è
ciò che separa radicalmente l’Increato dal creato, Dio dall’uomo. Ma le
tenebre sono anche la manifestazione dell’abisso, quando l’Increato esce
dalla sua non-conoscenza, dalla radicalità della separazione, per farsi
conoscere in un’icona del Figlio divino, un ‘Io sono’ del suo essere!...
Nessuno può nascere al ‘figlio’ divino che porta in sé, se non fa
l’esperienza delle tenebre che salgono dall’abisso".
L’esperienza degli ebrei è quella della morte di Gesù:
"Si fece buio su tutta la terra…", e quella che riscontriamo in molte
vicende dei grandi mistici della tradizione cristiana, detta "notte
oscura " o "cammino notturno".
La morte dei primogeniti
Infine, preparata dalle prove precedenti, giunge la
decima piaga, l’uccisione dei primogeniti: questi muoiono perché
gli egiziani non hanno partorito al loro interno un ‘figlio’ primogenito
attraverso morti e nascite successive e non hanno costruito la totalità
di se stessi, il ‘nome’ segreto, divino. Non si tratta di una vendetta o
ferocia divine, come non lo sono state per Gesù che muore perché il
‘figlio del padre’, Bar-abba, fosse liberato. Al termine di
questa lunga vicenda, Israele comprende che il passaggio, prima
di essere vicenda dell’uomo, è passaggio della luce folgorante di Dio.
"La spada passa sopra (pesah-pasqua) la casa dove è appena
nato un figlio; si abbatte su quella dove regna la sterilità e si
fa distruttrice del bambino che si amava teneramente. Il nome del
distruttore è quello del Messia!".
Memoria del futuro
Un percorso arduo e insieme esaltante quello
tracciato dalle dieci ‘piaghe’, a simboleggiare con il suo numero (5+5,
maschile e femminile dell’essere, richiamato dal numero 10
corrispondente allo yod, il nome divino) l’unità interiore da
raggiungere nel corso dell’intera esistenza. Come per Gesù, dal vino di
Cana all’‘ora’ della croce, si è compiuta l’unità con il Padre, anche
per tutti gli uomini si rinnova la stessa dinamica: dal sangue versato
sulla terra della prima prova a quello dei primogeniti straziati in
terra d’Egitto si opera la scoperta dell’amore quale forza immensa che
costruisce e fa fruttificare. Ogni anno, la grande liturgia del sabato
santo ce lo rende attuale e orienta la nostra ascesa di "alberi piantati
lungo il fiume" (Sal 1). Più che rinviarci a un passato remoto, questi
racconti sono ‘apertura di senso’: in essi possiamo scoprire il nostro
glorioso destino. Come l’eucaristia, essi sono memoria del futuro
che Dio ha disposto per l’umanità intera.
Francesco Geremia osm
Priorato di Sant’Egidio
24039 Sotto il Monte (BG)
1 A. DE SOUZENELLE, L’Egitto interiore o le dieci piaghe
dell’anima, Servitium, Gorle (BG) 2000.
2 La ricerca di A. De Souzenelle si è concretizzata in numerosi
scritti tutti editi dall’Editrice Servitium (Sotto il Monte, Bg): Nel
cuore del corpo la parola; Il simbolismo del corpo umano; L’Egitto
interiore o le dieci piaghe dell’anima; Il femminile dell’essere;
Risonanze bibliche; L’Edipo interiore; L’arco e la freccia; La lettera
strada di vita; Giobbe sulla via della luce; L’alleanza dimenticata; Il
bacio di Dio o l’alleanza ritrovata; Il mito di Giona.
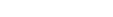 |
|
|
|