|
 |
 |
 |
 |
La riflessione sin qui
fatta (vedi numeri 1 e 2/2002 di Consacrazione
e Servizio) allude a quel cammino di purificazione attraverso la
sofferenza della solitudine, che i padri spirituali descrivono come via
di purificazione, necessaria per accedere, nella via unitiva, alla
relazione d’amore con Cristo e i fratelli. Se ora ridomandiamo: qual
è il clima che favorisce questo cammino dello spirito? Veniamo
introdotti a considerare un altro tipo di solitudine, la solitudine
spirituale, che è patrimonio prezioso nella vita del consacrato e
favorisce la maturazione della propria persona all’interno della vita
comunionale.
Solitudine
spirituale
Fa
parte dell’esperienza di ogni consacrato la consapevolezza che, senza
un luogo in cui vivere momenti di solitudine, la nostra vita è messa in
pericolo e i nostri gesti rischiano la paralisi o lo svuotamento. Non si
tratta solo di luoghi fisici. Si tratta piuttosto di luoghi dello
spirito. E pertanto silenzio e solitudine non possono essere considerati
come semplici ritagli dal vivere quotidiano, come fuga dalle
preoccupazioni o dall’eccesso della fatica. Ben presto diventerebbero
essi stessi insopportabili.
Silenzio
e solitudine non possono neanche essere ridotti a semplici tecniche di
“igiene della mente”. Il relax è importante per recuperare energie:
anzi occorrerebbe impararne l’importanza per la propria vita
spirituale, al fine di decongestionarla dagli ingorghi del “traffico
mentale”. Ma non è a ciò che facciamo qui riferimento. Silenzio e
solitudine sono invece momenti dello spirito che possono coesistere
persino nell’attività. Attraverso l’attitudine a essere presenti a
se stessi si entra in dialogo con il proprio mondo interiore, si
ospitano Dio e gli altri in modo attento ed accogliente.
La
presenza a sé è insopportabile quando ci si ritrova soltanto di fronte
al fluttuare delle proprie emozioni. L’autospecchiamento rende
inquieti. Quando, invece, la presenza a sé è sostenuta dalla
solitudine e dal silenzio spirituali introduce a una relazione amica e
dialogica con il Signore e con gli altri nostri fratelli. La solitudine
e il silenzio spirituali sono allora agli antipodi dell’isolamento,
anzi favoriscono quello scavo che mette a contatto con le fondamenta,
che sostengono la nostra umanità.
Dall’intimità
con Cristo
la rassicurante serenità di esistere
nel mondo
Il
punto critico di ogni rapporto è il modo con cui noi viviamo la nostra
interiorità. Siamo esseri che assorbono tutta la realtà circostante
attraverso la sensibilità. E sappiamo quanto le sensazioni siano
potenti in noi e sovente decidano anche di noi. Il silenzio interiore
permette una giusta sedimentazione delle emozioni. Impedisce che le
impressioni del momento la facciano da padrone e le mette a contatto con
il giudizio di verità.
Se
il nostro io è disperso nella molteplicità delle preoccupazioni, ben
presto sarà come una stanza stipata di cose, buttate là nel disordine
e nella polvere, ove è impossibile riuscire ad abitare. Non minore
disagio si vivrebbe nello stare in un’abitazione fredda e disadorna,
in cui risuona soltanto l’eco dei propri passi.
Rientrare
nella propria interiorità vuol dire misurarsi con la relazione intima
che sostiene la propria solitudine. Chi abita in me? Chi ritrovo quando
rientro in me stesso? Le alterazioni delle reazioni istintive e degli
umori passeggiano anarchicamente nello spirito, prostrandomi nella
confusione? C’è un punto di sedimentazione di tutta la polvere che la
sensibilità umana alza ogni qualvolta si scontra con qualche disagio?
Al
credente consacrato è data la grazia di conoscere e, poco o tanto, di
sperimentare che la risposta a questa questione è il contatto
spirituale con la persona di Gesù, il risorto nella propria vita. E
pertanto sa che la sua vita dipende dalla stabilità con cui vive
l’esperienza spirituale con Cristo presente. Ma in queste cose non
basta sapere.
Dire
“esperienza spirituale” significa appunto superare il semplice
livello della conoscenza e accettare la sfida di consegnare libertà e
sensibilità al rapporto con Cristo che vive in noi, e questo non
soltanto nell’astrazione dal mondo, ma precisamente attraversando le
preoccupazioni del mondo.
La
grazia della fede è umanamente significante se conclude a un rapporto
affettivo con Cristo, altrimenti si riduce a spunto ideologico senza
impatto umano. Ed occorre anche spiegare che dire “affettivo”
significa differenziarne il concetto da “sentimentale”:
l’affettività è un legame che avvolge il sentimento umano, ma
esprime più profondamente il vincolo che intelligenza e volontà
riconoscono come fondante al di là, o meglio dentro i sentimenti che si
possano provare. A nessuna persona intelligente, credo, è risparmiata
la prova dell’amarezza e della delusione. Ma precisamente nella vita
spirituale la questione non è di venirne preservati, ma di avere un
legame affettivo entro cui la turbolenza dell’anima possa essere
placata.
Un
cammino spirituale significa pertanto imparare a rapportare
continuamente, nelle circostanze della vita, il proprio io e la sua
fragilità con l’attualità della compagnia di Cristo, ed educarsi a
pensare con Cristo, a sentire con Cristo, a volere con Cristo. Solo se
questa relazione primaria è tenuta viva nell’animo, si può percepire
la ricchezza dell’essere soli con se stessi e avere la chiave di volta
che tiene in piedi l’esistenza, sottraendola alla facile illusione dei
momenti felici e all’amarezza delle circostanze dolorose.
Il ruolo del
silenzio e del raccoglimento
Se
il rapporto con Cristo deve tradursi in esperienza e l’esperienza
interiore si nutre di silenzio e di interiorità, la vita cristiana non
è vita solitaria, ma vita in solitudine sì. Il raccoglimento cristiano
non è vuoto, ma pienezza, poiché nel fondo dell’animo si riverbera
il Volto del Mistero. Vi è da attuare pertanto un’ascesi del
raccoglimento. Dio parla nel silenzio e nella solitudine: solo nel
silenzio della solitudine è possibile ascoltarlo (1Re
19,11-12). E quando vuole attrarre a sé un’anima la «conduce nel
deserto e le parla al cuore» (Os
2,16).
E’
quasi inevitabile che rientrando in noi stessi ci scontriamo con le
nostre tenebre. E’ spontaneo averne paura. Ma questo spiacevole
incontro, invece che essere occultato, dovrebbe essere messo in contatto
con colui che senza retorica è “il Salvatore”.
Se
il silenzio dell’anima mette a nudo la nostra povertà e il nostro
peccato, è anche vero che da tale consapevolezza può salire più
profondo il grido della nostra umanità. Persino le amarezze della vita,
quelle vili e umilianti situazioni che snervano e prostrano in forme più
o meno grandi di angoscia, possono svolgere un ruolo di sgombero nel
cammino dello spirito.
E’
in questi meandri che si può desiderare Gesù come la luce che splende
nelle tenebre (Gv 1,4-5; 8,12; 12,35-36). E quando lo si lascia operare, sprigiona
una potenza che non manca di produrre i propri effetti. Lo ha promesso:
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò»
(Mt 11,28). L’andare a lui rivestiti della coscienza della propria
nullità è l’inizio di ogni percorso di guarigione dello spirito.
Tutto
questo ogni consacrato lo sa già. Ma appunto questa presunzione di
saperlo già è l’inizio di ogni forma di decadenza nello spirito.
Nella vita spirituale tutto si sviluppa attraverso la vigilanza.
Nella
storia della spiritualità vi è un’operetta di san Bernardo, il De
consideratione ad Eugenium Papam, che meriterebbe di essere meditata.
Eugenio III, già monaco di Clairvaux, riceve una lunga e amichevole
lettera di Bernardo, che lo invita a non trascurare il raccoglimento
pure in mezzo alle distrazioni della curia papale, e tra le tante
considerazioni afferma: «Temo che in mezzo alle occupazioni che sono
molte e di cui disperi ormai di vedere la fine, il tuo spirito diventi
insensibile e perda a poco a poco il sentimento di un giusto e benefico
dolore. Sarebbe molto più saggio che tu sospendessi queste occupazioni,
almeno per qualche tempo, piuttosto che lasciartene trascinare e
condurre, un passo dopo l’altro, là dove tu non vuoi. Mi domandi
dove? Ti rispondo: alla durezza del cuore. E non chiedermi che cosa sia:
se non ne sei atterrito, vuol dire che ci sei già arrivato. Solo chi ha
un cuore duro non ha orrore di se stesso, perché ha perso ogni
sensibilità».
La
vita spirituale non diventa problematica quando una persona è prostrata
nelle tribolazioni dello spirito, ma quando si trascina
nell’insensibilità del cuore (Ap 3,16), quando cioè il cuore decide
di fare da solo e si rende impermeabile al rapporto con l’Unico che lo
può liberare. Ed è proprio il raccoglimento interiore che, impedendo
la tiepidezza dello spirito, riattiva la dinamica di una fede viva.
Il silenzio dà
peso alla parola e sostanza ai rapporti
La
sorgente della nostra vita attiva è la nostra vita in solitudine. Lì
è in atto la vigilanza e lì posso domandarmi: che cosa c’entra
quello che sto facendo con Cristo e con il mio destino? Dove mi conduce
questa scelta rispetto al senso profondo della mia esistenza?
Questo
dialogo interiore può avvenire solo nella calma del raccoglimento.
Raccoglimento e silenzio sono nutrimento e vita dell’anima, perché le
permettono di esplicitare le sue funzioni di conoscere, di giudicare, di
volere; e in tal modo di solidificarsi intorno a ciò che è essenziale.
Il raccoglimento porta così a semplificare la vita, portando ad
evidenza ciò che veramente conta e vale. E proprio da questa interiorità,
ricca di coscienza di sé perché relazionata a Cristo, è possibile
avventurarsi nel rapporto con gli altri.
Quando
la fragilità della nostra coscienza è rassicurata dalla certezza di un
amore che è fedele, prima e al di là della nostra fedeltà, allora
dalla nostra solitudine possiamo anche sbilanciarci nel rapporto con gli
altri senza timore di essere abbandonati o rifiutati. Se il mio io è
supremamente accolto e amato, posso fare spazio, senza essere ricattato
dalle mie paure, a coloro che Dio mette sulla mia strada. Le parole
allora non sono soltanto l’espressione delle reazioni del momento, ma
diventano capaci di stabilire relazioni, poiché, come giustamente
osservava Romano Guardini: «La parola è sostanziosa e fattiva soltanto
quando sale dal silenzio». Diventa possibile allora incontrarsi nello
scambio di parole vere.
La
solitudine in Cristo, mentre guarisce le nostre ferite, ci porta a
confrontarci non solo con il nostro dolore, ma anche con il nostro
destino. Per questo, la solitudine spirituale può diventare la porta
che introduce a una fraternità più sincera. «Che cosa vi fa credere
che la solitudine allontani gli uomini e impedisca di comprenderli?
Cristianamente, e anche umanamente, credo che sia vero il contrario.
E’ nel silenzio e nella solitudine che ci si ritrova – si ritrova la
verità di se stessi – ed è attraverso a questa verità che si accede
a quella degli altri».
L’imparare
a stare da soli di fronte alla verità di se stessi è passaggio
obbligato per cogliere la bellezza e la gioia di un incontro.
Esercizio di
solitudine.
Vi
è un pagina di Niceforo il solitario, che può aiutarci in quel
raccoglimento nella preghiera che è premessa per incontrare Colui che
colma ogni solitudine. Evidentemente, come ogni metodo pratico, è una
sottolineatura non assolutizzabile, che può dare spunti utili come
esercizio per entrare in se stessi e nella propria interiorità.
«Mettiti
seduto, raccogli il tuo spirito e introducilo nelle narici: è il
cammino che l’aria segue per andare al cuore. Spingilo, forzalo a
discender nel cuore, insieme con l’aria inspirata. Quando vi sarà
giunto, vedrai la gioia erompere. Come uno che torna a casa dopo una
lunga assenza non sa frenare la gioia di aver ritrovato la moglie ed i
figli; così lo spirito quando si riunisce all’anima, è colmo di
gioia e di ineffabile allegrezza. A questo punto abituati a non far
uscire lo spirito con impazienza. Sulle prime ti sentirai smarrito in
questa vita di reclusione e di prigione; ma quando si sarà ambientato,
non avrà alcun desiderio di uscire di nuovo nelle consuete divagazioni.
Il regno dei cieli è dentro di noi. Chi volge nel suo intimo lo
sguardo, e con pura preghiera cerca di dimorarvi, considera le cose
esteriori prive di valore e di pregio.
Se
fin da principio riesci a discendere nel cuore, nel modo che ti ho
descritto, ringrazia Dio! A Lui dà gloria, esulta e sii fedele a questo
esercizio, ti manifesterà le cose che ignori. A questo punto hai
bisogno di un altro insegnamento: mentre il tuo desiderio dimora nel
cuore, non stare silenzioso, né ozioso, ma costantemente sii impegnato
a gridare: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di
me!”, e non ti stancare. Questa pratica, tenendo lontano il tuo
pensiero dalle divagazioni, lo rende invulnerabile e inattaccabile dalle
suggestioni del nemico.
Ma
se nonostante tutti gli sforzi, non riesci a entrare nel regno del
cuore, come ti ho indicato, fa’ quello che sto per dirti, e con
l’aiuto di Dio troverai ciò che stai cercando. Tu sai che nel petto
di ogni uomo c’è la facoltà dell’interiore dialogo. Quando le
nostre labbra sono silenziose, parliamo, desideriamo, preghiamo e
cantiamo. Introduci in essa l’invocazione “Signore Gesù, abbi pietà
di me”, e costringila a gridare queste parole dopo aver eliminato ogni
altro pensiero. Quando col tempo ti sarai impadronito di questa pratica,
ti aprirà la strada del cuore che ti ho descritto. Se persevererai in
questo esercizio con intenso desiderio e ardente attenzione, ti verrà
incontro il coro delle virtù: l’amore, la gioia, la pace e tutte le
altre. Per esse tutte le tue domande avranno la risposta in Gesù Cristo
Nostro Signore. Amen».
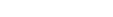 |