|
 |
 |
 |
 |
Alcune
chiarificazioni
Il delicato e
complesso rapporto fra spiritualità e psicologia, di cui abbiamo
parlato nel numero 1/gennaio 2002, non è però imputabile solo a
quest’ultima. Se è vero, infatti, che esiste una notevole confusione
per quanto riguarda la comprensione della dimensione psicologica, è
altrettanto vero che si verificano frequenti fraintendimenti per ciò
che concerne il significato da attribuire al termine spirituale.
Vogliamo qui metterne in evidenza soprattutto due, i più comuni ma
forse anche i più pericolosi.
Una
prima interpretazione errata, quella che incontriamo più sovente, tende
a far equivalere il termine spirituale
ad immateriale: spirituale, di conseguenza, sarebbe da riferirsi
unicamente a ciò che non riguarda la materia, il corpo, le pulsioni, il
desiderio, ma che concerne invece il pensiero, le aspirazioni, gli
ideali, la religione. Che tipo di persona immaginiamo, per esempio,
quando si parla di un uomo molto spirituale? Un uomo aitante, forte, vigoroso, pratico
oppure qualcuno di un po’ etereo, pio, poco concreto, disincarnato?
Citando S. Ireneo, il quale affermava che gli
uomini sono spirituali grazie alla partecipazione dello Spirito, ma non
grazie alla privazione ed eliminazione della
carne, M. Rupnik1 mette in risalto la pericolosità di
questa tendenza, che ha purtroppo trovato ampio spazio anche nella
Chiesa; basandosi su di essa e dimenticando l’insegnamento di tanti Padri, per secoli molti hanno invitato a occuparsi delle cose
del cielo e disinteressarsi di quelle della terra, intese appunto come
cose materiali.
Da
qui, come si può facilmente comprendere, deriva una sorta di dualismo,
che tende a separare e contrapporre dimensioni diverse della persona
umana. Secondo l’epoca in cui si vive, si tenderà a privilegiare ora
l’una ora l’altra, ma lo spirito e la materia rimarranno sempre due
realtà che si contrastano e oppongono, senza possibilità di
armonizzazione.
Questa
separazione e opposizione tra spirito e materia ha profondamente segnato
la vita spirituale e provocato effetti negativi nel cammino cristiano.
Come spiega Rupnik, vivere la fede è diventato poco per volta pensare
la fede, la morale si è sostituita all’esperienza e si è così perso
il gusto dell’essere cristiani. Sarebbe allora di conseguenza
legittimo domandarsi se l’attuale crisi, che la vita attiva sta
soffrendo e in cui spesso si riscontrano problemi ancora più rilevanti
rispetto a quanto si verifica nella vita contemplativa, non sia almeno
in parte da ascriversi a tale separazione.
Per
molti secoli la vita religiosa non ha conosciuto alcuna divisione tra
vita attiva e contemplativa, separazione che, tra l’altro, la Chiesa
Ortodossa tende a non attuare nemmeno ai nostri giorni. Al tempo dei
Padri, la vita attiva, o pratica, costituiva l’inizio dell’esperienza spirituale, che
comportava l’ascesi, la lotta contro i vizi e l’esercizio della virtù.
Solo dopo un lungo periodo di combattimento interiore, si poteva pensare
di essere giunti alla contemplazione, alla conoscenza di Dio.
Noi
invece distinguiamo con attivo
e contemplativo due modi diversi di mettersi alla sequela di Gesù; ciò
significa però che se implicitamente la nostra mentalità tende a far
coincidere attivo con materiale,
attenzione per le cose terrene, e contemplativo
con spirituale, preghiera, sguardo rivolto a
Dio, la vita attiva rischia di sperimentare una sorta di dualismo,
di separazione tra il tempo dato alla preghiera, allo “spirito” e
quello dedicato alle cose materiali, quali, in primo luogo, l’attività.
Questa falsa interpretazione del termine spirituale
è dunque un ambito su cui dovremmo maggiormente riflettere, perché da
esso possono derivare impostazioni sbagliate o confuse del nostro modo
di vivere.
Un
altro fraintendimento riguardo al termine spirituale
consiste nel considerarlo come una sorta di sovrastruttura,
che si aggiunge alla
dimensione fisiologica e psicologica dell’essere umano. Così, per
esempio, noi siamo abituati a considerare l’essere umano come qualcuno
che dopo la nascita vive prevalentemente a livello fisiologico e in cui,
poco per volta, si formano lentamente delle strutture psichiche, molto
più complesse rispetto a quelle di cui sono dotati gli animali, che lo
rendono sempre più umano. Questo significa che noi pensiamo la persona come una realtà
somatica, cui si aggiunge una dimensione psichica sulla quale,
eventualmente, se ne può giustapporre un’altra, quella spirituale. In questo caso lo spirito
appare come un di più, una
realtà non qualificante la persona, una dimensione che, qualora sia
presente, può forse renderla più generosa, più buona, più orientata
verso determinate attività quali la preghiera, la riflessione, la
contemplazione della natura, l’esperienza religiosa. Un di
più che però non appare indispensabile, di cui l’uomo può fare
a meno, perché la sua realtà psicosomatica gli è sufficiente per
sentirsi pienamente persona.
Questa
duplice confusione, che interpreta in modo errato il termine spirituale,
ha creato una profonda frattura non solo tra corpo e spirito, ma anche
tra psiche e spirito. Essi appaiono infatti come due realtà
profondamente separate, due mondi che non hanno nulla in comune e dove
il secondo può eventualmente intervenire per rendere tollerabile o dare
una parvenza socialmente accettabile al primo. Chi, per esempio, parla
della scelta celibataria come di una forma di sublimazione, spesso senza
rendersene conto, parte da un presupposto di tipo dualistico, dove la
dimensione sessuale presente nell’essere umano viene interpretata
unicamente in termini istintuali, di impulso che deve essere contenuto,
incanalato, attraverso un intervento della dimensione razionale,
spirituale, in grado di orientarlo e renderlo socialmente accettabile.
Nello
stesso modo una formazione di tipo moralista, che impone delle regole
preoccupandosi di farle osservare più che di favorire
l’interiorizzazione dei valori presentati, presuppone anch’essa
un’implicita visione dell’essere umano come un fascio di pulsioni,
di istinti, cui si sovrappone la norma, con il compito di contenere,
addomesticare ciò che dell’uomo è troppo passionale.
Se
ora proviamo a ricollegare quanto appena affermato a proposito dello
spirito, inteso come dicotomico e sovrapposto al biologico e allo
psicologico, con quanto abbiamo evidenziato in precedenza, in
particolare con la tendenza a interpretare lo psicologico come sinonimo
di conflittuale, possiamo renderci conto di come il rapporto tra queste
due dimensioni sia complesso e dei suoi effetti negativi in ambito
formativo.
Se
la psiche infatti diventa sinonimo di problematicità, area che si
contrappone allo spirituale e se quest’ultimo deve intervenire per
contenere o equilibrare il primo, ne consegue che il dualismo presente
in questa visione dell’essere umano si rifletterà anche
nell’impostazione del cammino formativo.
Si
prospetteranno allora due percorsi separati, dove il primo sarà
orientato a curare la persona, cercando di eliminare tutte le dimensioni
problematiche, e il secondo sarà invece diretto a presentare i valori
della vita religiosa, la preghiera, il significato della sequela, in
modo teorico, senza favorire un’esperienza e soprattutto tralasciando
la dimensione fondamentale, quella che possiamo considerare come la materia prima del cammino formativo, data dal vissuto concreto,
quotidiano. Ne conseguirà che lo psicologo, e non il maestro o la
maestra, diventerà il vero formatore, poiché l’attenzione prestata
alle dinamiche conflittuali lo metterà più direttamente e
costantemente in contatto con la vita del giovane, con le sue lotte
interiori, le fatiche, i sentimenti che accompagnano l’esperienza di
ogni giorno. Si favorirà però la crescita di una persona interiormente
divisa, di cui si può supporre la difficoltà a superare i momenti
difficili.
La
separazione fra psichico e spirituale impedirà a quest’ultimo di dare
un orientamento al primo e, nello stesso tempo, favorirà un processo di
disincarnazione.
Un
esempio ci aiuterà a meglio comprendere gli effetti deleteri di questa
pericolosa scissione. Pensiamo al caso, spesso frequente, della giovane
professa che, dopo gli anni di noviziato dedicati soprattutto alla
“crescita spirituale”, intesa come tempo da trascorrere in comunità,
frequentando corsi di approfondimento teologico e applicandosi
regolarmente alla vita di preghiera e alle altre pratiche contemplate
dalle Costituzioni dell’Istituto, all’inizio della sua attività in
parrocchia si innamora del seminarista che opera con lei in campo
pastorale o di qualche altro collaboratore. L’innamoramento, di cui
ella onestamente mette al corrente la Maestra, viene da quest’ultima
interpretato come un problema psicologico, un eccesso di dipendenza
affettiva finora mai manifestatasi, di competenza dello psicologo,
invitato a trovare una veloce soluzione a tale conflitto. Mentre lo
psicologo analizza, interpreta, risale alle origini, aiuta la presa di
coscienza di sentimenti profondi, la formatrice continua il suo percorso
orientando alla preghiera, all’impegno, alla fedeltà e messa in
pratica dei valori proposti nel periodo del noviziato.
Possiamo
ipotizzare alcune possibili soluzioni di questo problema?
Se
i due cammini continueranno ad essere paralleli, senza riuscire mai a
incontrarsi, la soluzione non potrà che coincidere con una perdita, più
o meno grave, per la stessa giovane che, in un modo o nell’altro dovrà
rinunciare a un aspetto importante della sua vita. Nel caso in cui sia
la dimensione psicologica a prevalere, ella si troverà a dover decidere
che cosa fare di un mondo ricco e significativo come quello relazionale,
di un amore umano capace di far risuonare le corde del suo cuore in modo
unico e finora mai udito, senza comprendere il possibile nesso fra
questa esperienza e la scelta di vita. Si troverà allora a decidere se
far prevalere i sentimenti, abbandonando la vita religiosa, oppure
contenerli, cercando costantemente una sorta di equilibrio fra
orientamento del cuore e vocazione. Al contrario, se fosse la dimensione
spirituale, nell’accezione riduttiva che in precedenza le abbiamo
attribuito, a prevalere, si tratterebbe di optare o per l’eliminazione
totale del sentimento, percepito come opposto rispetto alla scelta di
vita o per la sua spiritualizzazione, intesa in senso difensivo.
Non rimarrebbe
allora più alcuno spazio per la realtà concreta dell’amore, sempre
accompagnato da desideri, sentimenti, aspirazioni che, sebbene non
possano essere soddisfatti, rappresentano pur sempre una dimensione
ricca della persona umana, che può essere vissuta in modo egocentrico
ma anche orientata a Dio, perché l’altro è sempre colui che può
aprirGli una via nel cuore dell’uomo.
Quale
soluzione?
Per
ipotizzare una possibile relazione non problematica tra psicologia e
spiritualità è dunque necessario oltrepassare le false e scorrette
interpretazioni finora presentate. Se la prima, quella che tende ad
assimilare psicologia e psichiatria, è oggi sovente superata, le altre
confusioni permangono e non sempre facilitano il cammino formativo. Si
tratta allora di chiarire il rapporto fra psiche e spirito cercando di
evitare ogni dualismo e tendenza a opporli, ma anche ogni riduzionismo
che, come abbiamo messo in evidenza, tende a presentare l’essere umano
come un’entità psicosomatica, alla quale si può eventualmente
giustapporre una dimensione spirituale.
Un
aiuto per ricomporre tale dicotomia ci viene dalla psicologia evolutiva,
che studia lo sviluppo umano, i suoi dinamismi, le leggi che lo
regolano, i meccanismi che favoriscono la crescita o che tendono ad
arrestarla.
Uno
degli aspetti più interessanti di tale scienza è dato dalla possibilità
di individuare una sorta di lettura convergente da parte di studiosi
diversi che, pur analizzando ambiti differenti, quali quello cognitivo,
morale, affettivo, sono approdati a risultati pressoché identici. Uno
dei dati più rilevanti, e più utili per la riflessione che stiamo
affrontando, è dato dalla possibilità di cogliere un’armonia
all’interno del cammino di crescita, un’evoluzione non lasciata al
caso, ma ordinata, armonica, uno sviluppo indirizzato al superamento
dell’egocentrismo e dunque orientato alla trascendenza2. Gli studiosi
dello sviluppo si riferiscono, naturalmente ad una trascendenza che
comporta semplicemente il superamento di sé, nell’intelligenza, nella
moralità, nella relazione; non si parla di Dio, di valori cristiani.
I
dati che essi offrono, tuttavia, ci sembrano sufficienti per ipotizzare
che sia la dicotomia fra psicologico e spirituale, concepiti come
totalmente separati, sia l’abbinamento tra psicologico e patologico
sono privi di senso. Se lo sviluppo umano, infatti, implica il passaggio
dal soggettivismo al prospettivismo, come afferma il Piaget, il
superamento di una morale dei propri vantaggi verso un senso della
giustizia, come sostiene Kohlberg, la capacità di andare al di là del
narcisismo per incontrare l’altro in una relazione di vero amore, come
asserisce Kernberg, allora questo significa che già nella dimensione psicologica, così come nel corpo, esiste un
orientamento trascendente, che non induce a far equivalere
psicologico e spirituale, ma che permette di individuare nel primo le
premesse perché si effettui un’apertura verso il secondo.
La
psicologia evolutiva consente allora di distinguere livelli diversi,
evitando il rischio di equipararli o di fonderli. Essa aiuta inoltre a
vedere come, se è vero che essi possono opporsi, è altrettanto vero
che possono incontrarsi e dinamizzarsi reciprocamente. Se nello
psicologico, infatti, possiamo cogliere non solo il conflitto,
l’opposizione ai valori, il ripiegamento su di sé, ma anche
l’apertura alla trascendenza, la dimensione spirituale non diventa più
l’arma per combattere e contenere un’affettività percepita come
nemica, ma non diviene neppure l’ambito che non ha nulla a che vedere
con il nostro mondo intrapsichico fatto di desideri, bisogni,
sentimenti. Essa appare invece, secondo l’affermazione di Edvokimov,
non come la terza sfera, ma il
principio di qualificazione che si esprime attraverso lo psichico e il
carnale e li rende spirituali3.
Quale cammino formativo
Il cammino
formativo, allora, invece di essere concepito come una crescita
parallela di differenti aspetti della persona, talvolta rigidamente
separati l’uno dall’altro e affidati a figure diverse di formatore,
può essere configurato come una progressiva trasformazione interiore,
un processo di integrazione o, se vogliamo usare le parole di Paolo, un
percorso orientato in modo tale da permettere che, poco per volta, tutto
ciò che è mortale venga assorbito dalla vita (2Cor 5,4). Tutto
ciò che è mortale: di
conseguenza tutto ciò che, ad ogni livello della nostra esperienza, è
segnato dal peccato, dall’egoismo, dal narcisismo che concentra la
persona su se stessa, la convince a trattenere la propria vita invece di
perderla per il Signore, la invita a cercare la soddisfazione, fisica,
psicologica, intellettuale e a chiudersi agli altri, a Dio.
Teresa
d’Avila, nel suo Castello
interiore4, ha una bella immagine che ci aiuta a
descrivere tale percorso e, ancora una volta, ci fa capire come la
dimensione spirituale non è una sovrastruttura che si aggiunge al resto
della nostra umanità per orientarla eventualmente verso Dio, ma è la
dimensione più intima e nello stesso tempo reale del nostro essere, il
luogo più profondo della nostra interiorità, dove siamo da Lui
inabitati. Egli, secondo S. Teresa, come un Sole sta nel centro
dell’anima e illumina tutte le stanze; ma a causa del peccato la sua
luce può rimanere oscurata, come avviene per un cristallo trasparente
quando è avvolto in un panno nero. Perché allora non pensare che,
oltre al peccato inteso in senso stretto, altri impedimenti possano
bloccare l’irradiarsi di quel Sole in tutto il nostro essere?
La
presenza della Trinità nel fondo dell’anima desidera illuminare ogni
piega della nostra persona, ogni aspetto di ciò che noi siamo, ma ne è
impedita da tutti quegli elementi che, nel nostro corpo e nella psiche
la orientano verso qualcosa che non è Dio. I meccanismi di difesa, per
esempio, sembrano indirizzare ognuno di noi verso l’autoprotezione, il
nascondimento del limite, la negazione della fragilità, invece di
aprirci al dono, all’incontro, all’accoglienza dell’altro.
Anch’essi possono essere assimilati a quel panno scuro, di cui parla
S. Teresa, che impedisce al Sole di irradiare la sua luce anche negli
angoli più remoti della nostra persona. Il corporeo, lo psicologico,
allora, non appaiono più come contrari allo spirituale; essi rivelano
invece la loro ambivalenza, perché possono essere oggetto di un duplice
orientamento: verso l’Io, con la sua debolezza, il bisogno di
proteggersi, di preservarsi, o verso il superamento di sé,
l’accoglienza e il dono.
In
quest’ottica, il percorso formativo si configura allora come un
cammino di liberazione: non si tratta di costringere una natura che si
oppone e di orientarla verso uno spirituale che le è contrario, ma di
permettere a ciò che ci abita più profondamene, più intimamente, di
farsi spazio, di illuminare, di dare il giusto orientamento. Tutto in
noi è infatti abitato dallo Spirito e può essere verso di Lui
indirizzato. Non è questione, quindi, di combattere per togliere,
eliminare il corporeo e lo psicologico, ma di fare in modo che essi
possano trovare la loro giusta direzione, non nell’autogratificazione,
ma nel superamento di sé per qualcosa di significativo, di valido, per
un ideale che va al di là di noi stessi e che, nel caso di chi ha
scelto la vita religiosa, non può essere altro che Dio. Questo ci
permetterà di guardare al nostro corpo, alla psiche, in modo diverso:
non sono essi a costituire un ostacolo in se stessi, perché tutto in
noi è buono, è stato pensato come cosa
molto buona (Gen 1,31), ma è
il modo in cui noi ci poniamo in rapporto ad essi, difendendoci,
nascondendoci, o aprendoci all’appello di Dio, che possiamo cogliere
presente in ogni ambito della nostra persona, ciò che blocca il
cammino.
Più
riusciamo a superare le nostre letture difensive ed egocentriche e più
tutto può essere orientato a Lui o, se vogliamo ancora utilizzare
l’immagine di Teresa d’Avila in precedenza citata, tutto può essere
da Lui illuminato, anche il limite, la debolezza, la fragilità.
Un
esempio ci aiuterà a meglio comprendere la profonda differenza fra
questi due diverse concezioni della persona. Pensiamo al bisogno di
dipendenza affettiva, che porta l’essere umano a cercare l’appoggio,
il sostegno, l’aiuto di un’altra persona. Tale bisogno ha in sé una
profonda ambivalenza: da una parte è necessario alla vita
dell’individuo tanto quanto l’acqua e il cibo, poiché, senza di
esso saremmo degli esseri asociali, incapaci di accogliere l’affetto
degli altri e di vivere con loro. Nello stesso tempo però può impedire
lo sviluppo di una sana autonomia, spingere ad una ricerca compulsiva,
continua, dell’affetto e del sostegno altrui e impedire la fedeltà ai
valori della vita consacrata, in primo luogo della castità. Ciò
significa, allora, che tale bisogno deve essere eliminato, perché la
persona possa lasciare spazio a Dio e legarsi solo a Lui?
Questo
è quanto implicitamente afferma una concezione che tende a vivere in
modo dicotomico il rapporto fra spirituale e psicologico e pensa che
solo rimuovendo il secondo si possa lasciare spazio al primo. Il rischio
però è quello di creare squilibri, forzature ed eccessi: la persona
finisce per spaventarsi di fronte alla propria umanità, non la
riconosce e se ne difende. Spesso, per esempio, chi combatte contro la
dipendenza affettiva, perché teme che sia in contrasto con la sua
scelta celibataria, rischia di essere eccessivamente autonomo, tende a
scappare di fronte ad ogni relazione personale ed è incapace di vivere
affetti profondi.
Il
bisogno, riconosciuto dentro di sé, non deve quindi essere eliminato,
ma illuminato dalla luce dello
Spirito; solo così lo si potrà vivere in modo armonico. Ciò significa
che poco per volta la persona riuscirà a trovare un giusto equilibrio,
ad esprimersi in una relazione profonda come capacità di accogliere
l’altro senza bisogno di attaccarsi e trattenerlo per sé. Potrà
inoltre trasformare il bisogno in desiderio per Dio e conferire spessore
alla relazione intima con Gesù; infine esso si convertirà anche in
sacrificio, offerta, fatica sopportata per amore del Signore, in
rinuncia pesante e gioiosa nello stesso tempo di questa dimensione del
nostro essere che, spontaneamente, ci indurrebbe a cercare amore per noi
stessi e a cui si rinuncia per mantenere libero il cuore in modo da
poterlo offrire a Dio e ai fratelli.
L’esempio
citato in precedenza, quello della giovane professa che, alla sua prima
esperienza pastorale, s’innamora del seminarista, può ora esserci
utile per capire come queste due dimensioni possano dinamizzarsi
reciprocamente, in una sinergia capace di favorire una crescita che
comporti contemporaneamente un
aumento di umanità e un maggior orientamento verso Dio. Supponiamo
allora che, invece di essere inviata dallo psicologo, la giovane
professa trovi nella propria formatrice, o in un’altra persona con cui
la maestra collabora, qualcuno capace di aiutarla a compiere un cammino
che tocca diversi ambiti della sua vita, li integra e li orienta al fine
verso cui la persona ha deciso di indirizzare la sua vita: la sequela di
Cristo, la comunione con Lui. L’esperienza d’innamoramento diventerà
allora, per la giovane religiosa, occasione di conoscere il profondo
bisogno di essere amata, il desiderio sessuale spesso accompagnato da
forti sensazioni e altrettanto intensi timori, le trepidazioni e le
insicurezze che nascono dalla paura di non piacere, di non essere
attraente e tutte le resistenze di fronte ad una scelta di vita che non
porta all’appagamento di queste dimensioni della persona.
Il
cammino di conoscenza di sé le permetterà anche di prendere coscienza
dell’inesprimibile bellezza del suo desiderio, le farà conoscere
l’amore di apprezzamento, capace di contemplare l’altro senza
goderne, farà sgorgare dal suo cuore sentimenti di gratitudine per la
gioia di aver potuto conoscere tutta la bellezza interiore di una
creatura, la renderà capace di comprendere più da vicino le ansie e le
consolazioni dei giovani cui vuole dedicare la sua vita. Il fatto di
scoprire questa nuova bellezza non la costringerà a fermarsi solo su di
essa, come se unicamente lì fosse possibile trovare la propria vera
realizzazione. L’esperienza spirituale allora non dovrà essere
vissuta come qualcosa accanto
a ciò che la giovane sta sperimentando, ma dovrà penetrare nel cuore
dell’esperienza stessa, per interpretarla, valutarla, confrontarla, illuminarla
in base alla scelta di vita.
La
persona di Gesù dovrà essere posta di fronte allo sguardo della
giovane, la Sua Parola, la Sua Vita e, attraverso questo confronto, sarà
favorita una maggiore assunzione di responsabilità, un approfondimento
delle motivazioni iniziali e in modo particolare del rapporto con Lui,
percepito sempre più come unico
bene.
Questi
risultati non sono certamente garantiti: di fronte al fascino di un
amore umano, si è pur sempre liberi di abbandonare la scelta iniziale;
non è però reprimendo i sentimenti, eliminandoli dalla coscienza, che
si può essere certi di favorire la fedeltà. Questo metodo, al
contrario, tende semplicemente a dilazionare decisioni che prima o poi
la persona finirà per assumere e che avrebbe potuto fare all’inizio
della vita religiosa, prima di un impegno definitivo di consacrazione.
Come
si può facilmente intuire, una formazione di questo tipo richiede che
la dimensione spirituale sia correttamente interpretata e messa al primo
posto e, come abbiamo ripetutamente affermato, sia superata ogni sorta
di separazione e dicotomia fra psicologico e spirituale.
In
altri termini, essa necessita di una sana antropologia. Una corretta
visione della persona umana non è però sufficiente: elemento
fondamentale infatti è la figura del formatore, il quale, più che un
esperto in qualche disciplina deve essere un testimone, capace di una
profonda conoscenza del cuore umano ed esemplare nel vivere la sequela;
egli deve aver già lasciato spazio allo Spirito dentro di sé, affinché
illumini ogni angolo oscuro della sua interiorità, deve essere qualcuno
che, come scrive Gabriel Bunge, citando Matta el Meskin, non
tenterà mai di chiamare il discepolo alla propria sequela, perché noi
tutti siamo discepoli di Cristo… Neppure lo accompagnerà stando a
fianco, perché egli è solo un uomo e non un angelo. Lo segue,
piuttosto, umilmente, come un servo, per essere di aiuto, se occorre, a
colui che, come lui spinto dallo Spirito, segue le orme di Cristo5.
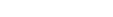 |