|
 |
 |
 |
 |
“Chiamate
a essere testimoni del primato di Dio,
segno profetico della santità” (Cf NMI, 32)
Santità: tema
quanto mai intenso e delicato che può essere interpretato nei modi più
disparati e quasi equivoci, ma che, nel suo significato più alto,
coinvolge tutta la nostra vita. Alla santità siamo chiamati dal nostro
apparire nel mondo e, forse, già da piccoli abbiamo compiuto degli atti
di santità, ci siamo sentiti amati da Dio e abbiamo corrisposto a tale
amore nel modo allora più puro. Anche per noi può essere stata detta
la parola di Gesù: «Lasciate che i piccoli vengano a me, non glielo
impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio» (Lc
18,16).
Santi siamo diventati
con il battesimo, con i sacramenti ricevuti nelle varie tappe della vita
e cresciuti con noi.
Ora però parliamo di
santità non come sacramentalità, ma come stato di grazia, stato di
cari a Dio, come itinerario di vita nella grazia, come pedagogia
esistenziale, come conversione e cammino verso un fine, che per noi è
pregno di luce, di amore, di gusto della misericordia e della
benevolenza di Dio, in comunione con tutti i fratelli e sorelle.
E’
la santità adulta…
quella che conosce
anche la lotta fra la carne e lo spirito, che ha forti aspirazioni,
contrastate dal male: «…infatti non quello che voglio io faccio, ma
quello che detesto….io non compio il bene che voglio, ma il male che
non voglio» (Rm 7,15-20).
Se il fine è la
immedesimazione con Cristo, la strada deve essere percorsa con quegli
atteggiamenti, con quei modi di vita che sono tipici del Verbo
Incarnato. La configurazione al Figlio e al Fratello primogenito, venuto
tra noi, incarnato nella nostra terra, prende i sentimenti del Servo di
un progetto di salvezza per tutto il genere umano (cf Fil 2); sono perciò
anche i nostri sentimenti nel limite esistenziale e del tempo, ma che
avremo un giorno in assoluto.
Nell’Apocalisse (7,9)
si parla della schiera dei santi vestiti di una veste bianca, la veste
della risurrezione dopo un martirio, con un nome nuovo scritto sulla
fronte, nome che Dio conosce, con il quale Egli li chiama ed è
l’attributo che Egli dà anche a ciascuno di noi, l’espressione
della parte in cui assomigliamo a Lui.
Nell’Apocalisse si
parla ancora di persone che hanno vinto (Ap 21,7), che hanno sostenuto
una battaglia nel loro essere di uomini e di donne. Hanno sostenuto con
valore, con virtù, la lotta per essere autentici, coerenti uomini e
donne, capaci di donare anche la vita: portano infatti una palma nelle
mani e cantano un cantico mai udito. Seguono l’Agnello, caricato del
peccato dell’uomo (Is 53,3), colpevolizzato (Lev 5,15), assassinato e
reso vittima che liberamente ha scontato su di sé la libertà
dell’uomo di compiere il male (Mt 27,11…)
Ma ci facciamo ora una
domanda: chi sono i santi nella maniera più semplice, quotidiana?
Quando noi vogliamo
dire bene di una persona, diciamo: “E’ tanto umana!”. Per cui la
santità è autentica umanità, è vivere secondo quel progetto di amore
per il quale siamo stati creati.
Un tempo abbiamo
imparato l’alfabeto del sacrificio in se stesso, della rinuncia, del
lavoro assiduo, dell’attendere solo a noi stessi, del rinnegare la
nostra persona, dell’umiliarci fino quasi a perdere la nostra dignità,
del lavoro perché l’Istituto avesse un nome, un seguito, un
prestigio. Abbiamo anche tanto esaltato la bravura, il saper fare tante
cose.
Oggi questo linguaggio
non è più “segno” profetico, non è evocativo di santità. La
pedagogia della santità parla oggi di lode del fratello, di
ringraziamento per quanto abbiamo ricevuto, di ascolto, di benevolenza,
di magnanimità anche se nell’altro non è tutto perfetto, di
riconoscimento dei doni che possediamo e che hanno i nostri fratelli e
sorelle, di accoglienza, di perdono, di desiderio di essere perdonati,
di saper perdere del tempo per consolare, di voglia di comunicare, di
stare insieme, di sottolineare i doni degli altri ed anche nostri.
E’ rendere vera la
affermazione di Gesù: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mc 8,34). E’ perciò la
negazione del primato di un “io” che si appella
all’autocompiacimento e affermazione per l’ampia e libera apertura a
tutto ciò che profuma di comunione, di sguardo buono, sincero, gioioso
verso l’altro. E’ riconoscere, infine, che la nostra vita appartiene
a Dio, è solo sua e non nostra, è vivere nella felicità dell’amore
che si concretizza in queste parole della I Lettera di Giovanni: «Noi
sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i
fratelli» (3,14).
Così si diventa
“segno” della Presenza di Dio. Che tutti possano dire: «Di qui è
passata una Suora che ama». Le nostre azioni non sono allora
all’insegna del prestigio, ma del “segno” umano e divino nello
stesso tempo.
Così vuol dire essere
vincitori sull’egoismo, sul protagonismo e ricevere la veste bianca
dell’alba della risurrezione, facendo risorgere pure gli altri,
annunciando la risurrezione con la nostra gioia, la nostra comprensione
e aiuto.
Santità vuol dire
compiere azioni che lasciano un “segno” anche come comunità.
In un mondo chiuso
nell’individualismo, il saper vivere in comunità, con attenzioni
reciproche come in una famiglia, è una grande testimonianza di quella
realtà che ci fa star bene.
Vivere in fraternità
non vuol dire però fare finta che i problemi non esistano: occorre la
trasparenza libera e comunicare come si superano e risolvono tali
problemi, quali strategie psicologiche, spirituali, di fede, si mettono
in esecuzione, dicendo come ci si perdona, come si comprende e si
giustifica, come, nella libertà, non si cade nel “giudizio”: «Non
giudicate e non sarete giudicati» (Mt 7,1). Dio allora è al centro
della vita.
Nella comunità deve
circolare quell’amore trinitario che è parità, reciprocità,
attenzione alla persona. La santità è una chiamata per tutti i
battezzati, è vita di grazia, è essere cari a Dio e perciò
carismatici nel nostro pensare e operare. I consigli evangelici sono per
tutti, di per sé non dovrebbero essere “voti”, ma sequela radicale,
amorosa della Persona di Cristo:
-
nella povertà, che
è sobrietà di vita, non lamento, ma condivisione di ciò che
abbiamo, avendo anche meno perché altri abbiano di più; è
essenzialità, perché a noi basta Cristo e la manna di ogni giorno,
frutto dell’onesto lavoro, della Provvidenza da vivere con altri
fratelli e sorelle,
-
nella castità, che
è celibato vissuto nella sponsalità d’amore con Cristo che ci offre, nella tenerezza, tutti i
suoi redenti da amare di più, da aiutare, a cui esprimere
l’affetto dilatando il cuore, da ascoltare in profondità, con
sensi di compassione specialmente verso i più poveri,
-
nell’obbedienza
reciproca, fraterna. Dio si manifesta per noi nella comunità, ove
c’è una sorella coordinatrice che assieme alle sorelle obbedisce
alla Volontà del Padre, cammina come una discepola e, in questo
atteggiamento, esprime il suo parere, oggetto della nostra
obbedienza, cercata insieme.
Santo
vuol dire anche separato…
…ma da che cosa?
Dalla mentalità del
mondo che cerca il piacere, il potere, il dominio, i mali nominati da S.
Paolo in Galati 5. Nella relazione tenuta in occasione del “grande
digiuno” del 14 dicembre u.s. P. Cantalamessa si riferiva a delle
astinenze personalizzate, quelle che non escludono le comunitarie, ma
sono non viste, compiute nel «segreto della camera, profumandoci pure
il capo» (cf Mt 6,8-17). Sono quelle della parola che ricusa ogni
espressione che ferisce il fratello per rivolgergli quella che lo aiuta
e a darsi un senso nella vita; quelle del pensiero, ancora più
difficili.
Riflettiamo infatti un
attimo: da quali pensieri siamo attraversati nella nostra giornata? E
abbiamo subito una misura di ciò che sta dentro di noi, di ciò che ci
occupa, delle idee che si traducono quindi in atteggiamenti di vita.
Non minore attenzione
deve essere data alle immagini che facciamo entrare attraverso i nostri
occhi, con tempi dati a riviste, a internet e alla TV. P. Cantalamessa,
riferendosi alla famosa frase di Feuerbach «l’uomo è ciò che
mangia”», adattava alla contemporaneità questa affermazione dicendo:
“L’uomo è ciò che guarda”.
Cristo
è il Santo…
il vero separato dalla
mentalità del mondo e, nello stesso tempo, è incarnato totalmente
nella realtà dell’uomo. La santità diventa allora incarnazione in
questa terra da amare, da condurre, da perdonare, da aiutare a liberarsi
dall’indifferenza alle cose vere, dalla schiavitù del male. E’
saper stare accanto all’uomo, alla donna di oggi nei loro problemi di
famiglia, nelle indecisioni, nelle disperazioni delle separazioni, dei
tradimenti, nella solitudine più amara dell’anziano, della ragazza
ingannata e sfruttata, nella paura del bimbo che non sa che cosa gli
serbi il futuro.
Siamo chiamate a essere
sorelle sante di questa umanità, sorelle che sanno parlare con la voce
di Cristo, benedire con le mani di Cristo, perdonare con il cuore di
Cristo.
Ma per arrivare a
questa interiorità occorre fermarsi con Lui, in una parola, occorre
pregare.
Come i discepoli
chiediamogli: «Maestro, insegnaci a pregare». Egli forse ci ripeterà
il “Padre nostro” (cf Lc 11,2-4), preghiera completa, difficile da
vivere, da capire in tutta la sua portata e, tuttavia, ricca di pace e
di fiducia. Forse ci insegnerà una preghiera tutta personale, secondo
le nostre inclinazioni, indole e bisogni.
Gesù ci farà vedere
come e quando Egli ha pregato, perché Egli pregava sempre: i salmi
erano sulle sue labbra in ogni circostanza, ritmavano il mattino con le
sue aurore, il pieno meriggio, la sera silente, la notte fonda…
l’ora della passione.
Le ore preferite da Gesù
erano appunto quelle della sera, della notte, quando il silenzio delle
cose, degli uomini, degli stessi servizi da compiere, erano nella
quiete.
Il giardino degli ulivi
era una meta consueta di Gesù (e Giuda lo sapeva!)
Spesso diceva ai
“suoi” di staccare la barca dalla riva e di andare “al largo”,
in piena libertà da tutto, circondati dall’acqua non solcata da
altri, non avendo timore di non essere in quel momento a servizio degli
altri. E lì Gesù pregava con gli Apostoli, i chiamati.
Risentiamo qualche
invocazione di preghiera di Gesù, perché è solo da Lui che impariamo
l’arte di pregare:
“Ti ringrazio, Padre,
perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai
rivelate ai piccoli…perché così ti è piaciuto” (Lc 10,21).
«Ti ringrazio, Padre,
perché mi hai esaudito….» (Gv 11,41).
Lo sentiamo in modo
particolare nell’ultima Cena, nella sua grande preghiera:
«Padre, conservali
nella verità, che siano uno, come tu, Padre e io siamo una cosa sola»
(Gv 17…).
«Non chiedo che tu li
tolga dal mondo, ma di custodirli dal maligno» (Gv 17,15).
Preghiera profonda,
intima, solo con i “suoi”, nell’ora del tradimento e della
consegna nelle mani degli uomini e del Padre.
Quindi
nel Getsemani:
-
nell’ora
dell’accettazione della libertà dell’uomo che lo portava a
morire;
-
nell’ora del
silenzio del Padre, della solitudine, del peso di tutto il male;
-
nell’ora del “sì”
al realizzarsi del progetto di salvezza, proprio in quel terribile
modo;
-
nell’ora in cui
altri dormono mentre Egli cerca sollievo e si ritrova ancora con il
silenzio del Padre, il quale manda un Angelo a consolarlo
nell’intensità del dolore, della preghiera per l’umanità.
Egli è profondamente
Uomo e Dio in questo momento: nel suo modo di soffrire, nell’essere
tentato a lasciar cadere “quel progetto”, infine nell’accettazione
piena della Volontà del Padre di salvare l’umanità in Lui.
Sulla
Croce:
«Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).
«Ho sete» (Gv 19,28).
«Dio mio, perché mi
hai abbandonato?» (Mt 27,46).
«Padre, nelle tue mani
affido il mio spirito» (Lc 23,46).
«Consummatum est» (Gv
19,46).
Sono tutti momenti
vissuti anche da noi e sui quali pregare.
La croce ci raggiungerà
senz’altro nella nostra vita: la croce è il segno di chi è chiamato:
«Quanto a bere il calice, anche voi lo berrete» (Mt 20,23).
In quella chiamata alla
piena maturità in Cristo, la persona dice a Dio parole inedite che
potranno avere tutto il marchio della carne che si ribella, ma infine
chiede a Lui di amare dentro di sé. Noi non siamo capaci, non
riusciremo mai, senza la sua grazia, la sua vita in noi, a dire a chi ci
ha offeso, riferendoci alle parole di Gesù in Croce:
“Oggi ti darò
gioia” – “Padre, perdona mio fratello, mia sorella, e tu, fratello
e sorella, perdona me” – “Il mio destino lo affido tutto alle tue
mani, o Padre!” – “Prendimi come sono, non ho nient’altro da
offrirti, sono figlia di questo tempo, sono assetata di libertà e di
verità, ma sbaglio nel perseguirle”.
Come il Pellegrino
russo ci sarà cara una litania, lungo tutta la giornata: “Miserere
mei… abbi di me pietà… oggi voglio essere libera di amare”.
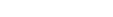 |